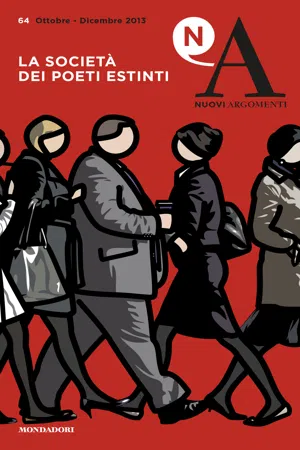![]()
SCRITTURE
![]()
LA PERDITA
di Franco Sepe
Trovarsi davanti a quel minuscolo ganglio sospeso nel grigio sfumato delle pareti uterine, non suscitava in lei nessuna sorpresa. Era già da un po’ che lo avvertiva dentro, ma ora che il medico glielo additava sullo schermo con il sorriso dell’uomo di scienza persuaso del prodigio non meno che dell’abilità a mettervi mano, preferiva rivolgere la testa verso la calma luce filtrata dalla finestra, lasciando che dall’altra parte del lettino continuassero a giungere fioche le contrazioni amplificate che un istante prima sul monitor verde si erano illuminate in frequenze.
Aveva provato a ragionare sull’artificio che si serve di un segnale scontato e banale per sollecitare emozioni tanto estreme – in quella posizione di abbandono erano giaciuti corpi che al medesimo suono avevano reagito con un brivido di gioia, con la secrezione di una lacrima, o con un discreto ma fiero inumidirsi degli occhi. Lei invece avrebbe voluto solo piangere, urlare al medico e ai suoi assistenti di smetterla con le prediche, con i discorsi volti a farla ravvedere, tanto la decisione, per quanto amara, era stata ormai presa; e di far presto con l’anestesia, anziché starsene lì a cercare nei suoi occhi un’ombra di cinismo, o quell’assenza di pietà della donna sopraffatta da una maternità insinuatasi in un ventre contrario a riceverla, ad assecondarla.
Davanti al suo ostinato silenzio riecheggiavano impotenti le parole del ginecologo: «È per essere sicuri che non vi siano in corso ripensamenti. Una regola a cui siamo tenuti».
Poi lei aveva abbassato del tutto le palpebre, escluse dalla luce che le cadeva dritta tra le gambe aperte e penzolanti nell’aria. Solo un tintinnio, uno sferragliare leggero di strumenti passati di mano in mano la tenevano ancora vincolata a quel luogo. La sua mente aveva cominciato a sdilinquirsi, i pensieri si impennavano e ricadevano nel vuoto, subivano orbite affannose, oscillazioni estreme, apnee. Le mani soltanto sfuggivano al gelo che si stava impossessando di lei. Le sue mani, che ora immaginava chiuse fra quelle di Livio sempre pronte a calmarle, a riscaldargliele in una stretta dolce. Quelle mani di lui così poco maschili, che per pudore si erano sempre arrestate sulla soglia dei vestiti, anche nei momenti in cui il suo corpo aveva reclamato in silenzio quel contatto. Così era stato quell’ultima volta, allorché si era decisa ad andare da lui per dirgli dello scoramento, del disprezzo che provava verso se stessa, di tutto quel carico di colpa. Una colpa che di fatto la riguardava solo a metà, ma di cui Livio, l’amico vero, l’amico del cuore, non aveva indugiato a dire che se ne sarebbe accollata volentieri l’altra parte, quasi fosse stato lui ad averla messa in quelle condizioni.
Se era corsa da lui quel pomeriggio, non era stato per lamentarsi ancora dei suoi amori, che non avevano mai buon esito; bensì, standogli semplicemente accanto, per riprendersi dalle parole inopportune di Fred, che dall’altro capo del filo erano riuscite ad accrescere ancora di più il suo tormento. Per riferirgli del paragone meschino col tumore benigno: come se a una donna fosse di qualche consolazione pensare al suo dramma come a un neo da estirpare.
Livio l’aveva tenuta tutto il tempo fra le braccia, laconico come sempre le aveva offerto la spalla a far da cuscino, mentre l’ascoltava. Poi, a un certo punto, aveva detto: «Una donna può sentire in assoluto di volere un figlio. Un uomo invece prova quel sentimento solo quando è convinto di aver trovato la compagna giusta. Per questo sono tanti gli uomini che nella donna già fiutano una madre e la rifuggono». E subito dopo, schernendosi, si era chiesto con voce sommessa se anche lui, di fronte a una decisione tanto seria, non si sarebbe comportato proprio come quelli.
Ma lei sapeva bene che Livio non era così come avrebbe voluto far credere, che una tenerezza infinita si nascondeva dietro la sua amabile menzogna, dietro quel nobile sentire a cui non pareva legittimo dare voce. Perché ciascuno dei due aveva finito col convincersi che mai le loro vite si sarebbero saldate in una sola, essendo stati – per un’atroce beffa – sempre altri i legami a dominare, a ostacolare quel loro occulto desiderio di unirsi in un destino comune.
«È bello anche così», diceva Livio. Ma lei avvertiva la ferita dietro le sue parole, la sentiva fremere di dolore come la propria. Persino quel pomeriggio, con tutta la lacerazione che si portava dentro, lei avrebbe desiderato che le loro bocche diventassero una sola, uno il respiro. Ma Livio appena le aveva sfiorato le labbra, accorto più che mai: per non oltraggiare il suo stato, per non accrescerne l’umiliazione. A ripensarci la cosa appariva ora quasi ridicola, perché il suo era da sempre un modo di baciare tutt’altro che avido (un bacio che neppure sembrava venire da un uomo). Quasi che, una volta raggiunto il destinatario, con quel bacio, per una qualche oscura ragione, Livio non osasse oltrepassare la soglia delle convenienze. Lei, scherzando, glielo aveva fatto persino rilevare; ma se ne era subito pentita. Livio, che non era solito andare a cercare riparo in una scusa, perché ogni scusa avrebbe solo rammentato a lei la propria appartenenza a un’altra, aveva semplicemente risposto: «A volte la bocca non arriva a baciare dove arriva il cuore». E in fondo lei gli aveva creduto, per il modo sincero con cui aveva pronunciato quelle parole. Ma non più di tanto. Perché le belle parole dell’amore non sono la stessa cosa che amare e vivere per esso.
Negli ultimi tempi si erano incontrati di rado, lasciando all’immaginazione ogni ulteriore passo. Proprio come quel bambino, lasciato pure lui all’immaginazione, che un giorno, forse, si sarebbe ripresentato sotto altre sembianze, ma che intanto era sparito nel nulla – e presto, magari, anche il padre lo avrebbe imitato.
L’infermiera le aveva riunito dolcemente le gambe, che le dolevano nella piega del ginocchio, prima di aiutarla a trasferirsi sulla lettiga. Nell’attraversare la corsia era rimasta a occhi chiusi, sentendosi osservata dagli altri malati. L’aspettavano adesso tre giorni di completo letargo, prima di far ritorno alla vita di sempre. Prima di andare a scrutare la verità – forse per l’ultima volta – negli occhi di Fred. Prima di votarsi nuovamente (o solo nel ricordo?) alla tenerezza di Livio.
![]()
IL NOSTRO TEMPO
di Giovanni Bracco
Cinquant’anni
Eccomi ai cinquant’anni. Ho una bolla
sul pollice sinistro,
quella puttana della bistecchiera.
Scottature, le metto nel bilancio.
Però voglio pensare ancora agli alberi
da frutto da piantare nel giardino.
La goccia
Abbiamo il nostro tempo, quale ha
la goccia sulla punta della foglia.
In margine a Keats
Vorrei che mi dicessi: «Non è tardi
per sentirmi cantare».
La morte è un luogo poco confortevole.
Riflessi
Le nostre facce si sono indurite.
Frugare nella tua tiepida nuca
per indurti a un sospiro, una smorfietta.
Femmina
Tornavamo. Era un viaggio sospeso
nella luce del tardo pomeriggio
rossa sulle colline di Tuscania
rossa come una casa cantoniera.
Rosso il tuo naso dopo una giornata
al mare, benché tiepido novembre.
Addossata al casotto di legname
con le gambe distese sul cemento
ti eri fatta guardare fino al punto
in cui cede la vanità al dispetto
e hai nascosto il tuo seno con orgoglio.
***
Ogni sera in cucina da sola
l’anziana signora
consuma tutta la sua trasgressione
tirando un sigaretto dal bocchino
con la lentezza controllata e gli occhi
semichiusi.
In attesa
che dal muro di fianco
si levi sopra il ritmo ossessivo
di una musica africana il grido
della bella avvocatessa in calore.
Alla cara memoria di Vincenzo Curcio
Quella malinconia che ci ha fregati
ti accompagnava pure nel sorriso.
Lasciava al fondo di ogni nostro incontro
come un grumo di zucchero rappreso.
Piazza Duomo
Strozzato, pende come da un patibolo
quel che resta di un palloncino rosa
dal tubo teso in cima al porticato.
Sotto l’arcata il vento
gonfia la vela gialla
di un’insegna imbrattata dai piccioni.
Sui cartelloni l’allegria ciarliera
delle vendite a sconto.
Ma so di un campo che la rende vera
all’impianto di un melo.
***
Una piuma sintetica
si è venuta a posare
su un brandello di sedia di legno
appoggiata al balcone.
Un’altra piuma vibra
dentro una ragnatela
distesa tra le maglie dell’antenna.
In fondo la differenza è questa,
rimanere impigliati o posarsi.
![]()
VERSO I SETTE ANNI
PRIMO MESE
di Vittorino Curci
il penoso ritmare dei secoli
negli avvistamenti dell’ultima ora
quando ai camminatori affrancati
dalle mappe non resta
che l’assillo di un’attesa
l’uomo di spalle, che potrei
essere io, suppone
che la terra non sporchi.
nel sacrario delle sue disfatte
un fruscio di flanella
e neve che sbarra le porte
mio raggio di luce, sul solco
scavato dal bene e dall’essere
l’amore è scomparso.
se ritorna
lo fa in segreto nei sogni
nel dileggio di un inverno spavaldo
negli atti apocrifi
del sottoscala al civico 57
dove, sul piatto muto della
bilancia, resistono al tempo
le fascine per la caldaia
una paletta di ferro, un pallone
un grembiule spiegazzato
verso i sette anni
anch’io volevo un cane
giovedì 2
paradisi in fuga dal cemento.
il libero sfogo dei giardini
che tornano al passato.
il mare traduce l’alga in verde fibra
che ondeggia nei boschi
ma non per questo gli uomini
sono più docili
il cinegiornale i passeggeri
mostra con una gamba sola
e poi un piccolo italiano
che saluta. la strada che si trova
è quella che si perde, mi hai detto.
ci ho pensato tutto il giorno
mentre l’acqua stringeva
il telaio delle sue premure
primo ottobre nel cortile della scuola.
collane di bambini intrecciano
trame di vendetta.
il mesto giro delle stagioni affianca
la crudeltà dei sigilli.
i nomi potrebbero tornarmi
venerdì 3
l’istante puro che trafigge
da parte a parte materiali freddi
e comici rimpianti.
un deragliamento di numeri primi
sotto il manto lacerato
dei proverbi
ieri, mentre forse morivo,
la rapinosa grammatica
dei pensieri
l’inesistenza confermava
di vite semplici,
l’elementare pulsare della carne
portava il tuo nome
e graffi di luce, come domande
si arricciavano sul brusio della terra
domenica 5
non ci si guarda in faccia
nelle stazioni di paese, l’inquadratura
è ferma sul chiaro messaggio
della carne che scava trincee
nelle nostre vite.
l’indicativo presente del tuo sperare
tenacemente ricomincia
in una pausa di mandel’štam.
e così mi appari nel forcipe
che ci strappa al pianto
e al soffio caldo delle promesse.
eloquentemente impallidiscono
gli amanti, ai quali tutto è consentito
mercoledì 8
il temporale si allontana tra
conversazioni spente.
sarebbe questa l’incurvatura
di un pomeriggio frusciante
sulla collina?
i predestinati si riprendono
il tempo di caduta
i mancati utili dei traffici oculari
le livelle a bolla d’aria.
niente più che
vocaboli fantasma
gli agguati dei saltimbanchi
giovedì 9
nel granaio di parole
a testa in giù
al traduttore non sfugge
quel nugolo di mosche
che io però non vedo.
sono cieco. posso solo
ascoltarne il ronzio
la decina con il 3
ha appena il tempo
di nascere.
toccherà a voi consolarci
con il più grande numero
del mondo…
tutte queste cose
e tante altre, e nessuno
che possa guardarle.
la linea obliqua delle p
su tre righe (in tedesco
non vi è traccia)
per l’arte mantica
delle cadenze finali
il problema non sussiste.
cerco un punto d’appoggio.
arrossisco come un pezzo
di carne. tra abbandono
e abbondanza
dividiamoci quest’aria
![]()
LA BUONANIMA
DELL’INGEGNERE
di Stefano Brusadelli
Sul Lungotevere Prati, a Roma, il monotono tessuto dell’edilizia umbertina è rotto dalla incongrua facciata neogotica della chiesa del Sacro Cuore del Suffragio, che ai romani è più nota come la chiesa delle Anime del Purgatorio. La spiegazione di questa bizzarra intitolazione sta nella sacrestia, dove in una sorta di piccolo museo sono raccolte varie testimonianze – abbastanza impressionanti – del loro manifestarsi ai vivi lasciando impronte impresse a fuoco su stoffa, carta o legno.
La storia qui raccontata non sarebbe mai accaduta se in questo piccolo museo non fosse stata condotta, da bambina, l’ormai cinquantottenne signora Augusta D., che ne era rimasta fortemente impressionata.
Volendo immaginare Augusta D., si deve pensare ad una signora corpulenta, un tempo indubbiamente procace, con un piglio gagliardo che si potrebbe dire tranquillamente da verdumaia di campo de’ Fiori se non fosse per il cognome che ha acquisito e per la casa lussuosa che abita sulla collina di Monte Mario.
La caratteristica principale di questa signora è che fa parlare i morti.
O, per essere più precisi, li fa scrivere.
Figlia di un tranviere e di una sarta del quartiere Monteverde, la signora Augusta era stata messa incinta a 20 anni e sposata al quinto mese di gravidanza dall’ingegner Giorgio D., appartenente ad una schiatta della borghesia romana tanto ricca di mezzi quanto povera di scrupoli. L’uomo l’aveva sposata più per sfregio alla supponenza della propria famiglia che per altro, e lei era rimasta durante tutta la vita del marito relegata in una sorta di terra di nessuno: né fuori dalla famiglia D., né dentro.
Poiché l’intelligenza e la conoscenza degli esseri umani non gli facevano difetto, ella aveva presto capito che agitarsi per entrare nelle mura del castello sarebbe stata fatica inutile; anche perché il marito, compiuto con poca convinzione e ancor meno successo qualche iniziale tentativo di farla accettare, gli aveva comunicato senza giri di parole che non ci si sarebbe più adoperato. L’ingegner D., del resto, era persuaso che l’averla tirata fuori dal suo seminterrato dandole il suo cognome, figli e patrimonio potesse costituire per lei un premio più che sufficiente.
Impossibilitata a recitare la parte della gran dama, visto che una parte nella vita si deve sempre recitare, la signora Augusta scelse allora quella della strega.
Si votò all’eccentricità. Dedicatasi all’esoterismo e alla necromanzia, vestita con voluta trasandatezza, i capelli malcurati e raccolti sempre a coda con l’elastico, gli occhiali scuri anche col buio, fornì essa stessa alla famiglia del marito i motivi evidenti ed incontrovertibili per tenerla a distanza; compiendo così il capolavoro di far apparire tale esclusione come frutto del timore che incuteva e non più della scarsa considerazione che suscitava.
In occasione delle feste comandate, quando non si poteva fare a meno di ammetterla in famiglia, faceva sentire addosso ai congiunti la stessa ostilità che essi riservavano a lei. Ma i suoi occhi avevano il dono di penetrare le vite altrui assai meglio di quanto riuscissero a fare gli altri con la propria. E questa acutezza veniva nutrita con tutte le informazioni, comprese le più scabrose, che l’ingegner D. le forniva a piene mani sul conto dei parenti.
Perché il marito lo facesse, e anche compiacendosene, non era del tutto chiaro neppure a lei. Forse era per divertimento, forse per disistima nei confronti della propria famiglia, forse ritenendo in tal modo di poter mitigare, se non addirittura di giustificare, la sua condizione di esclusa; in ogni caso, lo faceva nella certezza che versava quei segreti in un vaso dal quale non sarebbero mai usciti. Certezza che la signora Augusta faceva di tutto per confermare, ostentando dinanzi alle rivelazioni del marito un contegno che stava tra l’indifferenza e lo schifo.
Aveva comunque altro a cui pensare. Leggeva testi di esoterismo, partecipava a sedute spiritiche e nutriva uno speciale interesse per il Purgatorio, che considerava una realtà ingiustamente negletta. Perché l’umanità, pronta ad appassionarsi per ogni sciocchezza, riservava così poca attenzione a quel luogo dove prima o poi quasi tutti si sarebbero trovati a passare?
La morte prematura dell’ingegnere per un colpo apoplettico sembrò dover recidere in via definitiva il legame tra la signora Augusta e la famiglia D.
Gli abbracci di circostanza e le parole banali che i parenti le riservarono al funerale avevano lo stesso sapore di quelli con cui si accompagna alla porta un ospite che si spera di non vedere mai più.
Da vedova, l...