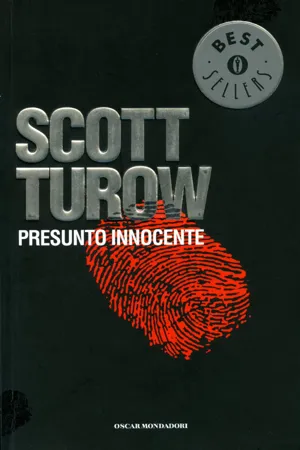![]()
![]()
«I documenti e i rapporti sono sopra. Le dichiarazioni dei testimoni sono sotto» dice Jamie Kemp mentre posa una pesante scatola di cartone sul piano lucidissimo del tavolo di noce. Siamo nella piccola sala delle riunioni, nello studio del suo principale e mio avvocato difensore, Alejandro Stern. Kemp suda. Ha fatto due isolati a piedi sotto il sole di luglio dal County Building con questi documenti. Si è tolto la cravatta blu, e i capelli biondi sono incollati alle tempie.
«Vado a controllare i messaggi telefonici» dice Kemp. «Poi tornerò per dare un’occhiata a questa roba insieme a te. E ricorda...» mi fa notare. «Non spaventarti. Gli avvocati difensori hanno un termine preciso per definire ciò che provi. Lo chiamano fifa.»
«Fifa?»
«Fifa è la paura che ti assale il cuore quando vedi le prove raccolte dallo stato.» Kemp sorride. Mi fa piacere che creda che io possa ancora accettare uno scherzo. «Non è letale.»
È il 14 luglio, tre settimane dopo la mia incriminazione per l’omicidio di Carolyn Polhemus. Questo pomeriggio comparirò davanti al giudice capo della Corte Superiore Edgar Mumphrey per l’imputazione ufficiale. Secondo le norme statali l’accusa è tenuta, prima dell’imputazione, a mettere a disposizione della difesa tutte le prove concrete che intende esibire e un elenco dei testimoni, incluse le copie delle loro dichiarazioni. Perciò ho davanti questa scatola. Fisso l’etichetta incollata sul cartone: IL POPOLO CONTRO ROZAT K. SABICH. Mi riassale la stessa sensazione: Non è vero. Solo in questa stanza confortevole, con le pareti rivestite di pannelli scuri e le file dei testi di giurisprudenza rilegati in rosso, attendo che passi questo abbinamento familiare di paura e nostalgia.
C’è un’altra copia dell’atto d’incriminazione, sulla scatola. Fisso le parole. “Aggredendo con la forza e le armi.” Vi et armis, un termine del diritto comune. Con queste medesime parole sono state formulate per secoli, nei paesi anglofoni, le accuse per gli atti di violenza. È una frase arcaica, abbandonata da molto tempo in quasi tutte le giurisdizioni; ma fa parte della legge del nostro stato, e leggerla mi lascia la sensazione di un’eredità bizzarra. Sono nella stessa categoria delle star del delitto, John Dillinger, Barbablù, Jack lo Squartatore e un milione di altri meno famosi, i mezzi pazzi, i maltrattati, i malvagi, e coloro che hanno ceduto alla terribile tentazione di un momento, a un istante in cui si sono trovati a contatto con le nostre componenti più selvagge, il nostro aspetto più tenebroso.
Dopo due mesi di insinuazioni quotidiane della stampa, di voci, di allusioni, di pettegolezzi crudeli, ho detto risolutamente che sarebbe stato un sollievo se fosse arrivata l’incriminazione formale. Ma sbagliavo. Il giorno prima Rinvio ha mandato a Stern quella che viene chiamata “la copia di cortesia” per l’imputato. Ho letto per la prima volta le accuse a una dozzina di metri da qui, in fondo al corridoio, nell’elegante ufficio color crema di Sandy, e il mio cuore e tutti gli altri organi si sono bloccati di colpo, con una sofferenza così acuta da darmi la certezza che fosse scoppiato qualcosa. Ho sentito il sangue defluirmi dalla faccia e ho capito che il mio panico era visibile. Mi sono sforzato di apparire composto, non per mostrarmi coraggioso ma perché all’improvviso ho capito che era l’unica alternativa.
Sandy era seduto sul divano vicino a me, e gli ho parlato di Kafka.
«Ti sembra orribilmente banale se dico che non riesco a crederci?» ho chiesto. «Che sono pieno di incomprensione e di rabbia?»
«Certo, non puoi crederci» ha detto Sandy. «Certo. Io, che faccio da trent’anni il penalista in questa città, non riesco a crederci, eppure pensavo di aver visto tutto. Tutto! E non lo dico tanto per dire. Avevo un cliente, Rusty, anche se non posso farne il nome, che una volta ha posato venticinque milioni di dollari in lingotti d’oro esattamente dove sei seduto tu. Un mucchio di lingotti alto più di mezzo metro. E io che ho visto cose di questo genere, a volte, di notte a casa mia, penso: Davvero, questo è straordinario e spaventoso.»
Sulle labbra di Sandy queste parole avevano la forza dell’autentica saggezza. Il suo lieve accento spagnolo conferisce eleganza anche alle cose più normali che dice. La sua dignità è rassicurante. Con l’andare del tempo mi sono accorto che, come un innamorato, conto su ogni gesto gentile.
«Rusty» mi ha detto Sandy, toccando il foglio che tenevo in mano, «non hai notato l’unica cosa che...» ha cercato la parola adatta, «che è incoraggiante.»
«Quale?»
«Non c’è la notifica. La notifica della Sezione 5.»
«Ah» ho detto io, scosso da un brivido. Nel nostro stato, l’accusa deve notificare, al momento dell’incriminazione, se chiederà la pena di morte. Nonostante i miei calcoli finemente calibrati sulle intenzioni di Rinvio, in tutti questi mesi, una zelante difesa interiore ha impedito che la mia mente sfiorasse tale possibilità. La mia espressione, credo, ha rivelato un po’ del mio imbarazzo, addirittura dell’umiliazione di essere già così distaccato dalle prospettive della routine professionale. «L’avevo dato per scontato» ho detto, fiaccamente.
«Ah, bene» Sandy ha sorriso con gentilezza. «Abbiamo queste abitudini» ha detto.
Su consiglio di Sandy, non eravamo in città quando fu restituito l’atto d’incriminazione. Io, Barbara e Nat andammo su, presso Skageon, in una baita di proprietà di amici dei genitori di mia moglie. Di notte si sentiva lo scroscio di Crown Falls, a un chilometro e mezzo di distanza, e le trote erano abbondantissime.
Ma naturalmente non potevo dimenticare mai la calamità seicentocinquanta chilometri più a sud. Il giorno dopo, George Leonard, del «Tribune» si procurò chissà come il numero di telefono della baita e mi chiese una dichiarazione. Gli risposi di rivolgersi a Stern. Più tardi, rientrai e sentii che Barbara stava parlando con la madre.
Quando posò il ricevitore mi sentii in dovere di chiederle: «È tutto finito?».
«Ne parlano ovunque. La televisione. I due giornali. In prima pagina. Con le fotografie. Il tuo vecchio collega Rinvio ha diffuso i dettagli più luridi.»
Era ancora dir poco. Il mio caso è uno di quelli che fanno parlare i giornali scandalistici venduti nei supermercati: Viceprocuratore capo incriminato per omicidio; era l’amante della vittima. Sesso, politica e violenza nella contea di Kindle. Non soltanto la stampa locale non ha parlato d’altro per giorni e giorni, ma ci si sono messi anche i mass media nazionali. Per curiosità, ho cominciato a leggere le cronache. La biblioteca di Nearing ha un’ottima sezione periodici e adesso io ho poco da fare. Seguendo il consiglio di Stern ho rifiutato di dimettermi da viceprocuratore e mi sono posto in aspettativa retribuita a tempo indeterminato. Di conseguenza ho passato in biblioteca più tempo di quanto avessi previsto. Come i vecchi mi godo il silenzio e l’aria condizionata e leggo le cronache nazionali dei miei misfatti. Il «New York Times», come al solito, è secco e concreto, chiama tutti “signore” e spiega l’intera situazione. Stranamente, sono state le riviste nazionali, «Time» e «Newsweek», a fare di tutto per calcare la mano. Ogni articolo era accompagnato dalla stessa foto, scattata da un imbecille che avevo visto appostato tra i cespugli per un paio di giorni. Alla fine, Stern mi aveva consigliato di uscire e di permettere che mi fotografasse, a condizione che poi mi lasciasse in pace. Il sistema ha funzionato. I Minicam, che secondo i vicini erano rimasti accampati per una settimana davanti alla casa mentre eravamo a Skageon, non sono ancora tornati.
Da un punto di vista pratico non fa molta differenza. Dopo dodici anni in cui ho sostenuto spesso l’accusa nei processi più clamorosi della città, i giornali e le stazioni televisive hanno abbastanza materiale su di me per sbattere la mia faccia dappertutto. Non posso andare in giro per Nearing senza che tutti mi guardino. Si comportano con una certa esitazione, indugiano qualche frazione di secondo prima di salutarmi. I pochi commenti consolatori sono ridicoli e inetti: il tintore che dice «una vera sfortuna» o il ragazzo del benzinaio che chiede se sono proprio io quello di cui parlano i giornali. Un’altra ragione per cui apprezzo la biblioteca è che là nessuno può parlare.
E cosa provo, io, caduto improvvisamente dal piedistallo di cittadino modello e trasformato in paria? Dire che non esistono parole è inesatto. Le parole ci sarebbero, ma sono tante. Il mio spirito beccheggia all’impazzata. L’ansia è corrosiva e io trascorro gran parte del tempo in un tumulto di collera e d’incredulità. In prevalenza c’è uno stordimento... un senso di ozioso rifugio. Anche nella mia preoccupazione per Nat e per il modo in cui tutto questo condizionerà il suo avvenire, spunta il pensiero che, dopotutto, questo è successo a me. Io solo sono la vittima. E in una certa misura, questo posso sopportarlo. Ho ereditato da mio padre più fatalismo di quanto immaginassi; una parte del mio essere non ha mai avuto fede nella ragione e nell’ordine. La vita è semplicemente esperienza; per motivi non facili da discernere, noi tentiamo di andare avanti. In certi attimi mi sorprendo di essere qui. Ho preso l’abitudine di guardarmi le scarpe quando cammino per la strada, perché il fatto di muovermi, di andare in qualche posto, di fare qualcosa, a volte mi appare sorprendente. Il fatto che la vita continui nonostante questa sventura mi sembra bizzarro.
Sono quasi sempre così, sperduto e remoto. Naturalmente, passo anche molto tempo a chiedermi perché è successo. Ma mi accorgo che a un certo punto, lungo la strada, la mia capacità di valutazione si arresta. Le mie speculazioni sembrano portare a una periferia buia e spaventosa, all’orlo di un nero vortice di paranoia e di rabbia dal quale, finora, mi sono ritirato istantaneamente. So che su certi livelli non posso sopportare altro, e non lo sopporto. Mi preoccupo, invece, di quando sarà finito, e di quello che sarà il risultato. Con una disperazione la cui immensità non può essere resa con una metafora, mi auguro che tutto questo non sia mai avvenuto; desidero che le cose siano com’erano prima, prima che lasciassi devastare la mia vita da Carolyn e accadesse tutto quello che è accaduto. E poi c’è la mia ansia divorante per Nat: Che ne sarà di lui? Come posso averlo portato sul punto di essere, a tutti i fini pratici, orfano per metà? In un certo senso questi sono i miei momenti peggiori: questa frustrazione rabbiosa, straziante, questa impressione di incapacità, queste lacrime. E poi, una volta o due, nelle ultime settimane, una sensazione straordinaria, più leggera dell’aria, più rasserenante di una brezza, una speranza che sembra sopravvenire senza spiegazioni, e mi da la certezza di essere salito su un alto bastione e di avere il coraggio di guardare avanti.
L’incriminazione contro di me, come posso dedurre dal contenuto della scatola di cartone, è molto semplice. Nico ha elencato una decina di testimoni d’accusa, più della metà da quali hanno a che fare con le prove anche scientifiche che si propone di produrre. Sarà chiamato Lipranzer, probabilmente per confermare che gli ho detto di non richiedere l’elenco delle telefonate fatte da casa mia. La signora Krapotnik mi ha identificato come uno che ha visto nel palazzo dove abitava Carolyn, sebbene non sia sicura che fossi io, l’estraneo notato la sera del delitto. Nell’elenco figura anche una cameriera di Nearing, la cui dichiarazione piuttosto oscura suggerisce che mi ha visto sull’autobus di Nearing City una sera, qualche giorno prima o dopo la morte di Carolyn. Ci sono poi Raymond Horgan; Tommy Molto; Eugenia, la mia segretaria; Robinson, lo psichiatra dal quale sono andato in diverse occasioni, e un certo numero di esperti scientifici, incluso Indolore Kumagai.
Tuttavia l’accusa contro di me è lineare. Nessuno dirà che mi ha visto uccidere Carolyn Polhemus. Nessuno testimonierà che ho confessato, se non si tiene conto di Molto, il quale nel suo promemoria finge di considerare l’ultima frase da me rivoltagli quel mercoledì di aprile come se non gliel’avessi detta con il tono di mandarlo al diavolo. Il nocciolo di questo caso è costituito dalle prove: il bicchiere con due impronte mie, identificate confrontandole con quelle che furono archiviate una decina d’anni fa, quando diventai viceprocuratore distrettuale; la documentazione della società dei telefoni, che mostra una chiamata fatta da casa mia a Carolyn circa un’ora e mezzo prima della sua morte; l’analisi del contenuto della vagina, che rivela la presenza, nei genitali di Carolyn, di spermatozoi del mio gruppo sanguigno, frustrati nella smaniosa, cieca migrazione da un contraccettivo la cui presenza implica un congresso carnale volontario; e finalmente, le fibre color malto di Zorak V trovate sugli indumenti di Carolyn, sul suo cadavere e un po’ dovunque nel soggiorno, e che corrispondono ai campioni prelevati dalla moquette di casa mia.
Queste due ultime prove sono saltate fuori in conseguenza di una visita fatta nella mia abitazione da due agenti della polizia statale un giorno o due dopo la riunione del Mercoledì Nero, come ormai lo chiamiamo io e Barbara, nell’ufficio di Raymond. Suonò il campanello: e mi vidi davanti Tom Nyslenski, che da almeno sei anni consegnava i mandati di comparizione dell’ufficio della procura. Ero ancora abbastanza confuso per sentirmi vagamente contento di vederlo.
Non mi fa piacere essere qui, disse. Poi mi consegnò due richieste del Gran Jury: una per fornire un campione di sangue, una per testimoniare. Aveva anche un mandato di perquisizione che autorizzava i poliziotti a prelevare campioni della moquette di casa mia e da tutti gli indumenti di mia proprietà. Io e Barbara restammo seduti in soggiorno mentre i tre in uniforme passavano da una stanza all’altra, armati di sacchetti di plastica e forbici. Rimasero un’ora nel mio guardaroba, a tagliare minuscoli pezzetti di stoffa dall’interno delle cuciture. Nico e Molto erano stati abbastanza furbi da non ordinare di cercare anche l’arma del delitto. Un tutore della legge sa che è meglio non fare qualcosa di ovvio come cambiare la moquette; sa che sarebbe rischioso anche scartare qualche indumento. Ma non conserverebbe mai l’arma del delitto. E se i poliziotti l’avessero cercata...