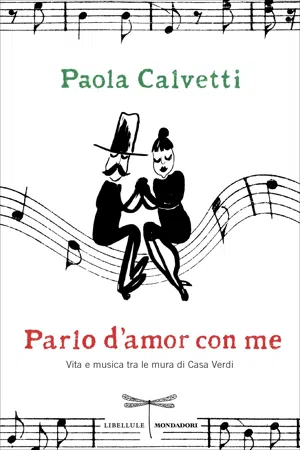![]()
«Ada, non trovo lo spartito.»
Sarebbe opportuno che per me fossero tutti uguali, lo richiede il mio ruolo, ma è inevitabile avere delle preferenze. Prendiamo la Piera – da pronunciare con l’articolo come si usa qui a Milano –, per esempio. Con lei me la intendo bene, forse perché da giovane faceva il mio stesso mestiere.
Porta la protesi alla gamba, ma per il resto è una vecchia adorabile come quelle che si trovano in quei bei film in bianco e nero di una volta, porta i capelli radi chiusi in una retina, ha la carnagione rosa e un paio di orecchini che non toglie mai. Per lei il pianoforte «non è mica uno strumento qualunque, come un flauto o una viola che si mette via in un armadio», eppure, quando si è trasferita qui, il suo lo ha lasciato dov’era.
Dice che non le manca, che a lei basta suonare.
«Non trovo lo spartito.»
Sono le dieci del mattino e sta per iniziare la sua prova in sala musica.
Sul pianoforte sistema il suo metronomo, tozzo come una piccola piramide, mentre lei si accomoda sulla panca con una grazia tutta sua e appoggia i piedi sui pedali. Apre il coperchio e c’è qualcosa di solenne, al limite dell’illecito, in quel gesto, poi le sue mani planano sulla tastiera e le note riempiono lo spazio della stanza, profumata della cera d’api che ho passato giusto ieri sugli infissi.
Da bambina la Piera aveva sentito le note per la prima volta alla radio e subito le era venuta la passione, ma in quegli anni non si usava che le signorine frequentassero il Conservatorio e i genitori l’avevano mandata come esterna.
Finiti gli studi era lì lì per farsi suora, ma pulire i pavimenti del convento con la soda le rovinava le mani.
«Erano sempre rosse e screpolate, allora chiesi alla madre superiora di affidarmi altre mansioni, ma quella non capiva. Come fai a spiegare che suonare vuol dire stare più vicini al Signore?»
Io, che con Dio non riesco ad avere confidenza nemmeno quando la mia malinconia si trasforma in uno strazio insopportabile, davanti a tanta logica quasi mi commossi. Fatto sta che tra il pianoforte e Dio, la Piera aveva scelto il primo. Lei aveva lasciato il convento e la vocazione aveva lasciato lei. Le sue mani sono presto tornate agili e tutta la dolcezza negata ai pavimenti delle consorelle l’hanno riversata sugli allievi. Non ci sono recital, né concerti, per la Piera. Soltanto le sue lezioni: «Se non ci fossero gli insegnanti non ci sarebbero concertisti» ripete, e quando i ragazzi arrivano qui, il mercoledì e il venerdì, lei fruga nella sua borsetta, li rimpinza di caramelle e dolcetti e comincia. Nella stanza si sente solo il ticchettio del metronomo, poi la musica sembra venir fuori dalle loro anime da sola, non perché lei, con le sue mani fragili e minacciose, ce la ficca dentro a forza.
Io naturalmente non commento perché una cameriera deve starsene zitta, ma come vorrei essere insieme a loro piuttosto che davanti al mio pianoforte muto!
Il resto del suo tempo la Piera lo passa a leggere partiture come fossero romanzi, e anche tutto quello che le capita a tiro. Le piace districarsi fra le parole crociate, divora gialli e thriller sanguinolenti. Suona l’organo ogni domenica alla messa qui nella cappella della Casa e, quando occorre, le toccano i funerali.
Non lo ammette, è troppo timida!, ma l’idea di suonare fra poche ore in una irripetibile occasione sembra eccitarla più del solito: «Ada, sono tutta sottosopra! Mi sento come dopo quella funzione del 19 marzo di due anni fa, l’onomastico del Maestro, sai? Un bel signore distinto mi si avvicinò e mi chiese se per caso conoscevo l’organista. Be’, gli dica che è stato bravissimo, disse proprio così».
Era lei, nascosta lassù, a suonare Franck, ma per via di una paralizzante timidezza non rivelò la verità allo sconosciuto ammiratore. Sarà per questo aspetto del suo carattere che non si è mai sposata, anche se un giorno – era in vena di confidenze e ci eravamo bevute un goccetto – mi aveva raccontato di avere incontrato delle persone che le piacevano, ma che «quelle dopo un mese volevano già fare l’amore».
«Dicono che sia la cosa più naturale del mondo» avevo ribattuto, ma a dire la verità in queste faccende non sono proprio un genio e ho passato buona parte della mia vita a chiedermi come sciogliere questo nodo.
«Io rispondevo: prima il matrimonio. E quelli se ne andavano.»
«E poi?»
Dopo quella sbalorditiva confessione, era rimasta un po’ in silenzio. Poi, senza una goccia di rimpianto nella voce aveva risposto:
«Volevo farmi suora, figurati se mi importava degli uomini!»
Cosa sanno loro del morir d’amore?
«Ti ho già detto che non trovo lo spartito? Sto aspettando la Kimiko.»
Sono inseparabili, la Piera suona e Kimiko canta.
«Avete già scelto i brani per la cerimonia?»
«Oh, un programma ambizioso, ma sono così affezionata alla Clara che non posso fare brutta figura, ne’. Si sarà mica persa, quella?»
Aperta la finestra, Piera si affaccia sulla piazza, quasi a dare il buongiorno al suo Maestro. O a parlare con il suo buon Dio.
«Vado a cercarla, tu stai qui tranquilla.»
Che strana gente, la musica si conserva dentro di loro e poi si perdono in un bicchiere d’acqua.
«Sarà in giardino come al solito. O magari è ancora in stanza. Sicura di averle detto alle dieci?»
«Sicurissima. Vai, su. Intanto io cerco lo spartito. Vi aspetto qui.»
Chiude la finestra e si mette a frugare nella ciotola delle caramelle.
Busso alla numero 16. È uno scrupolo perché non chiude mai a chiave, lei. Entro e me la trovo davanti, seduta sulla sua poltroncina gialla. Non lo direste mai che questa signora con l’abitino di cotone a fiori e i piedi avvolti in un paio di calzette bianche sia un soprano lirico che, prima di arrivare qui con gli scatoloni zeppi di ellepì e partiture d’opera, ha fatto più volte il giro del mondo all’inseguimento della musica. E di una specie di rocambolesca libertà.
Con lo sguardo fisso oltre la barriera della finestra Kimiko gira il cucchiaino nella tazza appoggiata sul tavolo; tiene l’altra mano davanti alla bocca come a scusarsi di qualcosa.
«Che ci fai ancora qui? La Piera ti aspetta da un pezzo.»
Mi fissa e, come se rivedesse un’immagine precisa in ogni dettaglio e con l’aria di chi si è dovuto allontanare da qualcosa per necessità, Kimiko comincia a parlare.
Parla a me, ma sta raccontando per sé.
«È mattina. Sono in cucina e d’improvviso tutto diventa buio come se scendesse di nuovo la notte. Guardo fuori, il vento tuona, l’acqua batte sui vetri. In cielo c’è un enorme fungo grigio e poi tutti, la mamma, i vicini, la zia rientrano dalla strada arrancando come moribondi. Papà non c’è, però. Lui lavora al cantiere navale di Nagasaki, consegna motori a centocinquanta chilometri da casa.
Non riesco a muovermi. Sono abituata a rintanarmi sotto terra, ma questa volta è diverso. Non capisco cosa sta succedendo, ma so già che per proteggerci da quella nuvola gigantesca il rifugio non basterà. La mamma stende dei panni neri alle finestre perché così gli aerei non ci possono vedere. Scendiamo. Ho paura, ma qui sotto per fortuna c’è la musica. Mia sorella ha una bellissima voce e canta ’O sole mio. Tre settimane dopo mio padre comincia a stare male. Il 1° febbraio muore di tumore. Dicono tutti che è per le radiazioni.»
Il tè deve essere già freddo, ma Kimiko continua a girare il cucchiaino e c’è qualcosa di così struggente in quel cucchiaino che gira che mi viene voglia di prenderla per mano e portarla via con me. Ha taciuto per decenni e di colpo – forse il pensiero di cantare davanti a una nuova famiglia felice ha fatto rigurgitare quella brutta roba? – s’è voluta confidare con me, e a me mancano le parole.
«Ada, fin da bambina il canto è stato l’unico posto dove potevo stare in pace.»
Di puzza di bruciato e cicatrici sul cuore me ne intendo, ma davanti a quell’orrore la voce mi si riduce a un soffio: «Su, non pensarci adesso e vieni giù a cantare che la Piera ti aspetta da mezz’ora» è l’unica frase che mi esce di bocca.
Musica e memoria: può esistere un impasto più forte a pesare sul cuore?
Quando ho avuto occasione di osservare da vicino il visetto smunto di Kimiko sarà stato cinque, sei anni fa. Era un pomeriggio di agosto. Il caldo scioglieva l’asfalto e lei si era rifugiata in giardino, vicino alla statua del Boito. Pareva una porcellana poggiata sul bordo della panchina, con le mani accostate in grembo, le ginocchia ravvicinate, i minuscoli piedi infilati nelle ciabatte di un numero più grande da cui spuntavano le caviglie chiare. Le foglie del cespuglio dal quale la sbirciavo formavano un séparé che non bastava a nascondermi. Mi dissi: “Ecco una condannata a fare Butterfly per tutta la vita” e per attaccare bottone
gliela buttai lì:
MADAMA BUTTERFLY, Atto II
«Chissà quante ne ha dovute cantare, eh!»
«Sono stata Gilda, Rosina, Leonora, ma quella lagna di Cio-Cio-San non mi è mai piaciuta: sempre lì ad aspettare che torni quel disgraziato...»
La prima giapponese della mia vita aveva risposto in perfetto italiano. Da quell’incontro ci siamo avvicinate sempre di più e adesso ogni volta che possiamo ci piace un sacco stare a bisbigliarci delle cose stupide. È che siamo accomunate dallo stesso destino: solo a pronunciarla, la parola famiglia ci fa sentire le fiamme in gola e nella pancia un tormento rovente come mille incendi. Lei se l’è data a gambe dal Giappone, io dal paesino di quattro case e troppa cattiveria dove sono nata.
La nostra specialità sono le famiglie infelici, la corpulenta cameriera e il fragile soprano dagli occhi come chicchi di uva passita combattono il nemico con le note e, ognuna a modo suo, pensa che è stato il canto a salvarle la pelle. O forse soltanto l’anima, ma è quanto basta.
Qualche giorno dopo – d’estate la Casa si spopola, chi può se ne va in vacanza – l’avevo invitata da me.
Con la fine della guerra Kimiko s’era ritrovata senza il padre, e la casa, il terreno e le risaie erano stati confiscati, ma fortunatamente, oltre a questi soprusi, il programma governativo prevedeva delle borse di studio e, appena diciassettenne, Kimiko da Nagasaki era riuscita a farsi spedire a Tokyo. Fra canto italiano e canto tedesco aveva scelto il primo, impiegando sei mesi per preparare l’ammissione ai corsi. Quando mi raccontò di quella volta che era arrivata in ritardo sull’ora di chiusura del dormitorio dove alloggiava, e per punirla l’avevano obbligata a fare i mestieri, mi trattenni a stento dal dirle: “Anche tu come me! E come la Piera. Il mondo della lirica è popolato di sguattere”.
LA CENERENTOLA, Atto I
Lavare pavimenti con l’acqua fredda a poche ore da un esame irrigidisce le dita, ed è dura poi scioglierle su una tastiera, ma Kimiko anche quella volta la spuntò sulla malasorte, per lei si aprirono le porte dell’università dove, «vestita con una gonna grigia e un paio di scarpe rosse», sostenne l’esame cantando non so cosa di Fauré in francese.
Che snob!
Siamo cresciute con lo stesso sogno, anche se io sono nata quando l’eco delle bombe si era zittito da un bel pezzo.
«E poi, che è successo?»
«Sono stanca, ora. Ne avrei tante di cose da raccontare, Ada.»
Disse così, si alzò dalla sedia, fece un cenno con la mano e tornò a rintanarsi nel tempio del silenzio. Più che un saluto, la sua sembrò un’invocazione e la musica l’unico luogo dove non l’avrebbero inseguita.
Certo, adesso che finalmente so tutta la storia capisco perché quella volta se ne andò così, e quel tipetto della Kimiko – come la chiamano qui – mi è ancora più caro. Sarei rimasta ...