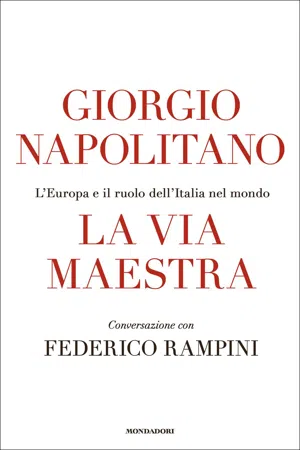Quando, nel 2012, la giuria di Oslo ha assegnato il Nobel per la pace all’Unione europea «per oltre sei decenni dedicati al progresso della pace e della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani in Europa», ad alcuni è sembrato come un premio «alla memoria». Un riconoscimento che guardava più al passato che al presente. Certo l’Unione europea di oggi è figlia di quella Comunità che nel 1957 sancì la riconciliazione franco-tedesca rendendo impossibile una nuova guerra fratricida nel cuore dell’Europa. Certo ha dato contributi importanti ai diritti umani, basti ricordare l’attrazione esercitata verso paesi come la Spagna franchista e la Grecia dei colonnelli, poi divenute democrazie. Ma tutto questo è storia. Per i giovani sembra quasi… preistoria. Oggi, quando si dice «Europa», si pensa subito all’euro, alla dimensione economica. Il nostro ruolo come superpotenza nella politica estera resta allo stato virtuale.
Non dobbiamo commettere l’errore di ridurre l’Europa – il disegno e la realtà della costruzione europea – alla moneta unica e, più in generale, alla sola dimensione economica. Quando parliamo di Europa come soggetto politico unitario, di integrazione politica, di Unione politica, ci riferiamo all’affermazione del ruolo dell’Europa nel mondo, nella rete delle relazioni internazionali e nel complessivo processo di globalizzazione. È vero, la politica estera e di sicurezza è rimasta gravemente in ombra in quest’ultimo periodo dominato – nell’Unione europea – da una pesante sindrome «inward looking», da un forte ripiegamento su se stessa. L’Europa non è solo integrazione economica, ha rappresentato per ben più ampi motivi e aspetti un modello per nuove aggregazioni unitarie in America latina e in Africa. Abbiamo sviluppato un originale modello economico-sociale che amalgama libertà e solidarietà. Ci tengono insieme una comunità di valori, una comunità di diritto, un molteplice flusso di cultura, all’insegna dell’unità: è tutto ciò che fa dell’Europa una realtà unica sulla scena mondiale. Ma siamo stati troppo spesso assenti, divisi o esitanti nell’arena internazionale. Per Prodotto interno lordo, popolazione, potenzialità militari e rete d’interessi strategici ed economici, l’Europa ha tutti i numeri per essere un attore globale. Nulla ci impedirebbe di competere con Stati Uniti, Cina, Russia. Purché uniti. Delle possibilità dell’Europa nel suo insieme, di quel che già rappresentiamo, diede, alcuni anni fa, una felice sintesi l’allora ministro degli Esteri britannico, David Miliband, ricordando questi dati: i paesi dell’Unione sostengono quasi il 40 per cento del bilancio delle Nazioni Unite e quasi i due terzi degli aiuti allo sviluppo mondiale; abbiamo 2 milioni e mezzo di uomini e donne in armi e 40.000 diplomatici che operano in 1500 missioni diplomatiche nel mondo; e, naturalmente, la dimensione del nostro mercato unico ci dà un’influenza decisiva nei negoziati sul commercio globale o sull’ambiente.
C’è un banco di prova qui vicino a noi: sono le «primavere arabe» iniziate come rivolte antiautoritarie in Tunisia, Egitto, Libia, Siria, e spesso segnate da esiti tragici. Sono zone dove abbiamo interessi strategici, paesi dove gli europei furono colonizzatori, e che conosciamo meglio di quanto li conosca l’America. Eppure non sembra proprio che l’Europa abbia saputo esercitare una leadership in queste crisi, né un’influenza rilevante presso i popoli che sono scesi in piazza per abbattere regimi autoritari, anche se senza chiare prospettive.
In quello che è il nostro «estero vicino» – Nord Africa, Medio Oriente e Balcani – la capacità di iniziativa dell’Europa è essenziale: non si può giustificare che manchi o si mostri debole e discontinua. La nostra parte dobbiamo farla innanzitutto lì. La presenza e il ruolo dell’Europa nei Balcani stanno da anni facendosi sentire e pesando. Ma assai poco abbiamo pesato rispetto alla trasformazione avviatasi nel Mediterraneo arabo, che può cambiare radicalmente la fisionomia del Nord Africa e del Medio Oriente ma il cui percorso è difficile, esposto ad alti e bassi e financo a drammatici rovesciamenti, a insorgenze di guerra civile, a sanguinose regressioni, come stiamo vedendo in Egitto. L’intero limes meridionale e sudorientale dell’Unione è fonte di sfide e di grandi potenzialità, di forniture preziose, minacce alla sicurezza, movimenti di popolazione e, insieme, scambi e traffici fecondi. Da quando in Tunisia, alla fine del 2010, la rivolta del pane diede il via a uno straordinario sussulto democratico, subito propagatosi in altre nazioni vicine, è sembrato levarsi da quelle sponde un anelito di libertà che non potesse essere soffocato con le armi. Forse abbiamo però ceduto a una previsione troppo ottimistica. E ce lo ha fatto capire la Siria, pagina dolorosissima per le atrocità del regime di Assad, per le conseguenze umanitarie devastanti della guerra civile, per i limiti della comunità internazionale nel tentativo di arrestarla.
Questa situazione ci chiama in causa direttamente. Il Nord Africa è fragile, e l’Europa ha la responsabilità di sostenerne il deciso avanzamento democratico, attraverso la costruzione dello Stato di diritto, la tutela dei diritti umani e delle minoranze, l’affermazione delle libertà fondamentali, compresa quella di culto. È preciso interesse strategico del nostro continente promuovere il progresso civile e sociale dei 160 milioni di persone che vivono tra le Colonne d’Ercole e il Mar Nero. Spetta in particolare all’Italia, con gli altri paesi che hanno radici nel Mediterraneo, persuadere quei partner dell’Unione la cui politica estera è distratta da altri orizzonti, e ai quali sfugge l’urgenza che viene da sud. Tocca a noi far compiere un salto di qualità alla politica dell’Europa per il Mediterraneo. Il varo della Politica europea di vicinato, con una miscela di aiuti e di condizionalità sul piano democratico, promette maggiore accesso al nostro mercato e maggiore mobilità per le persone. Ma non basta a venire incontro a un rinnovamento epocale di quelle dimensioni. Un impegno europeo per il Mediterraneo, per farne un’area di pace, democrazia e benessere, non è solo questione di denaro e di circolazione delle merci. Dobbiamo concorrere al rafforzamento delle strutture istituzionali di quei paesi, trasmettendo esperienza e capacità di «institution building». Dobbiamo elaborare incentivi specifici per i governi che realizzino le riforme democratiche. Puntiamo a fare dei paesi della sponda sud veri e propri partner, senza abdicare ai nostri valori universali di libertà e democrazia. In definitiva, l’uscita dalla crisi economica e occupazionale che in questo momento ci attanaglia passa anche attraverso il rilancio della proiezione esterna delle nostre economie. Per Spagna, Italia e Grecia da dove cominciare, se non dal Mediterraneo? Il proiettarci verso le realtà emergenti di continenti lontani è importantissimo, ma senza «saltare» il Mediterraneo.
Eppure l’Unione europea continua a dividersi su questioni di primaria importanza politica. Per esempio, quando il 30 novembre 2012 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato a stragrande maggioranza il nuovo status della Palestina come «Stato osservatore», noi europei non siamo riusciti a votare tutti allo stesso modo. Due fra le maggiori nazioni Ue, Germania e Regno Unito, si sono astenute.
È difficile trovare le posizioni comuni nell’emergenza, in extremis, se prima non si sono sviluppate in profondità una riflessione e un’analisi comuni. Questo non vale solo per la questione israelo-palestinese, che è forse la più intricata e scottante di tutte. Anche in occasione della crisi in Georgia, alcuni anni fa, apparve chiaro che, cercando all’ultimo momento di definire una posizione convergente, si fa fatica, si resta sul terreno della manovra tattica. Per i più pessimisti sembra avere avuto ragione Giulio Andreotti, il quale pensava che una politica estera comune fosse un obiettivo velleitario. Certo occorre poter disporre di «leve» strutturali che ci spingano e ci aiutino ad agire insieme. Da questo punto di vista non siamo più nelle condizioni in cui ci trovavamo quando il segretario di Stato americano Henry Kissinger si chiedeva quale fosse il numero di telefono da chiamare per parlare con l’Europa. Quella celebre battuta alludeva alla mancanza di un rappresentante unico. Oggi l’alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea – titolare unico delle competenze in materia – esiste. Esso può far leva su una cellula permanente e perfino su una prima rete diplomatica, su un «servizio di azione esterna», nonostante le difficoltà proprie di un’invenzione così originale.
Resta però molto da fare, anche per superare il peso dei retaggi storici. Sul Medio Oriente, per esempio, la Germania si sente vincolata dal proprio passato. Qualunque cosa faccia Israele – sembrano pensare i governanti tedeschi – la Germania non ha titolo per dire di no, per sostenere posizioni critiche. L’ex cancelliere socialdemocratico Helmut Schmidt ha detto all’ultimo congresso della Spd che ci vorranno generazioni perché venga dimenticato ciò che fece il nazismo. Questo è un problema che non riguarda solo Israele. Anche a proposito della forte, se non egemonica, posizione raggiunta dall’economia tedesca in Europa, abbiamo visto con quale facilità nei paesi vicini si riaccendano i sospetti del passato. In quanto alla Gran Bretagna, su Israele essa riflette il peso delle posizioni americane. E negli Stati Uniti le lobby pro-israeliane sono potenti: abbiamo un premier di Israele, Benjamin Netanyahu, che ha sostenuto duramente le sue posizioni in trasparente polemica con il presidente Obama davanti al Congresso di Washington, ricevendo applausi dai parlamentari repubblicani.
Quel voto sulla Palestina come Stato osservatore all’Onu il 30 novembre 2012 ha rianimato divisioni non soltanto tra diversi governi europei, ma anche all’interno del nostro paese. Rispetto al governo Berlusconi, che si era allineato con Netanyahu, qualcuno ha denunciato uno «strappo» quando il governo Monti ha votato in favore della Palestina.
La chiave del voto italiano sullo status della Palestina all’Onu è chiara: bisogna favorire un recupero di autorità della parte più moderata e lungimirante della leadership palestinese. La deriva estremista di una parte del mondo palestinese è anche il riflesso di troppe rigidità e chiusure del governo israeliano. Questo è tanto più preoccupante in uno scenario di frantumazione del mondo arabo. Apparentemente, in quel mondo c’è un punto di unità nel difendere la causa palestinese. Ma non mancano atteggiamenti distruttivi verso Israele; e giocano manovre tattiche e calcoli di concorrenza tra i paesi del Golfo, e tra quelli e altre realtà del mondo arabo e islamico.
Nelle polemiche su quell’episodio, è stato coinvolto anche lei. Qualcuno ha riesumato il sospetto che dietro la posizione dell’Italia ci fosse la tradizione filopalestinese o filoaraba che fu del Partito comunista italiano.
Ricordo bene che Giancarlo Pajetta credeva al socialismo arabo di Nasser, quando il colonnello egiziano prese il potere al Cairo negli anni Cinquanta. Acqua passata. Io ho svolto un ruolo convinto e chiaro nella ricollocazione del Pci rispetto a Israele, quando nel 1986 al Congresso di Firenze l’allora segretario Alessandro Natta mi chiese di diventare responsabile della politica estera del partito. Il mio primo viaggio in quella veste lo feci in Israele, e l’incontro con Shimon Peres è proprio di quell’anno, il 1986. Questo mi torna in mente perché al riequilibrio dei rapporti tra la sinistra italiana e Israele ho lavorato molto. Ne è rimasta testimonianza l’amicizia che continua da quasi trent’anni con il presidente Peres; e ne hanno rappresentato l’espressione culminante i miei viaggi in Israele da presidente della Repubblica, le celebrazioni del Giorno della Memoria da me tenute al Quirinale, i miei discorsi sulla Shoah, sull’antisemitismo e sull’antisionismo. In quanto all’Italia, le tensioni con Israele o l’attenzione al mondo arabo ci furono con Andreotti, Moro, Craxi: è strano sentirsi accusare adesso (anche se solo da qualcuno) di avere rotto una continuità di intesa senza intoppi nelle relazioni tra Italia e Israele. Il voto dell’Italia sullo status della Palestina all’Onu, nel novembre 2012, sconta la rigidità dell’attuale politica del governo israeliano. Ma il rifiuto dell’antisemitismo, o anche il rifiuto dell’antisionismo che maschera ideologie antisemite, il fermo attaccamento alla linea «due popoli, due Stati», questo è un punto fermo della politica estera italiana al quale tengo molto.
Rievocare i tempi di Andreotti, Moro e Craxi ci riporta a un’epoca in cui i margini di manovra per l’Italia e per l’Europa erano comunque limitati. Potevamo fare una politica di aperture al mondo arabo, in una logica da paese mediterraneo, ma all’interno di un quadro generale dove le superpotenze erano Usa e Urss, e noi contavamo poco. Oggi lo spazio che l’Europa potrebbe occupare come soggetto della politica internazionale sarebbe diverso.
Forse non ci si è ancora resi pienamente conto della svolta radicale creatasi con le rivoluzioni del 1989 nell’Est europeo e con la dissoluzione dell’Unione Sovietica. Per oltre trent’anni dopo la nascita della Comunità europea le potenzialità di una politica estera comune furono limitate dalla divisione del mondo in due blocchi contrapposti. I paesi dell’Europa occidentale fecero la scelta di campo a essi connaturale, e poterono semplicemente caratterizzarsi, in chiave spesso moderatrice, all’interno dello schieramento atlantico. Ma con gli anni Novanta si è aperto un campo di opportunità senza precedenti per un’Europa che voglia fare la sua parte, e non rassegnarsi a un fatale decadimento del suo peso e del suo prestigio sulla scena mondiale. Lo può fare senza mettere in forse la sua storica alleanza con gli Usa e i suoi legami transatlantici, ma dandosi, con l’Europa, un più netto profilo e acquistando un proprio spazio di movimento. C’è in questo senso una domanda che viene dall’esterno dell’Italia e dell’Europa. Perché all’Europa si riconoscono una ricchezza di radici e sensibilità culturali, una tradizione di potenza civile, una capacità di mediazione politica disinteressata in situazioni di crisi. L’Europa ha dimostrato in alcuni conflitti esterni la sua vocazione a combinare l’intervento militare, quando necessario in aree di crisi e di violenze – su richiesta della comunità internazionale –, con la solidarietà e il sostegno allo sviluppo economico, sociale, istituzionale delle popolazioni e dei paesi coinvolti. In fatto di soft power, siamo apprezzati dal resto del mondo.
Per quanto possa apparire paradossale, è nelle nostre classi dirigenti nazionali, e nell’opinione pubblica europea, che si manifesta invece scetticismo sulla possibilità di un’efficace funzione dell’Unione per promuovere un ordine mondiale più pacifico e più giusto. Quegli scetticismi fanno tutt’uno con residue illusioni sulle possibilità di protagonismo dei maggiori Stati membri, se non con tendenze a una grave sottovalutazione delle responsabilità internazionali degli europei. Un caso emblematico è il persistente, tradizionale atteggiamento di diffidenza, se non di ostilità, del popolo e delle élite britanniche nei confronti dell’unificazione europea. È ora di ammettere realisticamente che la speciale posizione della Gran Bretagna nelle relazioni internazionali – compreso il rapporto particolare con gli Stati Uniti –, la peculiarità del ruolo della City o della sterlina non possono giustificare un atteggiamento distaccato, se non addirittura elusivo, rispetto a fondamentali responsabilità comuni. Il Regno Unito dovrebbe capire che non è immune dal rischio di marginalizzazione.
Lo scetticismo sul nostro ruolo globale ha coinciso con un netto raffreddamento dei consensi verso l’allargamento. «Meglio meno, ma meglio» è diventato uno slogan sottinteso, anche per lo shock della crisi che ha accentuato le divaricazioni economiche tra un centro e una periferia dell’euro. Aver detto no alla Turchia si è rivelato un errore?
È un errore escludere di aprirsi oltre gli attuali confini dell’Unione. Dobbiamo proseguire. Allargamento verso i Balcani, dopo che l’ingresso di Slovenia e Croazia ha costituito un fattore di pacificazione, rendendo possibile quella riconciliazione adriatica di cui l’Italia si è fatta promotrice, anche per mio diretto impulso. Allargamento verso la Turchia, con cui non possiamo rinnegare l’impegno di negoziarne l’ingresso nell’Unione, purché quel paese non scivoli verso una deriva non democratica, integralista. Proprio per scongiurare tale pericolo, è essenziale offrire alle forze democratiche e di tradizione laica in Turchia l’ancoraggio alla prospettiva europea.
Un’altra ragione per essere scettici sul ruolo mondiale dell’Europa è quella che spesso ci viene rinfacciata dagli americani. Gli Stati Uniti ci considerano un «parassita della sicurezza». Pensano che alle velleità europee di svolgere un ruolo internazionale non corrispondano adeguati investimenti per la difesa. Le opinioni pubbliche europee si sono abituate per decenni a vivere sotto l’ombrello di protezione Usa, e ogni spesa militare incontra fortissime resistenze tra gli elettori.
Nell’era della guerra fredda e della contrapposizione tra le due superpotenze, l’egemonia americana diede l’impronta all’alleanza transatlantica, e ciò avvenne anche per un calcolato (e forse storicamente condizionato) ritrarsi dell’Europa da costose e rischiose responsabilità, come quelle che avrebbe dovuto assumersi per la propria sicurezza. Oggi l’Europa deve farsi carico della propria difesa e anche della sicurezza collettiva: si tratta di responsabilità e oneri che non possiamo più lasciare sulle spalle degli Stati Uniti. Solo così si può avere voce, com’è giusto, nella definizione di un nuovo concetto di sicurezza globale, e solo così si può consolidare quell’alleanza transatlantica che anche in un mondo tanto mutato resta la pietra angolare della nostra collocazione internazionale.
Le minacce da fronteggiare sono molteplici. Il terrorismo, di matrice fondamentalista islamica ma anche di altre radici. La tendenza, oggi da parte dell’Iran, a rilanciare la proliferazione nucleare. Se manca in noi la consapevolezza di quali siano oggi i rischi e la posta in gioco, franerebbe per l’Europa ogni chance di farsi coprotagonista del processo di globalizzazione, con la conseguenza di condannarci all’irrilevanza. Ma il solo modo di fare senza più alibi la nostra parte è mettere insieme le nostre risorse e le nostre strutture militari, razionalizzarle e accrescerne la produttività, attraverso un coraggioso processo di integrazione su scala europea in questo campo cruciale.
Una conferma delle diverse sensibilità tra Europa ...