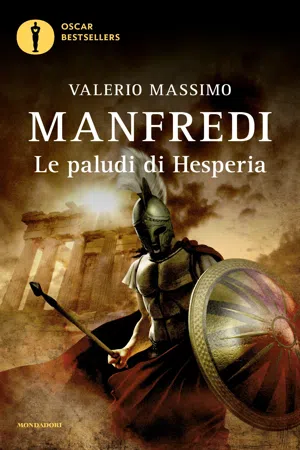Si fece silenzio nella sala, tutti guardavano l’ospite, il naufrago abbandonato dal mare fra gli scogli e la rena. Le sue mani erano ancora ferite e graffiate, i suoi occhi arrossati e i capelli secchi come l’erba al finire dell’estate. Ma la sua voce era bella, d’un timbro fondo e sonoro e, quando narrava, il suo volto si trasfigurava, gli occhi si accendevano di una febbre misteriosa, sembravano riflettere un fuoco interno e nascosto, più ardente che le fiamme del focolare.
Capivamo la sua lingua perché noi abitavamo vicino al paese degli Achei e un tempo avevamo con loro rapporti commerciali ma, benché io sia un cantore fra la mia gente e conosca storie bellissime e lunghe tanto da occupare una notte intera d’inverno, quando gli uomini hanno piacere di starsene su a bere vino e ad ascoltare fino a tardi, tuttavia non avevo mai udito nella mia vita una storia più bella e terribile; la storia della fine di un’era, del tramonto degli eroi…
Triste, quindi, soprattutto per un cantore quale io sono, perché se gli eroi scompaiono anche i poeti muoiono non avendo più materia per il loro canto.
Io sono vecchio ora e non ho alcun desiderio di vivere di più. Ho visto città fiorenti divorate dalle fiamme e ridotte in cenere, ho visto pirati feroci battere i mari e saccheggiare le coste, ho visto fanciulle intatte violate da barbari sanguinari e ho visto morire tutti coloro che amavo… E tuttavia di quei lontani giorni della mia fanciullezza nessun ricordo è più vivo in me del racconto di quello straniero.
Egli aveva assistito all’impresa più famosa che fosse stata portata a termine in quei giorni, la conquista della più forte città dell’Asia, e aveva seguito in battaglia e poi in una interminabile avventura uno degli uomini più forti della terra, un guerriero indomito e generoso che aveva osato opporsi in duello agli stessi dèi ferendo a una mano Afrodite e squarciando il ventre ad Ares, il nume della guerra, furia oscura e tremenda, che non rinuncia mai a vendicarsi.
Ora voi ascolterete la mia storia seduti sul fieno bevendo latte di capra e forse non crederete alle mie parole, lo so, penserete che siano racconti che ho inventato per intrattenere il mio uditorio e per ricevere alla fine un’elemosina di cibo e di alloggio, ma vi sbagliate. Prima di questo mondo rozzo e miserabile esistette un’epoca in cui gli uomini abitavano città di pietra, vestivano di bisso e di lino, bevevano, in calici d’oro e d’argento, vino inebriante, navigavano su agili navi fino ai confini della terra, combattevano su cocchi di bronzo e impugnavano armi splendenti. In quel tempo i poeti erano accolti nelle case dei re e dei principi, erano onorati come numi.
Ciò che sto per dirvi è tutto vero.
L’ospite straniero rimase a palazzo per alcuni mesi poi un giorno, sul finire dell’inverno, sparì senza dire nulla e di lui non sentimmo più parlare. Io però non avevo perso una parola di quello che lui narrava la sera, dopo la cena, nella sala delle adunanze. L’eco della grande guerra sulla sponda dell’Asia era giunta fino a noi ma quella era la prima volta che avevamo l’opportunità di ascoltare la testimonianza di un uomo che vi aveva preso parte.
Più volte il capo della nostra gente e i nobili gli chiesero di raccontare la storia della guerra ma egli sempre si rifiutò. Disse che non voleva ricordare quei giorni amari. E quando finalmente cominciò a narrare egli iniziò il suo racconto dalla notte della caduta della città di Priamo.
Così come l’appresi dalle sue labbra, io ora vi narrerò la storia che seguì la caduta della città e di come una guerra tanto lunga ed estenuante fosse stata combattuta per nulla.
Prima di scomparire per sempre quell’uomo mi rivelò un segreto: il vero motivo per cui Ilio fu rasa al suolo e la sua popolazione distrutta o ridotta in schiavitù. No… non fu Elena la causa. Potrei dire anzi che, in un certo senso, lei fu uno dei combattenti e forse il più temibile. E in ogni caso perché Menelao l’avrebbe ripresa senza farle pagare in alcun modo il tradimento? Qualcuno raccontò che lei gli mostrò il seno nudo, facendogli cadere la spada di mano. La causa fu un’altra, una causa tanto forte da spingere un re a mettere la sua regina nel letto di un altro uomo… per anni. Se pure anche questa non sia una verità incompleta e non nasconda un enigma dentro l’enigma.
Tuttavia quello sconosciuto, gettato dal mare sulle nostre spiagge, volle rivelarla a me… a un ragazzo, in parte raccontando ciò che personalmente aveva veduto, in parte ciò che aveva udito dire e in parte, io credo, ciò che gli stessi dèi gli avevano ispirato.
Forse pensava che nessuno mi avrebbe creduto o forse desiderava scaricare il suo cuore da un peso che non poteva più sopportare.
Ecco dunque ciò che egli raccontò. Che la dea ispiri il mio racconto e sostenga la mia memoria. Voi state per udire una storia quale non avete mai udito e che tramanderete ai vostri figli e ai figli dei vostri figli.
Per sette notti e per sei giorni bruciò la città di Ilio, bruciò la rocca superba e bruciarono le cinquanta stanze della reggia mentre i suoi abitanti, quanti si erano salvati dalla strage, venivano ammassati nel campo, come pecore nell’ovile. Là aspettavano di essere assegnati ai vincitori come preda di guerra. Le donne giacevano a terra con le vesti squallide e i capelli sciolti, senza più lacrime negli occhi. Quasi tutte erano spose o figlie di guerrieri troiani caduti nella notte del tradimento. Il loro destino era di servire le mogli dei vincitori e anche di salire, come concubine, nel loro talamo, essere possedute e violate, private di tutto, fuorché dell’amarezza dei ricordi.
I bambini piangevano, sporchi e affamati, giacevano a terra dove il sonno li coglieva e si risvegliavano piangendo di nuovo.
I capi, riuniti nella tenda di Agamennone, discutevano se si dovesse partire immediatamente o se l’esercito dovesse fermarsi per offrire sacrifici di espiazione per il molto sangue innocente versato. La vittoria che avevano desiderato per tanti anni non aveva recato loro la gioia che si attendevano. La preda era scarsa perché la città, esausta, aveva dato fondo a tutte le sue ricchezze, le atrocità commesse la notte della conquista avevano lasciato nel cuore di ognuno la cupa aspettativa di un castigo immancabile. Si sentivano come degli ubriachi che si risvegliano dopo una notte di gozzoviglie e hanno le vesti sporche e il sapore del vomito in bocca.
Sedevano in cerchio su sedili coperti di pelli: Ulisse, il vincitore, l’inventore della macchina che aveva ingannato i difensori. Per lungo tempo, dopo che il grosso dell’esercito aveva fatto irruzione in città, era scomparso e il comando dei suoi uomini, Itacesi e Cefalleni delle Isole occidentali, lo aveva preso Euriloco, suo cugino. Era riapparso all’alba, pallido e muto. Egli, l’eversore di città, non aveva preteso che una modesta quota della preda, cosa strana, essendo lui uno dei più poveri tra i re della coalizione, sovrano di isole rocciose e aride e, quel che più conta, avendo lui il merito completo della vittoria. In quel modo nessuno volle discutere né controllare cosa si nascondesse in quel piccolo bottino, così piccolo da non suscitare né la gelosia degli altri capi né l’invidia dei suoi uomini. E dopo tutto egli riportava in patria le armi di Achille che da sole valevano il prezzo di cento tori.
Ulisse versatile e scaltro! Ascoltava tenendo la sinistra sull’elsa della spada e la destra sullo scettro, ma non udiva nulla perché la sua mente labirintica seguiva sentieri a tutti nascosti.
Accanto a lui c’era il seggio, vuoto, di Aiace Telamonio. Aiace gigante, dallo scudo settemplice, mole smisurata, baluardo del campo e delle navi, l’unico dei capi che non avesse mai ricevuto in battaglia l’aiuto di un dio. Era morto di vergogna e di dolore gettandosi sulla sua spada perché Ulisse l’aveva privato dell’eredità più desiderata: le armi di Achille. Suo padre, che spingeva ogni giorno lo sguardo sulle onde dagli scogli della sua isola, lo avrebbe atteso invano.
Nestore veniva subito dopo, il re di Pilo, saggio consigliere dall’età avanzata ma a tutti sconosciuta, e poi Idomeneo, re di Creta, successore di Minosse, signore del Labirinto. Menelao sedeva a fianco del fratello, spossato da una notte di sangue, di morte e di delirio. Si dice che avesse posseduto Elena nel talamo di Deifobo, suo ultimo marito, l’avesse goduta in un letto pieno di sangue, a fianco del cadavere straziato del principe troiano. Ma quella fu una notte di inganni…
Aiace Oileo, Aiace minore, sedeva con la fronte aggrottata e le mani strette fra le cosce. Quella notte aveva stuprato la principessa Cassandra nel tempio di Atena. E la dea, inorridita, aveva chiuso gli occhi per non vedere l’abominio. Egli l’aveva inchiodata al suolo, le aveva strappato le vesti, l’aveva penetrata come un ariete, come un toro selvaggio. Per un attimo solo aveva incontrato il suo sguardo e in quel momento aveva capito che la principessa lo aveva condannato a morte, morte orribile e certa.
Agamennone l’aveva poi presa per sé. Lei sola conosceva il segreto che stava a cuore al re di Micene. Ma egli, il Grande Atride, sogguardava Aiace con sospetto perché era stato solo per primo con la principessa troiana.
Ultimo veniva Diomede figlio di Tideo, re di Argo, colui che aveva conquistato Tebe dalle Sette Porte. Dopo la morte di Achille nessuno lo emulava per valore e coraggio. Era entrato nel cavallo assieme a Ulisse e aveva combattuto tutta la notte cercando l’unico avversario troiano rimasto che fosse degno di lui, Enea. Ma il principe dardano sembrava scomparso. Diomede era penetrato nella cittadella sul far del mattino ed era scomparso in uno dei suoi passaggi segreti. La sua armatura era piena di polvere e il cimiero del suo elmo era sporco di ragnatele. Ed egli guardava con sospetto Ulisse dai molti inganni perché loro due soli, fra tutti gli Achei, erano penetrati nella città prima che cadesse per l’inganno del cavallo. Vi erano penetrati travestiti da prigionieri troiani, sporchi di polvere e di sangue. Loro due soli conoscevano i passaggi nascosti della cittadella.
I capi discussero a lungo ma non riuscirono a raggiungere un accordo. Nestore, Diomede, Ulisse e Menelao decisero di partire comunque: Agamennone e gli altri restarono per offrire un sacrificio di espiazione per propiziarsi il ritorno. Questo almeno fu ciò che si disse, ma forse la causa fu un’altra. Agamennone fu visto penetrare con Cassandra fra le rovine ancora fumanti di Ilio alla ricerca del solo tesoro che gli interessava, l’unico per cui la guerra era stata realmente combattuta.
All’isola di Tenedo la flotta che aveva salpato si fermò per la notte. Il giorno dopo Ulisse si pentì di essere partito; disse che Agamennone aveva ragione e che era giusto celebrare un sacrificio di espiazione. Tornò indietro benché tutti gli chiedessero di non farlo e i suoi stessi compagni lo scongiurassero di non riportarli su quelle spiagge maledette dove tanti dei loro erano caduti. Fu tutto inutile. La flotta itacese tornò indietro a forza di remi e col vento al traverso fra onde nere e alte che il vento settentrionale faceva ribollire di schiume livide. Ulisse, ritto a poppa in un nembo di spruzzi, reggeva personalmente il timone della sua nave: da allora nessuno lo vide più.
Si disse che fosse tornato, nel cuore della notte, al lido presso il quale gli Achei avevano innalzato un tumulo sulle ossa di Aiace e, spinto dal rimorso, mentre il cielo era squarciato dalle folgori e le montagne squassate dai tuoni, avesse deposto sull’ara votiva le armi d’Achille, troppo tardi, se pure fosse stato vero, perché ai morti non giovano le azioni dei vivi. Essi piangono per sempre la vita perduta e vagano nelle case oscure dell’Ade ricordando la luce del sole che non vedranno più.
In realtà io credo che egli si fosse reso conto di essere stato ingannato, una cosa insopportabile per lui. L’uomo più astuto della terra doveva assolutamente togliersi dalla mente ogni dubbio. Per questo aveva sfidato il vento contrario e le onde di una tempesta imminente.
So per certo comunque che gli altri compagni rimasti con l’Atride sulla spiaggia di Ilio non lo videro, né videro i suoi guerrieri cefalleni: quando lui sbarcò Agamennone era già ripartito e, in seguito, non ebbe più modo di raggiungerlo. Forse aspettò troppo a riprendere il mare e dovette combattere i venti avversi della cattiva stagione o un dio invidioso della sua gloria sospinse la sua nave verso l’Oceano senza vento e senza onde, oppure lo tenne prigioniero da qualche parte.
Il primo fra i duci achei a pagare gli eccessi compiuti nella notte maledetta della caduta di Troia fu Aiace Oileo. La sua nave fu presa da un fortunale, s’incagliò sulle rupi Ghiree e si spaccò in due. I suoi compagni furono subito sommersi dalle onde del mare in tempesta ma Aiace era un formidabile nuotatore. Aggrappato a una cassa di legno combatté con la forza dei flutti e riuscì a mettersi in salvo issandosi su uno scoglio assieme alla cassa che non aveva mai abbandonato. Di là, stando seduto su quella, bestemmiava gli dèi dicendo che egli possedeva una forza invincibile e che nemmeno Poseidone poteva sconfiggerlo. Il dio del mare lo udì e salì dalle profondità dell’abisso impugnando il tridente. Con un colpo sbriciolò lo scoglio durissimo: Aiace precipitò fra i massi e fu maciullato come grano nella macina. Per un attimo le sue urla di dolore superarono il fragore della bufera poi furono disperse lontano dal vento.
Gli altri capi riuscirono in qualche modo a sfuggire alla tempesta e, giunti a Lesbo, tennero consiglio se navigare sopra Chio verso l’isola Psiria tenendola a sinistra, o sotto Chio, doppiando il promontorio Mimante. Alla fine decisero di tagliare a mezzo il mare in direzione dell’Eubea, per la via più breve. Ma durante il viaggio, benché il mare si fosse appianato e il tempo fosse calmo e la temperatura mite, Menelao scomparve in una notte senza luna con tutte le sue navi. Di lui e di ciò che gli accadde vi dirò più oltre.
Nestore giunse salvo al Pilo sabbioso con gli uomini, le navi e il bottino dopo aver doppiato il capo Malea. Regnò ancora per anni sul suo popolo, onorato dai figli e dalle nuore.
Ben diversa sorte toccò al figlio di Tideo, Diomede.
Trasse in secca le navi sulla spiaggia di Temenion mentre la notte era a mezzo del suo corso. Nessuno sapeva del suo arrivo, non aveva voluto mandare avanti un araldo ad annunciarlo. Si ricordava infatti di un avvertimento di Ulisse: «Non fidarti» gli aveva detto «quando tornerai, di nessuno. È passato molto tempo, molte cose sono cambiate, forse qualcuno ha preso il tuo posto e trama contro di te. E soprattutto, anche se per te è doloroso, non fidarti della tua regina».
Partì con Stenelo, il suo amico inseparabile, e giunse a notte inoltrata nei pressi del suo palazzo a Tirinto. Non lo vedeva da dieci anni e gli parve cambiato, anche se non avrebbe saputo dire come. Provò comunque una forte emozione nel contemplare le mura della cittadella che si dicevano costruite dai Ciclopi, le porte del suo palazzo vigilate da guardie armate. Le osservò: erano bambini quando lui era partito e ora erano nel fiore della gioventù e del vigore.
Lasciò Stenelo con i cavalli in un luogo fuori vista ad aspettarlo ed egli entrò da un passaggio che solo lui conosceva, la postierla nel lato meridionale delle mura ostruita dal fango portato dalle piogge e dalle radici delle piante che vi si erano insinuate in tanti anni in cui nessuno l’aveva usata. Era infatti un passaggio che collegava la cinta esterna alla cinta del palazzo e serviva, in tempo di guerra, a fare sortite alle spalle del nemico. Man mano che avanzava si sentiva mancare il respiro per l’emozione e per il senso di oppressione che quel luogo gli procurava. Ben diverso l’aveva immaginato il suo ritorno: il popolo in festa che gli correva incontro lungo la strada, le sacerdotesse di Hera che spargevano fiori davanti al suo carro, ma soprattutto Egialea, la sua sposa, che gli apriva le braccia e lo prendeva per mano per condurlo nel grande talamo profumato per godere dell’amore con lui, dopo anni di desiderio e di lontananza.
Egialea… per quante notti l’aveva sognata giacendo nella sua tenda nella piana di Ilio. Nessuna donna mai, nemmeno le più belle prigioniere, ...