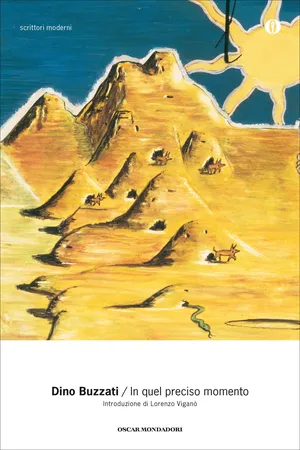![]()
LA FORMULA. Di chi hai paura, imbecille? Della gente che sta a guardare? Dei posteri, per strano caso? Basterebbe una cosa da niente: riuscire a essere te stesso, con tutte le stupidità attinenti, ma autentico, indiscutibile. La sincerità assoluta sarebbe di per se stessa un documento tale! Chi potrebbe muovere obiezioni? Questo è l’uomo, uno dei tanti se volete, ma uno. Per l’eternità gli altri sarebbero costretti a tenerne conto, stupefatti.
NON SIAMO PIÙ GIOVANI. Non siamo più giovani, o signori, né Marco né Attilio né Giovanni né Federico né io, qui presenti, senza vanteria possiamo dirlo. Altri vengono avanti e a poco a poco ci portano via le cose ch’erano così nostre. Per esempio: i progetti meravigliosi, il presentimento degli oceani, l’immensità del mondo, gli amori impossibili, la gloria. Anche il mattino ci hanno portato via, quella freschezza! Anche il tramonto con le sue nostalgie, e le sue musiche, che pure ci era utilissimo. Il turno è finito, è vero, ma non è ridicolo vedere i nuovi come le spadroneggiano, quasi le avessero inventate loro? Avanti, avanti! Non abbiamo più sogni per le età venture, non desideri di conquista, non attesa di belle donne, non abbiamo più fretta. Nudi e crudi come si è partiti, pressappoco, i signori possono salire sul palcoscenico a controllare coi loro occhi. Non siamo più giovani, perdio, ci verrà lasciata, spero, questa consolazione. Ciò che ci riuscirà di fare sarà dunque al netto. I migliori utensili abbiamo dovuto passarli ai nuovi arrivati, ormai lavoriamo soltanto con le nostre vecchie mani, col fiato nostro, col sangue.
Col sangue che tenevamo da conto per esplorare i deserti e l’Imalaia ma che oggi possiamo consumare. Non spaventarsi però per quello che ne potrà uscire. Non dire: ah, ma con questo sistema sono buoni tutti. Non dire: bella scoperta! Ci è tolta ormai la possibilità di fare gli eleganti. Dunque, con la ingrata volgarità nostra quotidiana passiamo, o signori, a incominciare.
LE FINESTRE ACCESE. Tornavo una notte alla vecchia casa e dal fondo della strada vidi la camera illuminata. Chi poteva essere, mi chiesi, a quell’ora? Avanzavo lentamente per la via, poiché ero stanco, e pensavo allo strano lume. Era accesa la lampada centrale, lo si vedeva benissimo, nella mia stanza da letto; e, se nulla era mutato, la luce doveva arrivare fino a metà delle pareti, lasciando nella penombra gli ultimi ripiani della libreria, con i volumi rari.
Oh, non dovevano essere i ladri. I ladri accendono soltanto le luci minori e certo non avrebbero alzato le persiane scorrevoli perché i vigili notturni si accorgessero della loro venuta. E poi era una notte quieta e buona, per nulla propizia alle avventure.
Ma qualcuno era. Forse un amico, salito fin lassù ad aspettarmi, dopo essersi fatto aprire dalla portinaia? O dall’Oriente era tornato mio fratello e adesso sotto la familiare lampada sedeva pensieroso trovandosi in mezzo alle cose nostre, ai mobili ben conosciuti e sicuri, vicino ai libri letti con amore da entrambi, e qui egli trovava di aver scritto il suo nome a matita, qui una pagina era stracciata, dove la mano sua sette anni prima, a metà lettura, era stata colta dal sonno? O forse vegliava la mamma venuta apposta da lontano a mettere in ordine la stanza per il mio ritorno? E lei sentiva i miei passi che si facevano sempre più vicini e aveva paura di non fare in tempo, perché mancavano al letto le coperte pesanti per questa fredda stagione, il bicchiere d’acqua sul tavolino e quattro caramelle perché io, trovandole, pensassi un momento a lei?
Chi mi aspettava, a un’ora così tarda, nella grande città, me che tornavo stanco e solo? Chi pensava a me, nel silenzio della casa notturna, sotto il rotondo paralume che aveva visto tanti giorni felici?
Ora io ero giunto vicino e vedevo distintamente le mie due finestre. La luce le riempiva, quieta e paziente, senza oscillazioni, ad indicare che il sonno là dentro non era ancora entrato.
Poi le persi di vista perché ero entrato nell’androne d’ingresso e salivo le umide scale. Frontini, Storner dentista, Andrioli, era sempre scritto sulle targhette di ottone delle porte, come se tanto tempo non fosse passato. E c’era sempre lo zerbino arrotolato al secondo pianerottolo, sempre quella bieca ragnatela al finestrone verso il cortile.
Entrai nell’appartamento, trovai il silenzio, udii risuonare sordamente i miei passi, con l’inospitale eco delle case disabitate. Nella mia stanza non c’era anima viva, nessuno seduto sotto la lampada, proprio nessuno c’era ad aspettarmi, compresi che ero stato io a dimenticare accesa la luce; ero fuggito, mi ricordai, prima dell’alba, senza neppure abbassare le persiane, sulla spalliera di una sedia pendeva ancora un asciugamani che avevo gettato là all’ultimo momento, le scarpe smesse la sera prima buttate vicino al letto, portavano ancora il fango e la polvere delle ultime ore di giovinezza. Era scesa la polvere a dare un tono di solitudine, ma il resto era rimasto uguale.
Povera stanza, lei non aveva dormito, con la luce in mezzo sempre accesa, chissà quante interminabili notti ad aspettare che io tornassi, e i moschini instancabili attorno alla lampadina da cento candele. Le ombre non si erano mai mosse di un millimetro negli angoli soliti, fino a che ogni mattina la luce del giorno le assorbiva. Immutato il disordine della precipitosa partenza, tutto in sospeso, niente aveva potuto riposare, da un momento all’altro io dovevo essere di ritorno, e intanto sono passati quattro anni, quattro lunghi anni della breve vita.
CONGEDO DALLA NAVE. La mia nave è partita ieri mattina e già molte cose, che per un anno intero hanno nutrito la mia vita, si sono fatte un poco lontane. Con una sottile angoscia io penso che la mia nave, gli uomini, le abitudini, la posizione delle scale e delle porte, le comodità e i fastidi, i rumori, gli odori, le facce, le voci del bastimento, tanto a me familiari da costituire lo sfondo della mia esistenza per così lungo tempo, queste cose amate, che un giorno mi parlarono di avventura, spensieratezza, amicizia, andranno dentro di me perdute. La mia memoria è misera, io mi conosco. Dopo pochi mesi i nomi oggi intimi, istintivi, che suppongo non dimenticherò mai come quelli dei miei parenti, questi nomi in gran parte saranno affievoliti, molti svaniti addirittura e inutilmente cercherò di ripescarli nel fondo della mia coscienza.
Questa cosa bella dunque scomparirà. Lo dico senza convinzione, oggi, eppure è certo che sarà così. E voglio ripeterli stasera, prima che sfuggano, tali nomi. Arena, De Sanctis, Padalino, Lambiase, Pedemonti, Schiroli, Majorana, Bagnoli, Greffi, Cappello, Masumeci, Ingrassia, Nelli, Notarbartolo, e Cappellini bey, e Raiani e il suo sostituto Vanzini, Lubrano, Boccuni, Passatempo, Somaini, Innamorati, Campari, Romano, Mezzetti, Falco, Argentero, Vesco, Cossetto, Rizzi, Mayol, che sonno, che sonno! Vorrei scrivere, in modo da poterle esattamente ricostruire nella mente, le minime particolarità della nave, la porta stagna, l’interruttore, il chiodo sul pavimento, i cassetti del mio camerino. Ma è una cosa assurda, lo so, non ci riuscirò mai. E un bel giorno, guardandomi indietro, di tutto questo vastissimo mondo non troverò che poche cose, pochissime, ruderi emergenti dalle sabbie.
Che cosa abbandonerà per prima la mia memoria? Chi per primo uscirà dalla scena ancor così viva e brulicante di personaggi? Non me ne accorgerò di certo. Di notte, durante il sonno, cose e uomini sgusceranno fuori di me ad uno ad uno, e io non ne saprò niente. Soltanto dopo mesi, o anni, una sera, preso da nostalgie, farò una specie di appello. Chi risponderà? Oh, pochi, pochi. Così compiendosi la solitudine dell’uomo.
GENNAIO 1944. Un giorno lontano, ti ricordi?, hai aperto una porta che sapevi di non dover aprire. Una questione di pochi secondi. Poi hai continuato la tua vita tranquilla e quel fatterello da niente è scomparso dietro di te con le altre infinite cose che si possono dimenticare senza pericolo. Un niente insomma concedesti al demonio, proprio una sciocchezza, poco più di un pensiero. Tuttavia apristi una porta che sapevi non era bene aprire. E ti sei rovinata la vita.
Tu dici: “In fin dei conti non è stata che una debolezza, una curiosità senza malizia, sapevo sì che era proibito ma pensavo proibito così, genericamente, ce ne sono tanti di divieti che trasgrediamo tutti i giorni. E poi dietro la porta non c’era niente, giuro che non c’era assolutamente niente, una stanza vuota senza neppure una sedia”. Con questi e altri pretesti cerchi ora di giustificarti ma intanto sei impallidito e balbetti.
Perché talora nella vita si compie la giustizia e se l’uomo dimentica facilmente ed è incline a ricordare di sé soltanto ciò che gli fa onore, ci sono tuttavia dei libri dove è registrato tutto, ogni attimo della nostra esistenza, cosicché ci possa essere dato fino all’ultima moneta quello che ci si merita.
Tu hai aperto l’uscio per un attimo di debolezza, un’inezia ridicola, verrebbe fatto di dire. Ma questo piccolo niente il demonio l’ha messo da parte, apprezzandone il valore da quel buongustaio che è. L’ha poi coltivato con amore, l’ha nutrito perché aumentasse di peso, l’ha mantenuto vigoroso e fresco per anni, mentre tu, non pensandoci, te ne andavi a spasso convinto di essere innocente.
Ed ecco lui viene a riscuotere. Poiché non è detto che aspetti a farsi pagare all’ultima scadenza; molte volte regola i suoi conti prima, mentre l’uomo preme ancora la polvere di questa terra. Ora tu ti volti indietro, smarrito, e gli indichi la strada da te percorsa, la quale apparentemente è diritta e pulita, a testimonianza che sei in regola. Lui sorride, scuotendo le corna. In un giorno lontano tu hai aperto una porticina sapendo che era vietato. E hai firmato la tua condanna. Per quella inezia? Per quella stupidaggine? dici tu. Bastava.
UNA FOTOGRAFIA DI RAGAZZA. Ho una sua fotografia, fatta per caso da uno di quei giovanotti che, la Leica alla guancia, appostano i passanti sui marciapiedi del centro (e poi consegnano uno scontrino con l’indirizzo della ditta).
È riuscita molto sincera, di una verità stranamente profonda. La testa eretta, ella cammina fieramente, il braccio destro abbandonato a piombo per il peso della grande borsa di pelle, la sinistra portata un poco avanti, nel movimento del passo, con la mano sottile anche essa dimenticata. Tutta la sua vita sembra invece concentrarsi nella volontà di avanzare. Ma dove? Gli occhiali scuri le nascondono gli occhi, la bocca è appena appena socchiusa. C’è qualcosa di stanco, viene in mente un automa governato da un pensiero. Si direbbe che dinanzi a lei (ma nella fotografia non possiamo vedere perché ella ci viene incontro), che dinanzi aprasi una via sterminata e in fondo a questa un miraggio che non so e che la chiama.
Il fotografo per un curioso miracolo l’ha sorpresa in uno dei rari momenti, forse il solo, di una sua certa grandezza. In quel passo orgoglioso una fatalità romanzesca sembra sostenerla, e non speranze bensì la semplice curiosità dell’opaco futuro trarla a fatti senza rimedio.
E si direbbe che lei dentro a sé indovini tutto questo e sappia dove porti la via – dopo brevi finti splendori trovarsi malata, sfinita e sola in mezzo all’avidità del mondo – ma ugualmente avanzi imperterrita, giocando per una bizza di donna l’intera vita.
Doveva essere mattina, a giudicare dalla luce; ora lontana di Napoli che mai si ripeterà. Come eri tu in quell’istante! Inconscia di bene o di male, perduta dietro a qualche tuo calcolo o menzogna, e non volevi credere; eppure te lo dicevano che è difficile camminare a lungo così, in balia della sola giovinezza.
Mai ti ho conosciuto così bella, e sì che ci siamo visti abbastanza. Certo non pensavi a me né a questo né a quell’uomo. Forse, invece, a un vestito nuovo, o alle scarpe che ti facevano male. Sopra queste miserie c’era però qualcosa di più grande che ti trasformava; tutto il destino tuo, infelice, stava celebrando l’unico possibile amaro trionfo: quello di andare con tanta cieca sfrontatezza verso la malora.
Ma è tardi, parecchi mesi intanto sono passati. Tu sei improvvisamente scomparsa e le mie parole non ti dicono niente, hai preferito proseguire da sola con quel passo disdegnoso, diritta dinanzi a te, non importa se le case da una parte e dall’altra si faranno sempre più miserande ed infette. Tu sei lontana, adesso, io non so neppure dove. Cammina, cammina, allora, come in quel giorno meraviglioso. La fotografia dal punto di vista tecnico non è proprio niente di straordinario però è piena di significato e patetica. Inoltre mi ricorda tempi ormai lontani. E io ogni tanto la guardo.
LA CALATA DEGLI UNNI – FEBBRAIO 1944. Li aspettavo con odio. Ma quando apparvero al fondo della via sui loro cavalli bianchi, sorridenti e piumati, il mio animo si contristò. Essi erano giovani e belli, si guardavano intorno con occhi buoni, salutavano i bambini, e alle donne comparse ai davanzali chinavano il capo con gesto pieno di civiltà e di rispetto. Li guardavo avidamente, mentre si avvicinavano alla mia casa, sperando che quella fosse tutta una maschera per coprire i loro mali. Osservavo le loro facce, le pieghe delle labbra, le mani, se fossero grossolane e volgari, ascoltavo i loro discorsi. Nulla di brutto essi tradivano. Cosicché quando essi bussarono alla mia porta e dicendo di essere stanchi chiesero di poter dormire, mi uscirono di mente le scuse da tempo preparate e, vinto, li invitai ad entrare. Si mostrarono grati, non facevano chiasso, non lordavano il pavimento, non pronunciavano parole sconce, non si ubriacavano. Disposero ordinatamente i loro bagagli nelle stanze destinate, si ripulirono, uscirono per i loro uffici.
Con ostinazione intanto io li andavo studiando da vicino, se mai venisse fuori da loro ciò che pensavo. Invano. Essi mi disarmavano con la modestia e la nobiltà d’animo, più di una volta fui costretto a unirmi alle loro franche risate, la sera, dinanzi al vino. Che distanza immensa tuttavia ci separava. Io dovevo ammirarli, riconoscere la loro forza, precisione, ricchezza, larghezza magnanima; miravo le lucenti corazze e le spade preziose, preziose due volte nelle loro mani; non con la violenza del braccio bensì con la giustizia e la fedeltà alle armi essi ci superavano, chiudendo le nostre bocche. La sera si ritiravano presto per non dare disturbo e in breve si addormentavano dolcemente. Più alti di noi erano, assai più alti, più belli. Eppure non cessavo di scrutarli, fisso nel mio sospetto, sembrandomi assurdo ch’essi fossero realmente ciò che apparivano. Si dominavano – tale il mio dubbio – controllavano ogni gesto e parola per non tradirsi, ma questo non poteva durare.
Ed ecco un giorno vidi uno di loro (ero nascosto dietro una tenda) sputare con violenza sul muro. Non fece altro di sconveniente, ma io respirai come liberato. Era la prima volta. Da allora la mia vigilanza si è raddoppiata. Strisciando in silenzio, non cessavo un istante di controllarli. In tal modo, attraverso un lungo periodo, confermai il mio vecchio pensiero. Vidi uno di loro battere sulla faccia un bambino che ingombrava la via e non si era prontamente scostato. Altri ne vidi gettarsi, credendosi soli, sulle vivande con avidità bestiale e schioccare con alto suono le bocche ricolme di cibi. Altri ancora gettare ai cani i resti delle mense mentre alcuni randagi, consumati dalla fame, li guardavano con desiderio, umilmente accucciati ai loro piedi. Altri infine trafugare dalle ville altrui oggetti ed arredi. Bene! Casi rarissimi però, che non turbavano il nobile aspetto della loro esistenza.
Non turbavano lo splendore del loro dominio, però l’incanto era finito. Ora io ho cessato...