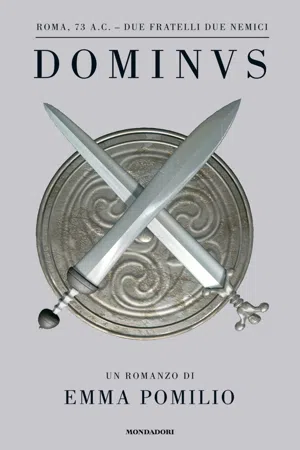![]()
Capitolo I
Gallia Comata, 662 ab Urbe condita (91 a.C.)
Tara scese al fiume a fare il bagno in un posto che credeva di conoscere solo lei, una piccola riva sassosa nascosta da folti cespugli, dove l’acqua era limpida. Ma tra le fronde quattro paia d’occhi la osservarono mentre si spogliava ed entrava nell’acqua fredda rabbrividendo e stringendosi le braccia al seno.
«L’informazione era buona» disse un uomo che teneva tra le mani una rete e una corda «ed è costata solo un’anfora di vino. E io che non volevo credergli, a quell’ubriacone...»
Tara nuotò a lungo e finalmente riemerse coi lunghi capelli sgocciolanti aderenti al corpo.
«È la dea del fiume... ohh i miei poveri occhi mortali s’accecheranno» mormorò uno dei quattro che teneva pronto un bavaglio.
«È degna di un re... un giorno anch’io ne avrò una tutta mia» disse un terzo con un’espressione sognante e grottesca sulla faccia brutale.
«Tu non sei un re, sei una bestia... in mano tua...»
«Sst... state pronti» bisbigliò quello che era stato zitto e che era il capo. «E piantatela coi sogni, questa è roba da ricchi.»
Fu lui a uscire lentamente dai cespugli e, camminando su qualche rada zolla erbosa, ad arrivare dietro alla ragazza che si rivestiva. L’afferrò e le premette una mano sulla bocca. Anche gli altri si avvicinarono e uno fu svelto a infilarle in bocca il bavaglio al suo tentativo di urlare, un altro cominciò a legarle le mani con la corda.
«No» disse il capo, «usa questa pezza di cotone, vista da vicino è ancora più bella e si difende come una tigre, con la corda si rovinerebbe i polsi. Vale più lei che tutto il resto del carico.»
La chiusero in un sacco e la trasportarono poco lontano, fino a un carro nascosto nella vegetazione, coperto da cuoio robusto inchiodato. La tolsero dal sacco e la spinsero dentro ancora legata e imbavagliata. Quando gli occhi si furono abituati alla penombra, Tara vide chi emetteva i gemiti di paura che laceravano l’anima e toglievano le speranze: erano altri ragazzi legati e imbavagliati seduti e appoggiati alle sponde, maschi e femmine. Gli occhi spalancati per il terrore erano tutti azzurri, cerulei, i ragazzi presentavano i caratteri dei popoli del nord. Tara comprese che l’avevano scelta per questo. Sarebbe finita in un luogo abitato da un popolo dagli occhi scuri. Il puzzo di orina faceva lacrimare. L’aria d’attesa era palpabile. Fu gettato dentro un altro ragazzetto, il carico era completo. I mercanti obbligarono i ragazzi a bere molta acqua, riposizionarono i bavagli, fecero balenare le lame dei pugnali vicino ai volti dei più ribelli intimando il silenzio e occultarono il carico umano con paglia e anfore vinarie vuote e ceramiche da tavola. Il lungo viaggio sui valichi alpini cominciò. Tara credeva di soffocare sepolta per ore sotto il peso delle anfore, mentre minuscole pagliuzze le si infilavano nel naso. All’arrivo in Italia le condizioni della prigionia migliorarono. I ragazzi furono slegati e fatti scendere spesso e nutriti bene, non si rifiutavano di mangiare, erano giovani e affamati e non del tutto consapevoli del loro destino. Ma Tara era tra i più grandi di età, fu presa dalla disperazione quando vide un paesaggio del tutto nuovo; suo padre non l’avrebbe ritrovata più. Rifiutò il cibo e un mercante la picchiò con un bastone ricoperto di cuoio, che le fece molto male senza lasciare segni sulla pelle. Tara non cedeva. I mercanti di schiavi sanno però come convincere, conoscono la loro merce, è un bestiame particolare quello munito di parola. L’uomo cominciò a colpire un ragazzetto esile e delicato al posto suo e Tara mangiò.
Tra le strade di una città senza fine, che metteva paura per l’imponenza degli edifici e l’enormità della folla vociante, il destino dei piccoli barbari si divise, alcuni di minor valore furono lasciati al mercato degli schiavi, vicino al tempio di Castore. Là Tara seppe di essere arrivata a Roma, la città delle città, suo padre gliene parlava sempre con un certo timore. Roma avrebbe conquistato anche la loro terra se il loro popolo non si fosse agguerrito di più, le diceva. Fu trascinata tra i vicoli intorno al Foro fino a una bottega. Il portone massiccio la inghiottì. Una vecchia la prese in consegna, la portò in un bagno e la osservò sotto la luce a quadri di una grata. Sembrava soddisfatta, cominciò a strapparle di dosso i panni lerci. Rise delle sue resistenze.
«Sei una schiava adesso. Sei solo un corpo senz’anima. Senza pudore. Il pudore è delle donne libere.»
Tara non la capiva, continuava a schermirsi, a tenersi stretti addosso i vestiti puzzolenti. La vecchia aveva esperienza di ragazze come lei, dimostrò una forza insospettabile, e le strappò di dosso ogni lembo di stoffa, poi sembrò addolcirsi per un attimo.
«Sei fortunata» disse, esaminandola e frugandola dappertutto con gli occhi e con le dita, «sei molto bella, se saprai sfruttare la bellezza avrai una vita buona. Non capisci nulla di quello che dico, fu così anche per me, ricordo quando mi presentarono sulla pedana, ero terrorizzata da tutte quelle facce e da tutte quelle mani. Ma non preoccuparti, ti abituerai, e sei a Roma, oggi un ricco ti comprerà.»
Le parlava per calmarla, ma le parole sconosciute non calmavano Tara, che da quando era piccola udiva racconti raccapriccianti su giovani rapiti dai mercanti di schiavi. La vecchia la immerse in una tinozza d’acqua caldissima e la strofinò con uno straccio ruvido per far affiorare la luminosità della pelle; ai capelli dedicò la massima cura, li tamponò con una salvietta imbevuta di olio profumato e li spazzolò fino a farli crepitare. Poi prese una tavoletta con polveri da trucco di varie gradazioni e tentò di combinare dei colori adatti a lei, ma cambiò idea. Quella era una bottega per gente raffinata.
«Sei bella così» disse, «ogni tentativo di abbellimento da parte mia ti renderebbe volgare», soltanto le pizzicò le guance pallide per farle diventare rosee, ma infine si decise a mascherare il suo pallore cadaverico con un po’ di rosa.
Le segnò i piedi con gesso, per far vedere che era venduta per la prima volta e aggiunse dei segni che rivelavano che alle sue esplorazioni la ragazza era risultata vergine. La trascinò nuda in una stanza accanto, dove poche persone di grandi possibilità, munite di un invito, sedevano chiacchierando e consumando frutta secca in attesa di trovare un giovane schiavo che accendesse il loro interesse. Tara fu afferrata dai servi e costretta a salire sulla pedana e a scostare le braccia con cui si proteggeva il seno.
Piacque subito, i presenti si affollarono. Mani esperte la toccarono e la frugarono. Occhi da intenditore esaminarono i suoi denti. L’asta cominciò e alla fine rimasero due contendenti. Il proprietario di un bordello di lusso e Milone, lo schiavo di fiducia del nobile Caio Cedicio. Milone non toccò la ragazza, si fidava del compiacimento che aveva visto sui volti di chi l’aveva fatto. Infine il ruffiano si ritirò e rimase Milone, vittorioso in nome di Caio Cedicio. Un amministratore che lo seguiva sborsò i soldi, anche se con poco entusiasmo, era una cifra grossa, la più alta in tanti anni, ma Milone era sicuro di aver concluso un ottimo affare.
Intenerito dalle lacrime di umiliazione che le rigavano la faccia, Milone coprì Tara con gentilezza col suo stesso mantello e la condusse via cercando di toccarla il meno possibile, ma parlandole con cortesia distaccata che lei apprezzò. «Sei fortunata» le diceva, «tutto questo finisce, entri in una casa dove gli schiavi che ubbidiscono al padrone possono avere una vita decente. Ma il padrone ha tanti impegni... vedrai, se ti comporterai bene, avrai il tuo angolino privato con le tue cose e i tuoi sogni e qualche ora per te. Sarà questa tutta la libertà che ti verrà concessa.»
Tara non capiva niente di quello che lui le stava dicendo, ma in quel momento cominciò un rapporto di stima reciproca che sarebbe durato tanti anni; era l’affinità di due persone molto diverse che conservavano nell’anima la memoria viva del passato e l’orgoglio di appartenere a una grande stirpe.
Roma, 663 ab Urbe condita (90 a.C.)
Un ragazzino si avvicinò con aria furtiva alla porta dello studio, se ne stette fermo, incerto, con una mano tesa un po’ tremante, davanti a un tavolino carico di oggetti di bronzo. Qualcuno alle sue spalle intuì che stava calcolando quanto rumore avrebbe prodotto quel pesante metallo rovinando sul pavimento di marmo.
«Tu, biondino. Che credi di fare?» Il ragazzino si sentì afferrare per le spalle da due mani forti e si trovò di fronte la faccia dura di Milone. «Lui si dedica agli affari. Non è questo il momento per attirare la sua attenzione, e non è questo il modo.»
Menodoto era un tenero adolescente, drappeggiato in un rettangolo di lino fine alla greca, che gli lasciava una spalla scoperta. Sorrise a Milone, per tentare di accattivarselo. Milone aveva raggiunto, in mezzo a mille incertezze, un perfetto equilibrio per uno schiavo. Serviva fedelmente il padrone, ma con estrema dignità, col proposito di non fargli mai dimenticare che era nato greco e aristocratico. Si intenerì, scrutato dagli occhi del ragazzo che niente poteva attendersi dalla vita se non essere un servo gradito ai padroni, per lui così giovane provava una pena ancora più grande che per sé. Ma in fondo agli occhi franchi di adolescente vide solo stoltezza e arroganza, che ebbero l’effetto di esacerbare le sue incertezze. Menodoto, greco e di origine aristocratica anche lui, si concedeva al padrone di sua spontanea volontà, in cambio di che poi... di una pezza di lino fine, di una pietanza ricercata... Si pavoneggiava di fronte agli altri schiavi quando il padrone lo rendeva partecipe del suo lusso. Milone si sentì in qualche modo associato a lui e umiliato insieme a lui. Ma che poteva fare? Solo dargli qualche consiglio pratico per facilitare la sua vita di servo.
«Un amante invadente può stancare anche il più innamorato degli uomini, non devi essere tu a proporti, è il padrone che deve cercarti... se ti vuole. Credi che lui non sappia che ci sei? E tu stai sempre pronto e ricordati che a nessuno è permesso turbare la pace di questo luogo caro al padrone.»
«Gli piaccio così» disse Menodoto, divincolandosi.
«Te l’ha detto lui? L’amante giura eterno amore... ma non mi sembra che richieda più molto la tua compagnia. E adesso sparisci... via, vattene, ho detto.»
Le mille ombre sbiadite del crepuscolo si dileguavano tra le colonne, i cespugli, le statue. Con la faccia indecifrabile, covando l’umiliazione nel cuore, Milone percorse in lungo e in largo il giardino, a controllare ogni posto dove si sarebbe fermato lo sguardo del padrone. Ordinò a un valletto di pescare le foglie morte nella grande fontana che si vedeva in lontananza dall’atrio. Al centro della fontana barre metalliche sommerse sorreggevano una statua di donna a grandezza naturale di marmo rosa, che camminava leggera a pelo d’acqua coi piedini minuscoli, sullo sfondo di una rupe nera concava. Quieta, inconsapevole della sua nudità, stringeva tra le braccia un’anfora e guardava assorta cogli occhi di diaspro il rivolo perenne che ne sgorgava, simbolo della ricchezza inalterabile dei Cedici. Il padrone indugiava spesso a contemplarla, seduto sul bordo di pietra.
La grande fontana alimentava un ruscello, che gorgogliava tra rapide di rocce colorate e andava poi a riposarsi in uno stagno coperto di ninfee. Milone si incamminò per i viottoli, tra le bordure fiorite, controllando che il valletto pulisse il sentiero che il padrone avrebbe percorso nell’andare a cena, e anche il ruscello, e preparasse il cibo per i pesci a portata di mano su un muretto.
Ispezionando il portico che circondava l’intero giardino, rassettò i cuscini e i drappi e lo sguardo gli cadde più a lungo del solito sugli affreschi. I colori vivaci calamitarono la sua attenzione. Con un certo interiore sussiego in tanti anni non si era mai soffermato su quel succedersi infinito di scene erotiche, e, anche se spesso venivano rinnovate, non era mai preso dalla curiosità, le considerava volgari scopiazzature della sua cultura superiore, in qualche modo cercava di difendere il suo amor proprio mantenendo le distanze dove poteva. Ma, in quel momento di crisi e di vulnerabilità provocata da Menodoto, per un attimo la sua corazza si squarciò, si trovò indifeso e, stupito e imbarazzato, fu costretto a riconoscere che la ninfa che si cullava nuda sull’acqua dentro una grande conchiglia, il corpo morbido abbandonato, la posa sensuale, lo sguardo malizioso, era il prodotto di una mano felice. Così i satiri pelosi che rubavano l’amore di ninfe recalcitranti dal sorriso furbesco sulle rive di un fiume, così gli efebi e le fanciulle e tutti i numerosi personaggi. Quell’eros gaio e spensierato era gioco, gioia di vivere che metteva allegria. E comprese solo in quel momento, dopo tanto tempo, meravigliato e ancora più umiliato, che il vero motivo conduttore dei dipinti non era l’eros, ma l’acqua, che infonde calma e serenità. Come ogni cosa nel giardino, anche le pitture rivelavano il desiderio di armonia e quiete del padrone. E Milone quella sera fece qualcosa che non avrebbe mai creduto di fare: abbandonò la sua andatura frettolosa da schiavo e tentò di accogliere la pace nel suo animo irresoluto camminando lentamente da uomo libero e guardando le pitture una dopo l’altra, le mani intrecciate dietro la schiena, ricercando nei volti e nelle posture il loro fine umorismo; era quello che faceva il padrone la sera, uscito dal suo studio, con la sua compostezza abituale. Lo aveva osservato tante volte, senza mai capire. Nei momenti di intima ribellione all’obbedienza che gli doveva, che si alternavano a quelli di segreto avvilimento, si era crogiolato nel credere che il padrone lusingasse i suoi bassi istinti e si era permesso di disprezzarlo. La pace respinse il suo invito e le ninfe maliziose risero di lui. Milone, ancora più confuso, si guardò intorno circospetto come un ladro preso sul fatto.
Riprese a lavorare, aggirandosi con la faccia sempre uguale nella confusione che precede la cena, e borbottava a se stesso “Semplicione, sciocco... megalomane“. Imitare il padrone... come se il padrone e lo schiavo potessero nutrire le stesse aspirazioni, impossibile, il padrone ha diritto a più alte aspirazioni. La serenità non è prerogativa degli schiavi.
Nella lunga giornata da servo, il momento di sospensione tra il giorno e la notte, dai contorni indefiniti, era il momento della piena consapevolezza del suo stato, era un’oppressione nel petto, una nostalgia dolente per la libertà... la libertà, che ancora, dopo tanti anni, lo schiavo non accettava di considerare un qualcosa di vago, di lontano e sfocato, di irraggiungibile. E sere dolci come quella erano le più tristi.
Eppure da quella sera diversa dalle altre, in cui, per la prima volta, nella continua disputa interna alla sua anima, la civiltà del padrone usciva vincitrice, si aspettava qualcosa di nuovo, forse una più tranquilla accettazione del suo stato in futuro. Forse doveva essere quella la pace per lui, una consapevole sottomissione.
Dal giardino, che ne era il centro e il cuore, si poteva scorgere uno spaccato della grande casa. Le stanze erano tutte aperte per far entrare il fresco, le camere da letto con le cortine svolazzanti, con le sue migliaia di papiri la biblioteca, nella parte opposta all’ingresso i triclini. Il più piccolo dei tre, quello centrale, sfavillante di luci, ospitava quella sera la mensa del padrone. I camerieri si affaccendavano con gli antipasti, e alla vista di Milone abbassavano la voce. Il lampionaio accendeva le lanterne del portico. Giungevano ovattati l’acciottolio della cucina e gli ordini concitati dei cuochi. Nell’atrio gli amministratori entravano e uscivano dall’ufficio conteggiando sulle tavolette i prodotti della campagna. Due nubiani seminudi, la pelle lucida di oli profumati, stazionavano di guardia all’ingresso.
Milone passò in rassegna alcune stanze, e i servi che vi erano addetti, mettendo ordine nelle cose e negli animi. Pretendeva che i servi fossero come lui, indispensabili e quasi invisibili. Infine constatò che la casa era in ordine come la voleva il padrone, non troppo chiassosa, non troppo calma, disciplinata, ma serena.
Il padrone curava gli affari di famiglia nel suo studio. Milone andò a piazzarsi di fronte alla porta chiusa, in attesa di ordini.
Scendeva la sera, il momento più dolce della giornata, che andava goduto con gli amici. Caio Cedicio, il padrone, uscì dallo studio, la fronte aggrottata, non fece caso a Milone, che gli si mise alle costole, come un’ombra. Si diresse al triclinio, aspirando il profumo acuto della lavanda. Si chinò a immergere le mani nel ruscello e al contatto freddo e piacevole il suo volto accennò a distendersi. Dal sentiero giunse al portico e camminando lentamente seguì con gli occhi gli amori acquatici, col gorgoglio del ruscello in sottofondo. Si lasciò pervadere dalla quiete difensiva di cui si era circondato, finché la sua mente fu occupata solo da amabili pensieri futili. Era giunta l’ora di far ridipingere il portico con nuovi personaggi, sulla parete che si scorgeva dal triclinio estivo si poteva ritrarre Menodoto mentre si tuffava da una barca insieme ad altri fanciulli. E quando si fosse stancato di Menodoto, ne avrebbe sostituito il volto con quello del nuovo favorito. Era un’idea piacevole.
Caio era sdraiato di fronte alla mensa con i suoi due ospiti. Da qualche tempo non aveva molti invitati a cena, sua moglie stava per partorire. Se gli dèi avessero voluto sarebbe diventato padre. Nell’offrire tutti i sacrifici necessari, aveva eseguito il rituale alla perfezione e questo lasciava sperare bene.
Un giovane coppiere mesceva uno dei vini più preziosi della cantina. Il tema della conversazione richiedeva una bevanda di pregio, non che fosse importante in sé, ma coinvolgeva personalmente i due ospiti di Caio, Emilio e Lucio, che per questo si stavano battendo nei salotti degli amici nell’ilarità generale. Caio era chiamato a fare da arbitro. Nel portico si aggiravano ombre furtive, erano gli schiavi che bisbigliando cominciarono a scommettere, non c’è cosa su cui non scommettano, Emilio era dato vincente, al guardarobiere di Caio era sembrato che Caio propendesse per lui mentre si vestiva quella sera.
Lucio era un bell’uomo, colla testa nera riccioluta e superba. Alla morte del padre era diventato capo della famiglia, a diciotto anni. Era stato sempre considerato simpatico e piuttosto arguto, ma stava perdendo il consenso della società in quei giorni, per il suo accanimento puntiglioso, quanto inutile, mai mostrato prima.
«Sono costretto dunque a sperare nell’imparzialità di Caio, speriamo che non sia solo una leggenda» disse.
Caio spense il sorriso un po’ amarognolo che gli voleva increspare le labbra, di fronte a chi poteva parlare come voleva. Era abituato a non mostrare mai i suoi sentimenti, costretto dalle situazioni. A trent’anni era ancora sotto la tutela del padre, che non voleva emanciparlo. L’unico posto in cui Caio si sentiva indipendente era la sua casa, di cui suo padre non si impicciava mai, mai aveva sminuito il prestigio di Caio di fronte ai suoi sottoposti. Ma di fronte alla città Caio aveva le mani legate. Non gli era mai successo di uscire di casa un mattino con la prospettiva di poter dire quello che pensava di fronte ai romani. Anche il figlio che stava per nascere non era sotto il suo controllo, apparteneva al padre che lo aveva obbligato ad accoppiarsi con una donna di sua scelta, Ortensia. Chiamarla donna, poi... era un essere privo di attributi femminili, di gaiezza, di spirito. Ebbene sì, Caio aveva fatto il suo dovere e si era accoppiato... con una certa ripugnanza, ma a volte invidiava Lucio che non aveva un padre.
La disputa tra Emilio e Lucio nasceva dal fatto che Emilio aveva dato in usufrutto la sua bella schiava, capelli neri e lucidi e pelle di seta, a Lucio, perché insegnasse una tessitura di gran pregio alle sue operaie, e Lucio, come pareva giusto, poiché l’aveva pagata un prezzo alto, l’aveva usata anche come passatempo.
Il figlio nato dalla schiava di chi doveva essere? Secondo la legge il figlio della schiava non è da considerarsi un frutto e appartiene al padrone, non all’usufruttuario, dunque il bambino era di Emilio. Ma Lucio lo voleva a tutti i costi, non si era mai allontanato dalla sua casa un servo che ci era nato, diceva, era ora piuttosto di cambiare quella legge...
«Io insisto, cari amici» disse Lucio, «se si dà in usufrutto un albero, i frutti di quell’albero appartengono all’usufruttuario, lo dice lo stesso termine frutto, che si usa anche per il raccolto di un campo, per la lana di una pecora, per l’uva di una vigna. E io vi chiedo, cosa c’è di diverso per il figlio di una schiava? Certo, Emilio deve tutelare i suoi interessi, ma la schiava è in ottime condizioni, che gli importa ...