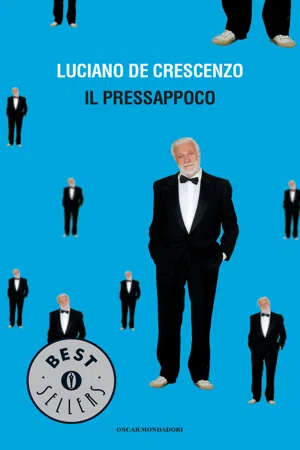![]()
Tris kai tetrákis ton sferon labonton panta kaká feughetai. Traduzione approssimativa: “Tre o quattro volte toccandosi i genitali tutti i mali fuggono”. Esatta o non esatta che sia la traduzione, ho sempre creduto che la masturbazione fosse un bene fisico e psicologico.
La masturbazione, diciamo le cose come stanno, rappresenta il pressappoco del sesso, e io, in qualità di esperto in materia, ne posso parlare con piena cognizione di causa. La mia prima “esperienza sessuale” è stata meravigliosa e sarebbe stata ancora più bella se fossimo stati in due. Dai quindici ai diciotto anni non ho fatto altro. Mi chiudevo nel buio della mia stanzetta e davo inizio a quello che all’epoca consideravo una pratica quasi religiosa, pensando a volte all’attrice Clara Calamai, che aveva mostrato il seno nudo all’attore Amedeo Nazzari nel film La cena delle beffe, e a volte a Ombretta De Santis, mia compagna di scuola di prima liceo.
Ombretta aveva il banco immediatamente dietro al mio, e io, fingendo di dover prendere la penna che mi era caduta, mi abbassavo quel tanto da poterle guardare le gambe.
Noi ragazzi degli anni Quaranta non sapevamo ancora che le donne avessero l’ombelico. Io, però, avendo visto una volta sola, e sottolineo una volta, Ombretta De Santis sopra una scala, tutta protesa a prendere un atlante geografico, sono andato avanti per quasi due anni con quell’immagine nella memoria. Era l’epoca in cui andava di moda la canzone:
Ombretta sdegnosa
del Mississippi,
non far la ritrosa
ma baciami qui.
E quel “qui”, almeno per noi della terza C della scuola Umberto I di Napoli, era il posto più osceno che si potesse immaginare.
Masturbarsi, comunque, oltre che al morale, faceva male anche al fisico. Per un giovanotto di diciotto anni che amava inoltre emergere nei campionati campani di atletica leggera, una masturbazione consumata poche ore prima della gara voleva dire passare dal primo all’ultimo posto nell’ordine d’arrivo. Il mio allenatore, il professore Armando De Filippo (che Dio lo abbia in gloria), me lo aveva raccomandato un centinaio di volte: “De Cresce’, se vuoi vincere negli ottocento metri, certe cose non le devi fare”.
E io, pur di avere qualche speranzella in più, evitavo qualsiasi tentazione. Temevo perfino la cosiddetta polluzione notturna. Poteva accadere, infatti, che durante la notte facessi un sogno erotico con conseguente eiaculazione. Ebbene, onde evitare anche questo pericolo remoto, la sera precedente la gara, prima di andare a letto, mi legavo un asciugamano intorno alla vita in modo che il nodo finisse esattamente dietro la schiena. Sempre De Filippo mi aveva spiegato che la “schifezza” poteva aver luogo solo se la schiena stava molto al caldo.
Ora, bisogna sapere che negli anni Cinquanta era praticamente impossibile avere un rapporto erotico con una ragazza cosiddetta perbene. Sono stato fidanzato con mia moglie per quattro anni e mai una volta, dico una volta, l’ho vista nuda. Una sera, a Ponza, (per risparmiare) abbiamo anche dormito insieme nello stesso letto e neppure quella volta abbiamo fatto qualcosa di pratico. Il ragionamento era grosso modo questo: “Se stanotte facciamo l’amore e domani muoio, magari perché investito da un autobus, questa povera disgraziata, non essendo più vergine, non avrà altra alternativa che suicidarsi”. Così almeno si pensava una volta. Per avere, quindi, un’esperienza sessuale significativa bisognava ricorrere alle straniere. Si andava a Capri e, grazie all’aiuto di un marinaio del posto soprannominato Bicipite (ma che in realtà si chiamava Antonio), riuscivamo ad avere un rapporto con una tedesca un po’ avanti negli anni.
A proposito di Bicipite, lui veniva chiamato così perché una volta una pittrice milanese volle per forza fargli un ritratto sul genere di Maciste. Oggi Bicipite è molto anziano, ma racconta ancora la storia come se fosse accaduta ieri.
«Ingegne’, quella era una pazza. Prima mi fece salire su uno scoglio e poi mi disse: “Mostrami il bicipite”. E io ch’aveva fa’? Glielo feci vedere. Allora lei si mise a gridare.»
Oggi la masturbazione viene definita in vario modo. Dai medici è chiamata onanismo perché venne consumata per primo da un certo Onan, figlio di Giuda.
Per saperne di più bisognerebbe leggere la Bibbia al paragrafo 38,6-10 della Genesi, dove si racconta che Giuda avesse ordinato al suo secondogenito Onan di mettere incinta la moglie del fratello che era impotente. Onan, però, non volendo dare al fratello maggiore una discendenza che in qualche modo avrebbe potuto diminuire l’eredità dei suoi figli, ogni sera, prima di andare a letto, spargeva il proprio seme per terra.
Oggi, a seconda del paese o della regione dove si vive, la masturbazione viene definita con espressioni diverse: per esempio, dai romani è chiamata “spararsi le seghe” e da noi napoletani “farsi le pippe”. Certo è che si tratta di un grande dono avuto da Nostro Signore. Se non esistesse, non si sa come farebbero certi individui orribili a procurarsi un minimo di piacere.
Nell’onanismo non è da sottovalutare il contributo fornito dal cervello. Non basta, infatti, il semplice contatto con l’organo genitale per portare a termine una buona masturbazione. È necessario anche un minimo di fantasia. La persona sulla quale… come dire… si lavora, è puramente immaginaria, e allora, se da un lato c’è il vantaggio di non doverla riaccompagnare a casa, dall’altro c’è lo svantaggio di non poterne ascoltare i gemiti durante il rapporto.
I nostri genitori, in accordo con i preti e con gli insegnanti di religione, ci avevano preannunciato la più totale cecità o quanto meno una miopia gigantesca. “Pazienza” rispondevamo noi, “ci compreremo gli occhiali.”
Certo è che fino alla maggiore età abbiamo continuato a praticare la masturbazione senza alcuna paura.
Tra i tanti che hanno fatto ricorso alla masturbazione non va dimenticato il grande Tommaso Campanella. Si racconta, infatti, che una sera il filosofo, dopo essere stato torturato con il supplizio della corda, abbia visto una bella ragazza farsi il bagno nuda in una vasca. Ebbene, Campanella si eccitò a tal punto che, una volta andata via la bagnante, non solo s’immerse nella stessa acqua ma ne bevve un sorso per poi scriverci sopra la seguente poesia:
Le mani, provvidenza che non erra,
rivolsi a me stesso cortese e pio,
tolsi l’acqua e applicaila al corpo mio,
già fracassato da una lunga guerra
e del medesimo liquor bevendo anch’io.
Miracolo d’amor stupendo e raro!
Cessò la doglia e diventai più forte,
le piaghe e le rotture si saldaro
sentendo in me le sue bellezze assorte.
So benissimo che non tutti sono d’accordo con questa interpretazione; io, però, leggendo il testo con un minimo di malizia, sono convinto che il nostro Campanella vide in quell’acqua il “medesimo liquor” che aveva bagnato la donna.
Adesso, però, per concludere, mi tocca raccontare quanto da me scritto a pagina 40 del libro Vita di Luciano De Crescenzo (Mondadori 1989):
Nella parrocchia di Santa Lucia c’era un gigantesco quadro del martirio di san Sebastiano. Ricordo ancora le corde che tenevano legato il santo, lo sguardo del martire rivolto verso il cielo e le frecce conficcate nel suo corpo come tanti aghi su un puntaspilli. In particolare, la freccia che più mi terrorizzava era quella che gli attraversava la gola. Non si trattava di un capolavoro, ma non aveva nulla da invidiare al più raccapricciante film dell’orrore.
Don Attanasio, il parroco di Santa Lucia, poi, era ancora più terribile del quadro. Quando mi confessava, a parte il fatto che sbrigava tutta la faccenda in piedi, fuori dal confessionale, era solito andare subito al dunque. Mi puntava un dito contro e urlava: «Hai commesso atti impuri?».
«Sì.»
«Da solo o accompagnato?»
«Da solo.»
«Lo vedi a san Sebastiano?»
«Sì.»
«E allora ricordati che ogni volta che ti tocchi, grandissimo fetente che non sei altro, san Sebastiano viene colpito da una freccia. Ecco quello che sei: un farabutto, un disgraziato, una canaglia, un uomo di merda e un vigliacco, e adesso vattene che non ti voglio più vedere.»
«E la penitenza?»
«Tre Ave Maria per ogni freccia che ha colpito san Sebastiano.»
Le frecce erano otto, compresa quella alla gola. Tre per otto fa ventiquattro. Ventiquattro Ave Maria da recitare tutte in ginocchio e ad alta voce.
E non basta: per anni sono stato tormentato da san Sebastiano, e ogni volta che ho fatto l’amore, proprio nel momento culminante, quello più bello, mi sono immaginato la gola di san Sebastiano e la sua stramaledettissima freccia.
![]()
Se c’è qualcosa che non ha niente a che vedere con il pressappoco è il telefonino. Due sono i casi: o è un mezzo insostituibile, o è una grande rottura di scatole. Faccio degli esempi e comincio con il primo caso.
Avete un appuntamento in un’altra città con una persona a cui tenete moltissimo. Purtroppo, avete perso il treno a causa del traffico. Il taxi non ce l’ha fatta. Avreste potuto avvisare la persona già dalla stazione di partenza, ma, maledizione e morte, il suo telefono, quello fisso, non risponde. E nemmeno i suoi amici rispondono. C’è solo il telefonino che vi può salvare. Ebbene, io di casi del genere ne potrei citare a migliaia: dall’avviso “Torna subito a casa che è scoppiato un incendio” al “So che stai a New York, ma gli auguri per il compleanno te li voglio fare lo stesso”.
Tutta la storia dell’umanità sarebbe cambiata se il telefonino fosse stato inventato prima. Consiglio a qualche storico, tipo il mio amico Lucio Villari, di scrivere un’opera in proposito.
Cominciamo con il dire che ...