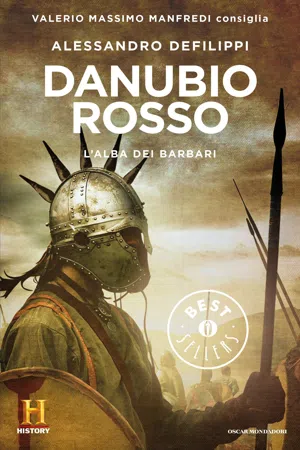1
Durostorum, rive del Danubio, Provincia della Mesia Inferiore, sponda romana del confine dell’impero d’Oriente. Anno MCXXIX dalla fondazione di Roma, XIII giorno prima delle Calende di dicembre (19 novembre 376 d.C.).
Pioggia sulla riva del grande fiume. Pioggia sottile e gelida, che gonfiava le acque grigie, annunciando l’inverno in arrivo dal massiccio dell’Emo. La notte era percorsa dai suoni della foresta, a poche centinaia di passi dal fiume. La nebbia saliva dal fango, dove gli stivali dei legionari lasciavano impronte profonde. Camminavano in fila, cauti e silenziosi, sostenendosi con le lunghe lance nei punti più scoscesi. Dieci uomini appesantiti dalle cotte di maglia, dai panni imbevuti di pioggia. Non portavano scudi. Quella notte non ne avrebbero avuto bisogno.
Costeggiarono il fiume lungo lo stretto sentiero che conduceva a settentrione, dove il Danubio si restringeva nell’attraversare una gola rocciosa. L’alba era vicina.
Nell’oscurità che si faceva livida, il tribuno si arrestò. Si chinò, sollevando un braccio. Gli uomini si accovacciarono, mentre un veterano gli strisciava accanto. Nascosti dagli arbusti, osservarono il fiume ai loro piedi. Il tribuno indicò i canneti sottostanti, che ondeggiavano nell’ombra come percorsi dal vento. Ma di vento, in quella notte gelida, non c’era traccia. La nebbia ristagnava immobile, satura dell’odore greve del fiume.
Il veterano annuì lentamente, chiamando gli uomini con un cenno. Scivolarono lungo l’anfratto, senza rumore.
Il movimento delle canne s’era arrestato. Il cielo, a oriente, andava schiarendosi. Sulla riva giaceva in secca un tronco rozzamente scavato: forse una quercia. Poteva sembrare un relitto portato dal fiume. Accanto, due lunghe pertiche.
Il tribuno si voltò ancora verso le canne. Non ebbe bisogno di gesti: i legionari posarono le lance e impugnarono le spade, lanciandosi nel folto senza una parola.
Prima, un grido di donna, poi l’ansimare convulso di una lotta. Infine, in silenzio, la cortina di canne si riaprì. I legionari ne emersero, spingendo innanzi i prigionieri: un uomo con le brache e la blusa chiazzate di sangue, una donna bionda e alta che reggeva tra le braccia un bambino dagli occhi sbarrati. Altri due bambini erano aggrappati alla sua veste. Tutti avevano il volto smagrito e sotto la tunica spessa le mammelle della donna pendevano flosce.
L’uomo perdeva sangue dal braccio destro. Colpendolo col piatto della spada, il veterano lo costrinse a prostrarsi di fronte al tribuno. «Tu es stercus!» gridò. «Inginocchiati.» Si abbassò fino ad accostargli le labbra all’orecchio. «Tuam matrem futui» sussurrò. Il prigioniero rimase immobile, il capo chino. Il veterano si rialzò. «Non capisce.»
Il tribuno afferrò il prigioniero per i capelli, forzandolo a sollevare la testa. Avvicinò il suo volto a quello dell’uomo, fino a sentirne l’odore, misto di sangue e di paura.
«Non è lui» disse, con voce tranquilla. «Non è Fritigerno.» Si voltò verso il fiume, dando le spalle ai prigionieri, le mani intrecciate dietro la schiena.
Con un movimento abituale, il veterano passò il filo della spada lungo il collo dell’uomo. Il getto di sangue inondò la tunica della donna, che sollevò il volto verso il cielo, ululando come un animale. Il veterano pulì la spada sulla pelliccia del morto. «La donna è giovane. Portatela al campo.»
«E i bambini?»
Tutti fissarono il tribuno. Anche la donna, gli occhi larghi e vuoti.
Il tribuno pareva interessato solo allo scorrere del fiume. «Uccideteli.» Si allontanò a passi lenti, mentre le grida alle sue spalle riempivano l’aria.
L’alba era sorta.
2
Marco Sulpicio Rufo, tribuno della XI legione limitanea, la Claudia Pia et Fidelis, si lasciò cadere su una roccia muscosa. Il dux gli voltava la schiena, impegnato a farsi sistemare il mantello da un servo. Marco alzò gli occhi verso il cielo plumbeo: in alto, un uccello dalle larghe ali ruotava sul campo. Volava così da giorni. I vecchi, veterani delle battaglie contro i Goti, avevano iniziato a osservarlo con timore. Un’aquila, come quella che stava sulle insegne dell’impero. Sarebbe stato un segno di vittoria, ma inizialmente le aquile erano due. Qualche giorno prima, un gruppo di esploratori era ritornato trasportando il cadavere della seconda. L’avevano caricata su uno scudo, le grandi ali aperte, una freccia nel torace. I veterani avevano esaminato la freccia: una punta d’osso, di quelle usate dai Tervingi. Avevano scosso il capo e mormorato a lungo. L’aquila uccisa portava la guerra. Portava la morte.
Marco era esausto. Da giorni il turno di sorveglianza notturno lungo il fiume era suo e dei suoi uomini. Quando infine Massimo, il dux, si voltò verso di lui, aveva quasi preso sonno. Massimo lo scosse con durezza.
«I bambini.» Marco aprì gli occhi. «I bambini» ripeté, come in sogno.
«Quali bambini?»
Marco fissò il superiore, levando le mani in segno di scusa. «I bambini» disse una terza volta. Mosse la testa, come per cancellarne un pensiero. «Ti chiedo perdono, dux. Stavo sognando.»
Massimo lo osservò in silenzio. Era un uomo quasi anziano, dai capelli color del ferro, al termine della sua carriera. Presto sarebbe tornato a Roma e voleva che il suo generale, Lupicino, comes rei militaris della Mesia Inferiore, fosse contento di lui. Non c’era spazio per gli errori, a Durostorum, sul confine. Non c’era spazio per gli errori in quel momento, con Valente sul trono.
«Qui non si sogna.» Marco annuì. «Qui non si sogna. Certo.»
«Il rapporto.»
«Abbiamo trovato la barca. Un tronco. Scavato con le pietre o con il fuoco. Non hanno ferro da sprecare.»
Il dux gli posò una mano sulla spalla, stringendo con forza. «Dio ci protegge, allora.»
«Era una famiglia. Una famiglia che cercava di passare il fiume. Avevano fame.»
«Che ne hai fatto?»
Un silenzio.
«Ho eseguito i tuoi ordini.»
«Gli ordini...»
«Li ho fatti uccidere.»
«Stanotte avrai lo stesso turno. Controllerai la riva verso settentrione.» Massimo, assorto, si voltò in direzione del fiume, invisibile oltre le mura dei castra. «Fritigerno potrebbe commettere un errore, prima o poi. Cercare di passare, da solo o con pochi uomini. E noi lo prenderemo.» Tornò a guardare Marco. «Va’, ora.»
Il tribuno si alzò, fissandolo.
«Va’. Devi dormire» ripeté Massimo.
«Cosa stiamo aspettando, qui?»
Massimo si guardò intorno. Nei castra, i legionari si preparavano a un’altra giornata. La foresta poco lontano incombeva cupa, silenziosa. Non si doveva mai entrare nella foresta, se non in forze. Gli schiavi goti dicevano che tra gli alberi si nascondevano i figli delle streghe e degli spiriti del male. Li chiamavano Unni. Massimo serrò le labbra. Un cristiano non credeva a quelle storie, ma molti tra i suoi uomini erano ancora pagani. E i Goti sapevano essere convincenti.
«Aspettiamo. Dalmatico è partito da quasi un mese, ma l’imperatore è ad Antiochia, a organizzare la spedizione contro i Persiani, e non pensa certo a noi. Aspettiamo.»
Marco lasciò il pretorio, dove risiedeva il dux, avviandosi verso i contubernia, gli alloggiamenti della truppa. Davanti alla sua bottega, un fabbro martellava cocciuto una lama che avrebbe poi immerso nell’acqua gelida, per temprarla. Poco lontano, sotto il portico del valetudinarium, un legionario medicava con un impacco vegetale la gamba di un commilitone. Il giovane, quasi imberbe, fissava con occhi smarriti la vasta ferita che gli lacerava il polpaccio. Più in là, i lavatoi erano affollati dalle donne dei soldati, che sciacquavano i panni nell’acqua gelata. Una di loro aveva un neonato attaccato al seno: lo reggeva con un braccio e con l’altro sbatteva un paio di brache contro le pietre piatte. Marco la osservò con gli occhi pesanti. Sentiva le membra rotte e pregustava il sonno: avrebbe dormito, come sempre, con i suoi uomini. Se fosse stato fortunato, non avrebbe sognato i bambini che aveva fatto uccidere.
Senza pensare oltrepassò la bassa costruzione dei dormitori, dirigendosi invece verso la porta pretoria, affacciata sul fiume. Salutò le sentinelle, camminò sull’erba fradicia, incurante della pioggia, fino alla sponda.
Il Danubio scorreva lento. Un immenso animale grigio. Trascinava detriti e cadaveri di animali. Piccole carcasse erano impigliate tra i canneti.
Il tribuno sollevò lo sguardo. Sull’altra sponda, colonne di fumo nero si alzavano dagli accampamenti goti. I carri sembravano migliaia, circondati dalle fiamme dei falò. In piedi, proprio di fronte a lui, un uomo alto, sul cui capo luccicava qualcosa che pareva una corona. Guardò verso Marco, che guardava verso di lui.
3
Antiochia, palazzo imperiale. Anno MCXXIX dalla fondazione di Roma, XII giorno prima delle Calende di dicembre (20 novembre 376 d.C.).
Era stata una notte insonne e solo alle prime luci dell’alba l’imperatore Flavio Giulio Valente era riuscito ad assopirsi. Ora gemeva tra i lini impregnati di sudore, visitato da un incubo. Non era certo il primo: fin da bambino gli accadeva di svegliare con un grido Valentiniano, il fratello maggiore che dormiva accanto a lui. Erano gli anni passati, a Cibalae, in Pannonia, o nelle tenute del padre, in Africa e in Britannia.
Non era certo il primo, ma mai Valente ne aveva sognato uno simile. Nel sogno, sapeva che la morte incombeva su di lui.
Si mosse bruscamente nel letto, urtando con un braccio il calice appoggiato accanto. Il calice cadde, rompendosi in frammenti di vetro verde e opaco e il fragore risuonò nella stanza. Ora Valente era desto, gli occhi ancora chiusi, incapace di muoversi. Fu angosciosamente certo di essere cieco, paralizzato. I suoi servi lo avrebbero trovato così. Qualcuno avrebbe pianto, altri sorriso nell’ombra, e lui sarebbe stato sepolto ancora vivo, andando incontro al destino di soffocare nella tomba, impotente. Sentiva sul viso un peso che gli toglieva il respiro, un sacco nero che lo avvolgeva. Con uno sforzo che lo lasciò esausto riuscì infine a gridare.
Udì, come da molto lontano, richiami, voci concitate. Poi, la porta della grande camera si spalancò.
Sulla soglia, illuminata dalle lucerne, si stagliava la figura di un uomo alto, massiccio, quasi un gigante. La luce baluginante gli segnava linee nette e taglienti sul volto. Portava le insegne di magister della schola palatina, la guardia personale di Valente. Si avvicinò al letto, chinandosi per sostenere il corpo molle dell’imperatore.
Valente aveva gli occhi semichiusi, che mostravano una semiluna bianca, e dalla bocca gli colava una schiuma densa e grigiastra. L’uomo lo scosse, poi, senza esitare, lo colpì al volto con la mano aperta. Le guardie e i servi che reggevano le lampade distolsero il capo. Nessuno poteva colpire il corpo sacro dell’imperatore. Nessuno poteva vederlo colpire.
Valente aprì gli occhi, le pupille piccole come la punta di un ago. «Batraz» mormorò. Afferrò la tunica dell’uomo con mani che parevano artigli, con unghie che graffiavano. «Sei qui. Allora sono vivo.»
Batraz annuì lentamente, chiamando un servo con un cenno. «L’infuso per l’imperatore.»
Il servo scomparve, mentre qualcuno scostava le tende dalle finestre e nella stanza penetrava il chiarore dell’alba. Era un giorno cupo. Nuvole basse.
«C’era un sole scarlatto, al tramonto.» Valente s’er...