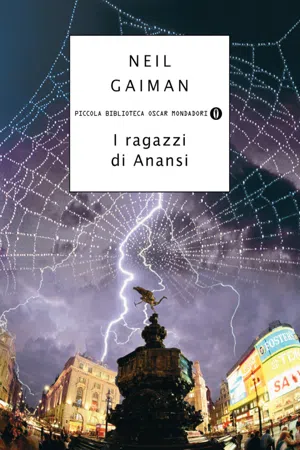![]()
Ciccio Charlie sedeva sulla coperta del lettino di metallo aspettando che succedesse qualcosa, ma non succedeva niente. Un periodo che gli sembrò durare parecchi mesi passò con estrema lentezza. Cercò di addormentarsi ma non riusciva a ricordare come si faceva.
Picchiò sulla porta.
Qualcuno gridò «Piantala!» e non capì se era un secondino o un altro detenuto.
Camminò avanti e indietro nella cella per un tempo che, secondo una stima prudente, gli sembrò durare due o tre anni. Poi sedette e lasciò che l’eternità lo travolgesse. La luce del sole era visibile in alto, al di là della spessa lastra di vetro, che fungeva da finestra, e la si sarebbe proprio detta la stessa luce che aveva visto quella mattina quando la porta della cella gli era stata chiusa alle spalle.
Cercò di ricordare a che cosa si dedicava la gente in prigione per far passare il tempo, ma gli veniva in mente soltanto che tenevano un diario segreto e si nascondevano delle cose nel sedere. Non aveva materiale su cui scrivere, ed era convinto che per valutare quanto una persona se la cavasse nella vita una maniera certa era proprio quella di non doversi nascondere niente nel sedere.
Non succedeva Niente. Niente continuò a succedere. Altro Niente. Il ritorno del Niente. Il figlio del Niente. Niente la vendetta. Niente e Abbott e Costello incontrano l’Uomo Lupo…
Quando la porta si aprì Ciccio Charlie quasi gridò di contentezza.
«Bene. È l’ora d’aria. Puoi avere una sigaretta, se vuoi.»
«Non fumo.»
«Comunque è un’abitudine schifosa.»
Il cortile era uno spazio aperto in mezzo all’edificio, circondato sui quattro lati da muri che in alto avevano il filo spinato, uno spazio nel quale Ciccio Charlie camminò decidendo fra sé che, se c’era una cosa che proprio non gli piaceva, era essere in custodia alla polizia. La polizia non gli era mai piaciuta davvero, ma fino a ora aveva nutrito una sostanziale fiducia nell’ordine naturale delle cose, nella convinzione che vi fosse una sorta di potere – un vittoriano l’avrebbe chiamato provvidenza – in base al quale alla fine i colpevoli venivano puniti e gli innocenti liberati. Alla luce degli ultimi eventi questa fede era crollata per essere sostituita dal sospetto che avrebbe passato il resto della sua vita a dichiararsi innocente davanti a una varietà di giudici e torturatori implacabili, molti dei quali con l’aspetto di Daisy; e che, molto probabilmente, l’indomani mattina si sarebbe svegliato nella cella numero sei scoprendo di essere stato trasformato in un enorme scarafaggio. Era decisamente finito nel genere di malefico universo che trasforma la gente in scarafaggi…
Il cielo sopra di lui venne attraversato da un oggetto che piombò sul filo spinato. Alzò gli occhi. Un uccello nero lo fissava con superba indifferenza. Sentì altre ali frullare e l’uccello nero fu raggiunto da alcuni passeri e da un esemplare di tordo, o almeno gli sembrava.
Gli uccelli lo fissavano e lui ricambiò l’occhiata.
Ne arrivarono altri.
Sarebbe stato difficile dire esattamente quando l’accumulo di uccelli sul filo spinato smise di essere interessante per diventare terrificante. Più o meno quando raggiunsero il primo centinaio, comunque. Ed era anche il fatto che non tubassero e non gracchiassero, non trillassero né cantassero. Si limitavano ad atterrare sul filo e a guardarlo.
«Andatevene» disse.
Rimasero immobili come un solo uccello. Invece, parlarono. Lo chiamarono per nome.
Ciccio Charlie si precipitò verso la porta d’angolo e picchiò con forza. Disse: «Scusate» alcune volte, poi si mise a gridare: «Aiuto!».
Un tonfo. La porta venne aperta e un membro del corpo di polizia di Sua Maestà con le palpebre pesanti disse: «Spero che tu abbia una buona scusa».
Ciccio Charlie indicò verso l’alto senza dire niente. Non aveva bisogno di parlare. La bocca del poliziotto si spalancò in modo straordinario e rimase spalancata. Sua madre, pensò Ciccio Charlie, gli avrebbe detto di chiuderla, se non voleva che ci volasse dentro qualcosa.
Il filo spinato era piegato sotto il peso di migliaia di uccelli. Minuscoli occhi aviari fissavano verso il basso senza battere le palpebre.
«Cristo in bicicletta!» esclamò il poliziotto, e spinse Ciccio Charlie dentro il braccio senza aggiungere altro.
Maeve Livingstone soffriva. Era distesa scompostamente sul pavimento. Si svegliò sentendosi i capelli e la faccia bagnati e caldi, si addormentò e quando si risvegliò i capelli e la faccia erano appiccicosi e freddi. Sognò, si svegliò e sognò di nuovo, sognò a sufficienza per essere consapevole del dolore alla nuca, e poi, siccome dormire era più facile, e siccome quando dormiva non sentiva male, permise al sonno di abbracciarla come una morbida coperta.
Nei suoi sogni attraversava uno studio televisivo cercando Morris. Di tanto in tanto coglieva immagini di lui sui monitor. Aveva sempre un’aria preoccupata. Cercava di trovare l’uscita, ma tutte le strade la riportavano allo studio.
“Ho tanto freddo” pensò e capì di essersi svegliata di nuovo. Il dolore era passato. Nel complesso, pensò Maeve, si sentiva abbastanza bene.
C’era qualcosa che la turbava, ma non sapeva bene cosa. Forse un’altra parte del sogno.
Ovunque si trovasse, era buio. Sembrava uno sgabuzzino delle scope e allungò le braccia per non andare a sbattere. Mosse alcuni passi nervosi con le braccia tese e gli occhi chiusi e poi li aprì. Adesso era in una stanza che conosceva. Un ufficio.
L’ufficio di Grahame Coats.
Allora ricordò. L’intontimento del primo risveglio non passava – non riusciva ancora a pensare lucidamente, sapeva che non sarebbe stata perfettamente in sé fin dopo la prima tazza di caffè – comunque ricordava tutto: la perfidia di Grahame Coats, l’inganno, il crimine, il…
… insomma, concluse, mi ha aggredito, mi ha colpito. E poi: La polizia. Devo chiamare la polizia.
Allungò la mano verso il telefono sul tavolo e afferrò il ricevitore, o meglio, provò ad afferrarlo, ma il telefono sembrava molto pesante o scivoloso, o entrambe le cose e non ci riusciva. Non era capace di stringerlo in mano.
Devo essere più debole di quello che pensavo, decise. Farei meglio a chiedergli di mandare anche un medico.
Nella tasca della sua giacca c’era un telefonino color argento con Greensleeves come suoneria. Fu sollevata nello scoprire che c’era ancora e che riusciva a maneggiarlo. Compose il numero delle emergenze. Mentre aspettava che qualcuno rispondesse, pensò che da adolescente aveva avuto un fidanzato che riusciva a imitare, e lo faceva in continuazione, il breep del primo telefono a tastiera, un’abilità che, ripensandoci, era il suo unico merito. Si chiese che cosa ne fosse stato di lui. Chissà come se la cavava un uomo capace di imitare il trillo del telefono in un mondo dove i cellulari ormai potevano suonare qualsiasi cosa…
«Ci scusiamo per l’attesa nell’inoltrare la sua chiamata» disse una voce meccanica. «Rimanga in linea.»
Maeve si sentiva stranamente calma, come se non le potesse mai più succedere niente di male.
Una voce maschile disse: «Pronto?». Suonava estremamente efficiente.
«Ho bisogno della polizia» disse lei.
«Lei non ha affatto bisogno della polizia» rispose la voce. «Ogni crimine sarà risolto dalle immancabili e adeguate autorità.»
«Sa» disse Maeve, «penso di aver sbagliato numero.»
«Analogamente» disse la voce, «tutti i numeri, alla fine, risultano corretti. Sono semplicemente numeri e perciò non possono essere né giusti né sbagliati.»
«Quello che dice è molto interessante» rispose Maeve, «comunque io ho bisogno di parlare con la polizia. Credo di aver bisogno anche di un’ambulanza. E ovviamente ho chiamato il numero sbagliato.» Chiuse la comunicazione. Forse, pensò, il 999 da un cellulare non funzionava. Cercò nella rubrica il numero di sua sorella. Dopo il primo squillo una voce che ormai le era familiare disse: «Mi permetta di chiarire: non sto dicendo che lei abbia composto il numero sbagliato volontariamente. Quello che ritengo di dire è che tutti i numeri sono, per loro natura, corretti. Be’, eccezion fatta per il pi greco, naturalmente. Con il pi greco non me la cavo. Mi fa venire il mal di testa solo a pensarci, così trascendente e trascendente e trascendente…».
Maeve premette il pulsante rosso per chiudere la telefonata. Chiamò il direttore della banca.
La voce che rispose disse: «Comunque eccomi qua, che parlo a vanvera sulla correttezza dei numeri, mentre lei, indubbiamente, starà pensando che c’è un tempo e un luogo per ogni cosa…».
Clic. Chiamò la sua migliore amica.
«… mentre in questo preciso istante ciò di cui dovremmo parlare sono le sue ultime volontà. Ho paura che il traffico questo pomeriggio sia estremamente intenso, quindi, se non le dispiace aspettare dov’è per un pochino, verrà ritirata…»
Era una voce rassicurante, la voce di un prete alla radio che racconta il suo pensierino della sera.
Se Maeve non si fosse sentita così placida a quel punto sarebbe stata presa dal panico. Invece rifletté. Visto che il suo telefono era stato – come si diceva – manomesso da un hacker?, quello che doveva fare era scendere in strada, trovare un poliziotto e sporgere denuncia. Siccome quando premette il pulsante dell’ascensore non successe niente Maeve prese le scale, pensando che non si trova mai un poliziotto nelle vicinanze quando serve, perché erano sempre a schizzare di qua e di là in quelle loro macchine che fanno nii-noo-nii-noo-nii-noo. I poliziotti, pensò lei, dovrebbero andare in giro in coppia a dire alla gente che ore sono o ad aspettare in fondo a una grondaia i ladri che scendono con la refurtiva nelle borse a tracolla.
Proprio in fondo alle scale, nell’atrio, c’erano due agenti, un uomo e una donna. Non erano in uniforme, ma erano decisamente poliziotti. Nessuna possibilità di sbagliarsi. L’uomo era grasso e paonazzo, la donna piccola e scura e in altre circostanze a Maeve sarebbe sembrata estremamente graziosa. «Sappiamo che è arrivata fin qua» stava d...