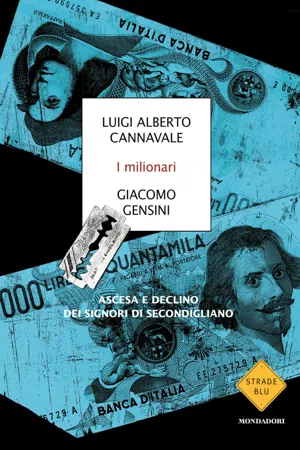![]()
Luigi Alberto Cannavale
Giacomo Gensini
I MILIONARI
Ascesa e declino dei signori di Secondigliano
![]()
a Tatiana a Enzo, Enzina, Barbara,
Lorenzo e Giancarlo ![]()
A caccia si va all’alba, a caccia di uomini due ore prima dell’alba. Quando il sonno di chi sogna è pesante.
Le settanta macchine che percorrevano le strade e i vicoli di Napoli quello facevano, andavano a caccia di uomini.
A bordo erano in duecento, le pistole pronte, i nervi tesi, il cuore a mille.
A bordo erano in duecento e tutti convinti che quella notte non avrebbe cambiato nulla, che qualcun altro sarebbe arrivato a riempire il vuoto creato dalla retata.
Ma questa consapevolezza non li inibiva.
Il telefono era squillato alle cinque di mattina di quel 1° ottobre 2002 e Sicco aveva risposto subito.
Subito sveglio, subito all’erta.
Era sua figlia, la figlia che di lì a pochi giorni si sarebbe sposata con una cerimonia da centinaia di milioni di lire, una cerimonia che a Napoli solo uno come ’o Sicco si poteva permettere.
La ragazza era spaventata, la voce le tremava.
In fretta gli aveva spiegato che la polizia era venuta ad arrestarlo, non lo aveva trovato ed era andata via.
Sicco si era affacciato alla finestra di quella casa dove talvolta dormiva, uno dei suoi rifugi, delle sue tane sicure. La notte di Secondigliano era blu di sirene, quella non era una cosa fatta a caso, era una maxi infornata e c’erano dentro tutti.
Sicco aveva sentito un buco di paura nello stomaco, un buco che aveva chiuso subito, però, perché non serviva a niente in quel momento.
Doveva muoversi, trovare un altro posto dove nascondersi, capire chi era dentro e chi fuori.
Ma quella notte di luci era uno spettacolo impressionante, e Sicco, che amava gli spettacoli, non riusciva a scollarsi.
Poi l’alba era arrivata, e la luce blu dei lampeggianti si era sciolta nel grigio del mattino. Il luna park in divisa aveva chiuso i battenti lasciando a ’o Sicco solo il torpore della notte in bianco e un sacco di domande delle quali non conosceva la risposta.
A metà mattina, non appena le cose si erano calmate, aveva preso la sua roba e si era trasferito, senza però allontanarsi troppo, in un enorme e fatiscente condominio di appartamenti per tre quarti vuoto.
La Tv mandava immagini di uomini trascinati in manette fuori dalle case: qualcuno che si copriva la faccia, qualcun altro che fissava arrogante le telecamere.
Sicco scuoteva la testa. Ciruzzo, che conosceva sempre le mosse della procura, quella volta non aveva annusato niente. Le sue fonti si erano inaridite, le sue gole profonde seccate.
E un sacco di compagni erano stati fottuti.
Aveva passato i primi giorni alla finestra, senza farsi vedere ma guardando tutto e tutti.
Affiliati gli portavano da mangiare e venivano a prendere ordini.
Le ore erano lunghe e tese, tese e noiose.
Pensare a quelli che ora erano in galera e a quelli che l’avevano scampata era inevitabile. Li conosceva bene, li conosceva tutti, erano cresciuti con lui, erano i suoi compagni di una vita intera.
page_no="4" ![]()
Secondigliano fino al terremoto finiva di botto. In modo netto. Niente più case, niente di niente, solo una strada che portava a Marano, in mezzo a campi coltivati a pomodori.
’O Sicco era nato là, a Secondigliano, all’inizio dei favolosi anni Sessanta, terzo figlio di sette, quattro maschi e tre femmine. Era nato in una casa che era stata di suo nonno, un posto che aveva visto passare tre generazioni di Cavani e un’eruzione del Vesuvio senza cambiare di una virgola, a parte gli elettrodomestici e la carta da parati.
C’era una luce speciale in quella casa, sottile la mattina, quasi azzurra; gialla la sera, densa e dolce, che colava e colava finché il sole non moriva.
Erano i primi ricordi di ’o Sicco, la luce come miele, che filtrava fra le persiane accostate, e un triciclo rosso sul quale sedeva fissando in silenzio quello strano miracolo.
Il padre gestiva un piccolo cinema, che come la casa era stato del nonno. Un vecchio teatro da avanspettacolo riadattato, con palchetti che stavano su per miracolo e sedili di velluto liso da decine di migliaia di culi.
Amava il cinema il padre, il cinema come arte, e aveva sfogato questa sua passione insistendo per dare lui i nomi ai figli maschi, concedendo alla moglie le femmine.
Il maggiore lo aveva chiamato Antonio, come il principe De Curtis, il secondogenito (unica eccezione, perché il parto era stato difficile e aveva fatto un voto) Gennaro. ’O Sicco l’aveva chiamato Vittorio, come Vittorio De Sica, e il più piccolo, l’ultimo dei maschi, Federico, come Fellini.
Era morto d’infarto una sera d’inverno all’inizio degli anni Settanta, quando il figlio più grande aveva dodici anni e ’o Sicco otto.
Era morto, e i ricordi che Vittorio avrebbe conservato di lui nel tempo non erano che un paio di episodi, sempre nella sala di proiezione del cinema, con il padre che sbuffando preparava le pizze (cinematografiche) e in sottofondo il ticchettio del proiettore.
«Lo tieni presente il maestro De Sica?» domandava nella stanzetta il padre al bambino, sudando perché il proiettore era vecchio e difficile da usare.
’O Sicco annuiva deciso, appollaiato su uno sgabello alto quasi quanto lui, gli occhi sgranati, felice perché gli piaceva l’odore di chiuso e di fumo e di pellicola di quella stanza. E gli piaceva stare solo con suo padre.
L’uomo di solito si fermava, lo guardava con un mezzo sorriso, poi il suo sguardo sembrava perdersi lontano.
«Che eleganza! Chillo sì che è ’nu signore. Ricorda, se tieni la possibilità e non ti sai vestire, sei un cafone peggiore del più ignorante dei morti di fame…»
Non era molto, ma era qualcosa; Sicco avrebbe ricordato per sempre quella lezione, non avendo avuto il padre il tempo di dargliene altre.
Era morto un mese dopo (lo aveva trovato la maschera, un vecchio mezzo sordo, richiamato dalle grida «quadro, quadro…» tanto insistenti che anche lui le aveva sentite) tra la prima e la seconda pizza di Operazione San Gennaro mentre cercava di far funzionare il maledetto proiettore.
Un infarto lo aveva steso mentre la pellicola continuava ad andare.
Quella sera aveva venduto tredici biglietti interi e tre ridotti.
Un mese dopo il cinema era stato sequestrato, chiuso e demolito. C’erano debiti, e ipoteche, frutto di investimenti sballati che il padre non aveva mai confessato a casa, e il terreno edificabile valeva più di quel rudere malmesso.
Secondigliano aveva ancora come confine la campagna e la gente ancora diceva «Vado a Marano» come fosse stato un altro posto. Ma i favolosi Sessanta erano finiti da un pezzo.
La madre non si era più sposata. Sette figli più se stessa da sfamare avevano completamente assorbito la sua esistenza.
Puliva le scale, aiutava al mercato rionale, si spaccava la schiena come poteva per rimediare poco o nulla. C’era la crisi, spiegava la televisione. Ma la cosa non li rasserenava affatto.
’O Sicco ricordava le sere a pane e latte, le sere a latte e basta, le sere senza niente.
’O Sicco ricordava quasi solo quello.
Un settembre la madre aveva preso centomila lire per centotrenta, da rendere dieci alla settimana.
Qualche volta non le aveva, e allora si nascondeva sotto il letto della sua camera, con l’uomo venuto a riscuotere che si piazzava in cucina e gridava: «Fatela uscire, ’o saccio che ci sta, tirate fuori i soldi…».
Vedere sua madre, che per lui era così forte e grande, spaventata al punto di nascondersi sotto il letto non mancava mai di ghiacciarlo, di terrorizzarlo sino a fargli mancare il fiato.
Era sempre suo fratello Gennaro a risolvere la situazione; restava calmo, parlava piano, senza alzare la voce, e alla fine l’uomo, convinto di poter aspettare ancora un paio di giorni dalla sicurezza inquietante di quel ragazzino alto e serio, se ne andava borbottando minacce.
’O Sicco non capiva perché, ma Gennaro era già un uomo a dodici anni.
Alto, scuro di capelli e di occhi (com’erano tutti loro), il sorriso aperto, il secondogenito della famiglia Cavani quando diceva una cosa veniva preso sul serio, e a dieci anni ’o Sicco avrebbe messo la vita nelle mani del fratello senza pensarci un attimo, un dato di fatto che non sarebbe mai cambiato.
Insomma Gennaro era già un adulto, anche più di Antonio, il maggiore, che più cresceva e più esasperava il suo carattere introverso. Qualche anno dopo, Sicco avrebbe riflettuto che era stata la responsabilità piovutagli addosso come primogenito alla morte del padre a schiacciare e far chiudere in se stesso Antonio. Mentre Gennaro, da cui nessuno si aspettava nulla, aveva agito in base alla semplice necessità, senza pressioni.
Allora, però, quello che gli capitava non aveva altre spiegazioni se non l’oggettività dei fatti. E i fatti erano che Antonio a Sicco sembrava sempre con la testa altrove, distratto dalla passione per l’arte che il padre gli aveva trasmesso. Una specie di malattia da quelle parti, in quelle condizioni. Mentre Gennaro gli appariva non solo presente, ma anche assolutamente concentrato sull’obbiettivo: mangiare.
Era stato proprio Gennaro il primo a lasciare la scuola. Si era messo a rubare, e quello che rubava lo portava a casa.
Partiva la mattina e talvolta non tornava che la mattina dopo, poi dormiva tutto il giorno e nessuno doveva disturbarlo.
Lasciava sempre qualcosa sul tavolo della cucina, però: un po’ di soldi, roba da mangiare o da vendere. In quel modo Gennaro era diventato il capofamiglia, portando il pane a casa.
Un anno dopo anche Antonio, che tra gli alti Cavani era il più alto e il più grosso, aveva lasciato la scuola e si era messo per strada. Ma non con Gennaro. Aveva giri diversi, zone diverse, faceva cose diverse, contrabbando in particolare, ma soprattutto era sempre più chiaro che aveva altro per la testa. Scriveva poesie, disegnava.
Ma non era comunque facile andare avanti, e otto persone sono un sacco di gente. C’erano ancora le sere a latte e basta.
page_no="8" Pure Sicco intanto aveva mollato la scuola. A dodici anni era grande, era tempo anche per lui di iniziare a faticare.
Poco dopo Federico, l’ultimo fratello, li aveva seguiti.
La madre non aveva pianto, capiva, e anche se magari in cuor suo avrebbe preferito una strada diversa non lo mostrava. Per lei, i figli facevano quello che bisognava fare, era una questione di sopravvivenza.
Come quando, ancora per debiti fatti dal padre e dei quali non sapevano nulla, improvvisamente la loro casa era stata messa all’asta.
Non avevano un altro posto dove andare, nessuno li poteva aiutare, dovevano risolvere la cosa da soli e lo avevano fatto.
Il giorno della vendita erano andati tutti e tre i fratelli più grandi negli uffici comunali. Avevano trovato la stanza giusta, dove già bivaccava annoiato un piccolo gruppo di compratori, erano entrati e si erano messi in disparte a osservarli: nessuno di loro sembrava davvero motivato. Un paio erano lì perché con le aste ci campavano, qualcun altro era in cerca di una casa per la figlia o il figlio che si sposava, o semplicemente tentava un piccolo investimento.
Li avevano avvicinati uno per volta, con Gennaro che spiegava come, se avessero comprato quella casa del Monterosa, loro o chi per loro ci fosse andato ad abitare sicuramente ci sarebbe bruciato dentro.
Sicuramente.
Un paio avevano reagito male, con mezze minacce e spinte abbozzate.
Alcuni avevano fatto finta di niente.
Altri ancora si erano spaventati tanto da andarsene subito.
Ma tutti avevano capito bene quello che Gennaro calmo calmo gli aveva spiegato, e la casa, in mancanza di altre offerte, era stata ricomprata da loro per due soldi.
Intanto Gennaro, che ora nel quartiere chiamavano ’o Sarracino, come il personaggio della canzone di Carosone, già da un bel po’ si era stancato di andare a caccia di turisti. Con il suo gruppo aveva cominciato a rubare macc...