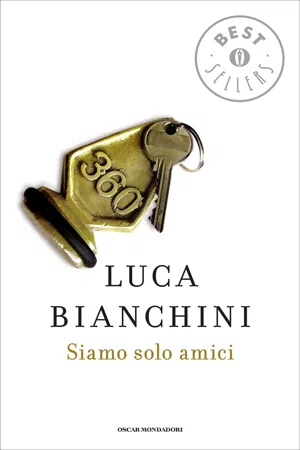![]()
Nella scala dei piccoli dolori, il trasloco viene al secondo posto in assoluto.
Prima c’è il sospetto di un tradimento. A seguire, tutto il resto. La signora Silvana ne era profondamente convinta, anche se non era mai stata tradita e aveva cambiato casa solo una volta. Ma ricordava ancora con orrore quando il suo comò era malauguratamente finito nel canale, e tutti i turisti a fotografare la scena mentre lei gridava: “È del millesettecentocinquanta”.
Vedere Giacomo alle prese con gli scatoloni le riaprì quell’antica ferita, ma lui era troppo concentrato per notare qualcuno alle sue spalle.
«Ti avranno mica licenziato?»
«Silvana! Cosa ci fai qui a quest’ora?»
«Go d’andar dal dottore a farme dar na ricetta... e mi chiedevo se avevi tempo per un prosecco.»
«Di prima mattina? Alla tua età?»
«Guarda che il prosecco aiuta ad abbassare il colesterolo.»
«Certo. Uno al giorno, però. Ora è troppo presto e poi devo sbrigarmi, perché stanno arrivando dei clienti.»
«Go capìo, ti me mandi fora da le bale.»
Lui sbuffò in silenzio, le appoggiò una mano sulla spalla e l’accompagnò alle scale senza fretta. Aveva le accortezze che si usano di solito con le vecchie zie, o con i capi, quando rallenti il passo, nascondi i malumori, cerchi di essere paziente e ti fai venire la gastrite. La rassicurò che non si sarebbe trasferito a Mestre, idea per lei inaccettabile: “Non si può lasciare Venezia solo per affittare casa ai turisti, guidare le macchine e vedere le fabbriche” brontolava. E lui a darle ragione annuendo vistosamente col capo. Sarebbe passato dalla hall al primo piano.
Declinò con fermezza l’ultimo invito per un prosecchino – “ma ci mettiamo dieci minuti” – e riprese a svuotare i cassetti della sua stanza d’albergo. Una stanza che era diventata la sua casa degli ultimi anni e che adesso stava per trasformarsi in un luogo asettico, fatto solo di scatoloni, pennarelli, carta adesiva e da imballaggio.
Durante un trasloco, le case si assomigliano tutte.
Giacomo aveva un modo tutto suo di mettere via le cose, anche quando partiva per un viaggio: cominciava sempre dalle scarpe. Forse perché era la prima cosa che osservava negli altri, anche se si sentiva in colpa a valutare le persone dai piedi. “Che me ne importa se la tua scarpa è un mocassino, una ballerina o uno stivaletto texano?” si diceva. Ma era più forte di lui. Le sue erano tutte simili, con l’impuntura impeccabile, il lucido stucchevole. Le stesse Church’s da decenni. Lo facevano sentire più sicuro e in sintonia con l’ambiente in cui lavorava.
Dopo le scarpe, sistemò calze e slip – rigorosamente bianchi – annusandoli per precauzione. Poi ripose i gessati, le numerose cravatte, i libri, i dischi in vinile che custodiva gelosamente, ma che non ascoltava più. Quindi incartò molti oggetti inutili, che ormai avevano perso consistenza ed erano diventati racconti delle persone che li avevano posseduti, o regalati, o semplicemente sfiorati, e lui lì, imbambolato, con la tentazione di eliminarli, eppure li metteva via.
Poi sistemò una scatola di cui non si sarebbe mai sbarazzato, perché lì c’erano i documenti più importanti che gli anni avevano salvato: biglietti d’auguri e d’aereo, inviti personali, ricevute postali, un paio di scontrini di elettrodomestici e, soprattutto, il codice bancomat.
Il codice bancomat gli aveva sempre dato molta ansia, quasi quanto quella per il PIN del telefonino. Un’ansia ingiustificata, visto che girava ogni giorno con una scorta di contanti e i numeri del codice gli ricordavano una notte di Capodanno. Però era terrorizzato all’idea di dimenticare quelle cifre. Una volta, al supermercato gli era venuto il più classico dei vuoti di memoria. Tutta la fila lo aveva guardato in silenzio, come un ladro da mezza tacca, e lui era riuscito ad azzeccare la combinazione solo al terzo tentativo, davanti agli occhi perplessi della cassiera: «N’altra volta ti te lo scrivi su na man... che xe mejo» gli aveva detto.
Ci sono timori, anche piccoli, che a quarantotto anni ingigantiscono le tue debolezze come se fossi un bambino. Giacomo aveva il terrore di dimenticare il codice bancomat e dover chiedere soldi in giro. Era troppo paranoico per trascriverlo su un foglietto (“e se mi rubano il portafoglio?”) o sul telefonino (“e se mi rubano il telefonino?”). Poteva fare affidamento solo sulla memoria e, periodicamente, sul ripasso. Così aveva tirato di nuovo fuori la scatola di latta per rivederlo. Eccolo lì, quel foglietto trasparente: 31999. Lo ripose subito, e riaprì il portafoglio per verificare i contanti. Poco più di duecento euro. La banconota più grande sembrava strizzargli l’occhio, e gli provocò un’eccitazione che, fino ad allora, aveva cercato di rimuovere: era mercoledì. Il lunedì dei parrucchieri, il sabato dei bancari, il giovedì degli gnocchi nulla valevano al cospetto del suo mercoledì.
Stava per rimettere via la scatola quando palpò un ammasso disordinato di carte. Vista la roba ancora da spostare, non era il momento migliore per leggere il passato, ma non c’è mai un momento migliore per leggere il passato. Quando capita, la testa sospende i giudizi, sospira, e ricorda.
Una cartolina da New York mandata dal signor Nazzaro; un invito alla prima della Bohème diretta da Zubin Mehta; biglietti da visita di persone che non avevano più un volto; una polaroid di una ragazza senza nome davanti alla Tour Eiffel; un disegno a china che raffigurava il San Carlone; lo scontrino pinzato di uno stereo portatile.
Per un attimo, Giacomo vide sfilare davanti a sé persone e cose, senza riuscire ad afferrarle, come se i ricordi fossero acqua corrente che ti accarezza le mani senza lasciare tracce, mentre il tempo ti mette al muro chiedendoti: “Sarebbe questa la tua vita?”.
Anche se al tempo, perché si ricordi di te, interessano soltanto l’amore, l’arte, i figli, e la morte. Gliel’aveva detto una volta la signora Silvana, e non se l’era più dimenticato. Lui non aveva un amore da condividere né dei figli da proteggere, non sapeva dipingere né voleva morire. Era solo al mondo. Aveva un lavoro, un rimpianto e una speranza. A volte si concedeva un po’ di sesso.
Dall’ammasso di fogli spuntò un plico di lettere legate da un nastro. Le scorse lentamente, attratto dalle calligrafie, fino a fermarsi su una che lesse al ralenti, muovendo le labbra come se fosse straniero.
Caro Giacomo,
volevo ringraziarla per quanto ha reso unico e indimenticabile il nostro soggiorno a Venezia. Io e mio marito abbiamo amato l’atmosfera cordiale che si respira qui, la sua eleganza, quell’odore di cera che si sente prima di entrare in camera.
Mi sarebbe piaciuto conversare ancora con lei, come abbiamo fatto ieri pomeriggio, quando mi ha accompagnato da Nico alle Zattere perché avevo voglia di un gelato. Ecco, quel gianduiotto da passeggio annegato nella panna sarà il ricordo più dolce che mi porterò dalla laguna. Soprattutto la sua faccia imbarazzata nel vedere una madamina come me che si sbrodola come un’adolescente. Ma io ieri mi sono sentita di nuovo ragazza, e lei sa a cosa mi riferisco. Paura e pudore non mi permettono di scriverle di più, ma credo possa immaginare.
Non vorrei però tediarla con questi sentimentalismi, sono una donna dalla lacrima facile, ma sa com’è, noi torinesi non siamo così abituati a esprimere le nostre emozioni (a stento ho trovato il coraggio di scriverle queste poche righe).
Se le capiterà di venire a Torino, la prego di farmelo sapere. Sarebbe un piacere per me ricambiare questa fantastica passeggiata, e non solo.
Io, comunque, non la dimenticherò.
Elena
Giacomo ripose la lettera senza battere ciglio.
Intorno a sé, le scatole ancora da sistemare. Dentro la sua testa, la voce di Elena. Per un attimo, ma solo un attimo, dimenticò che era mercoledì.
![]()
Non aveva dubbi: era venuto male.
Non male. Da schifo. “Dev’essere per questo che hanno inventato le macchine digitali” pensava Giacomo. “Lo hanno fatto per quelli come me che s’imbarazzano davanti all’obiettivo, incapaci di sorridere a comando e la volta in cui provano a farlo sembrano dei cretini. Se poi ti capita la giornata no ti escono gli occhi chiusi.”
Salvo Brancata non era così. Lui sapeva stare in posa come un attore, felice di essere al mondo e di gioirne con tutti. I suoi occhi neri ti fissavano con l’orgoglio di chi per nessuna ragione cambierebbe qualcosa di sé. Abbracciava Giacomo con forza, in quella foto spuntata tra le pagine di Maupassant, e con il braccio gli cingeva il collo quasi a volerlo possedere. Lui invece stava impalato, le mani lungo il corpo, a provare a dire cheese. Erano tutti e due in pantaloncini e maglietta, sudati, dopo una partita. Toccò la foto con le dita, tratteggiando le due sagome, e gli parve di risentire quella mano su di sé.
«Vuoi una mano, mister?»
Mister? L’avevano chiamato in tanti modi, in quell’insolito ruolo che ricopriva: “cameriere”, “portiere”, “direttore”, “concierge”, “signore”, “dottore”. Una volta anche “ehi, capo”. Ma “mister” mai. Giacomo tolse la consueta maschera di cortesia e s’irrigidì per un attimo, cercando di nascondere la foto a quella vista estranea. Un ragazzo si era affacciato alla sua stanza, non avendo trovato nessuno nella hall.
«No, la ringrazio. Non si disturbi.»
«Ma non è disturbo, è un piacere. Io vorrei sempre incontrare qualcuno che mi dà una mano.»
«Io no.»
Prima la signora Silvana, ora un emerito sconosciuto. Il “mister” si rese conto che stava per perdere il controllo, ma non era abituato a farsi vedere in pubblico così, con la cravatta allentata, i capelli che lo rendevano più simile a un quadro impressionista che a un mosaico bizantino. Non si prevedeva l’arrivo di nessuno prima di mezzogiorno, per cui gli era sembrato il momento migliore per spostare i bagagli. Anche se a muoversi, più che i bagagli, erano stati i ricordi. Giacomo nascose la foto nel libro cercando di non dare importanza a quel gesto, ma aveva il viso di chi si sente scoperto in un momento troppo privato.
«È ospite della locanda?»
«Sì. Ma sono con una ragazza che mi paga tutto, capito? Anche tu dormi qui, stasera?»
«Io dormo qui da quindici anni. Sono il concierge.»
«Cosa sei, scusa?»
«Il portiere, diciamo. Anche se il mio ruolo è un po’ più complesso.»
Questo è quello che rispose. In realtà, avrebbe voluto dire: “Perché secondo lei vengo male nelle foto?”.
«Anche io facevo il portiere. Prima al Santos e poi al Mirasol.»
«E dove sono questi alberghi?»
«Ma non sono hotel... sono squadre di calcio brasiliane.»
Alla parola “calcio”, Giacomo ebbe un nuovo momento di distrazione, ma si sforzò di concentrarsi. Non era solito trascurare l’interlocutore. Trasformò l’imbarazzo in un sorriso accennato, e cercò di resistere alla tentazione di guardargli i piedi. Alla fine cedette: scarpe da tennis usate a dismisura, forse taroccate, quindi estrazione semplice ma coraggio spiccato. Si trovava davanti un individuo assai diverso rispetto ai clienti con cui aveva a che fare abitualmente, a parte i soliti americani. L’uomo lo stava fissando appoggiato allo stipite della porta, senza distogliere lo sguardo, e a lui per un attimo parve di rivedere il volto della foto. Rimise il libro nello scatolone e si rese conto che non aveva ancora dato il benvenuto al nuovo ospite della locanda. Si alzò per andargli incontro e stringergli la mano.
Anche se era un albergo raffinato, tutti lo chiamavano affettuosamente “la locanda”. “La locanda dell’Abadessa”, per la precisione, perché in origine era un convento. Nei secoli sarebbe diventato di tutto, da casinò a boudoir, prima di tornare alla sua vocazione originaria: un luogo di culto. Quattordici stanze nel cuore di Cannaregio, a due passi da San Marco ma distante anni luce da San Marco – il sestiere – con le sue calli intasate e i negozi tutti uguali. A Cannaregio si respirava ancora l’aria della Venezia che appartiene a tutti, ai turisti e ai suoi abitanti. E i turisti che sceglievano di soggiornare qui trovavano in Giacomo il portavoce perfetto. Perché aveva girato il mondo e ne aveva carpito i segreti, e perché amava Venezia più dei veneziani. O forse aveva soltanto avuto il privilegio di scoprirla da adulto – l’amore maturo – preferendola a Roma e Parigi.
Per togliere gli occhi da quelle scarpe logore, si guardò le mani: erano nere di polvere. Cercò di nasconderle, fece un cenno di attesa, e rientrò in quella che non sarebbe più stata la sua casa. In quindici anni aveva già lasciato tre stanze, nel tentativo di cambiare vita tre volte. Ma a ogni occasione aveva finito per ricostruirsi il suo mondo di piccole certezze. Questa volta aveva semplicemente constatato che erano passati cinque anni dall’ultimo trasloco, e gli era sembrata una decisione più che ragionevole.
Gli ultimi scat...