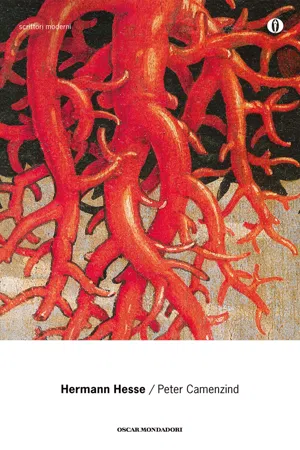![]() Peter Camenzind
Peter Camenzind![]()
I
In principio era il mito. Come il grande Iddio poetava e andava in cerca di espressione nelle anime degli indiani, dei greci e dei germani, così va ripoetando tutti i giorni nell’anima di ogni fanciullo.
Non sapevo ancora come si chiamassero il lago e i monti e i ruscelli del mio paese. Ma vedevo stesa al sole la verdazzurra e liscia superficie del lago trapunta di piccoli lumi e intorno, in fitta corona, i monti ripidi e nelle loro più alte fenditure i lucidi nevai e le minuscole cascate e ai loro piedi i prati obliqui e luminosi cosparsi di alberi da frutta, di capanne e di grigie mucche dell’alpe. E siccome la mia povera piccola anima era vuota, silenziosa e in attesa, gli spiriti del lago e della montagna vi scrissero le loro belle, ardite gesta. Le pareti rigide e gli erti versanti parlavano con orgoglio e con rispetto dei tempi di cui sono figli e di cui portano le cicatrici. Parlavano di quando la terra si fendette e si torse e dal suo corpo tormentato mandò fuori, tra i gemiti del parto, le vette e le creste. Monti rocciosi sorsero ruggendo e crepitando finché, nell’ascesa senza meta, si spezzarono in cima; monti gemelli lottarono disperatamente per lo spazio, finché uno vinse, salì e respinse il fratello mandandolo in frantumi. Fin da quei tempi erano rimaste nelle gole le vette scapitozzate, le rocce respinte e spaccate, e a ogni sgelo la valanga d’acqua portava a valle blocchi grandi come case, li frantumava come vetro e li affondava d’un colpo nei morbidi prati.
Dicevano sempre la stessa cosa, quei monti di roccia. Ed era facile comprenderli osservandone le ripide pareti, gli strati infranti, curvati, scoppiati, ciascuno straziato da ferite aperte. Abbiamo sofferto spaventosamente, dicevano, e ancora soffriamo. Ma lo dicevano con orgoglio, con serietà e con sdegno come vecchi guerrieri gagliardi.
Sì, guerrieri. Li vedevo combattere con l’acqua e con la bufera nelle paurose notti primaverili, quando lo scirocco ululava accanito intorno al loro capo e quando i torrenti strappavano loro dai fianchi macigni rudi e grondanti. Tetri, senza respiro e incaponiti stavano abbarbicati in quelle notti alle radici tese, ergevano contro l’uragano le pareti e le guglie provate dalle intemperie e, minacciosamente accovacciati, tendevano tutte le loro forze. A ogni ferita facevano sentire l’orrido rotolio della collera e dell’angoscia, e attraverso i più lontani anfratti riecheggiava, rotto e adirato, il loro spaventoso ansimare.
E vedevo prati e pendii e fratture terrose coperte di erbe e fiori, di felci e muschi, ai quali l’antica lingua popolare aveva dato nomi strani e pieni di mistero. Vivevano, quei figli e nipoti della montagna, innocui e multicolori al loro posto. Io li palpavo, li osservavo, ne aspiravo il profumo e ne imparavo il nome. Più a fondo mi toccava la vista degli alberi. Vedevo ciascuno di essi fare una vita isolata, formare il suo fogliame particolare e gettare un’ombra tutta sua. Eremiti e combattenti, mi parevano più affini ai monti, perché ciascuno, specialmente quelli che stavano più in alto, doveva combattere tenace e silenzioso con il vento, con la pioggia e con il pietrame, per poter vivere e crescere. Ciascuno aveva il suo peso da portare e doveva aggrapparsi al terreno, e a ciò ognuno doveva la sua forma e le sue ferite speciali. C’erano abeti ai quali la tormenta permetteva di portare rami soltanto da un lato e altri i cui tronchi rossastri si erano attorti come serpenti sulle rocce strapiombanti di modo che albero e macigno si stringevano e reggevano l’un l’altro. Mi guardavano come uomini di guerra e nel mio cuore suscitavano timore e rispetto.
Ma i nostri uomini e le nostre donne assomigliavano a loro, erano duri, rigidamente chiusi e di poche parole: più erano buoni, meno parlavano. Perciò imparai a guardare gli uomini come alberi o rupi, a riflettere sul loro conto e a rispettarli non meno e ad amarli non più degli abeti taciturni.
page_no="4" Nimikon, il nostro villaggetto, giace su un piano obliquo triangolare incuneato fra due propaggini montane in riva al lago. Una strada porta al vicino monastero, un’altra a un villaggio distante quattro ore e mezza, mentre gli altri villaggi del lago si raggiungono per via d’acqua. Le nostre case sono di legno, costruite all’antica, e non hanno un’età determinata; non si costruiscono quasi mai case nuove, e le vecchie vengono riassestate, secondo il bisogno, a mano a mano; quest’anno si rifà il tinello, un’altra volta si ripara il tetto, e certe mezze travi o certe tavole che una volta facevano parte, poniamo, del rivestimento di una stanza, si trovano ora a far da correnti nel tetto, e quando non servono più nemmeno lì, ma non è ancora il momento di farne legna da ardere, si adoperano per rassettare la stalla o il fienile o per ricavarne il paletto della porta di casa. Lo stesso accade di quelli che ci vivono; ognuno rappresenta la sua parte fintanto che può, poi si ritira mogio nella cerchia degli inservibili e sprofonda infine nelle tenebre senza che se ne faccia molto scalpore. Chi ritorna da noi dopo anni di lontananza non trova nulla di mutato se non qualche vecchio tetto rinnovato e qualche tetto nuovo invecchiato; i vecchi di allora sono scomparsi, è vero, ma altri vecchi abitano nelle medesime stamberghe, hanno gli stessi nomi, sorvegliano un’uguale figliolanza dai capelli scuri, e nel volto e nei gesti si può dire che non si distinguono da quelli che nel frattempo sono passati a miglior vita.
Mancava al nostro comune un più frequente afflusso di sangue fresco e di vita da fuori. Gli abitanti, una razza piuttosto robusta, sono quasi tutti imparentati fra loro e per buoni tre quarti portano il nome di Camenzind. Questo riempie le pagine del registro di chiesa, appare sulle croci nel cimitero, fa pompa di sé sulle case dipinto a olio o grossolanamente intagliato, e lo si legge sui veicoli del carrettiere, sulle secchie della stalla e sulle barche del lago. Anche sopra la porta di mio padre avevano pitturato la scritta: “Questa casa fu eretta da Jost e Franziska Camenzind”, ma non si trattava di mio padre, bensì di suo nonno, il mio bisavolo; e se un giorno morirò probabilmente senza figli, so tuttavia che un altro Camenzind albergherà nel vecchio nido, sempreché questo rimanga in piedi fino allora e mantenga il tetto sopra di sé.
page_no="5" Nonostante l’apparente monotonia, nel nostro comune c’erano i buoni e i cattivi, i preminenti e gli umili, i potenti e i deboli, e accanto a parecchie intelligenze una piccola e spassosa raccolta di matti, senza calcolare i cretini. Come dappertutto, davamo una piccola immagine del mondo grande, e siccome grandi e piccini, furbacchioni e stolti, erano indissolubilmente legati e imparentati fra loro, abbastanza spesso la severa superbia e la limitata leggerezza si pestavano i piedi sotto il medesimo tetto, di modo che la nostra vita aveva spazio sufficiente per il lato profondo e per la parte comica dell’umanità. Salvo che vi si stendeva un costante velo di oppressione nascosta o inconsapevole. Il dipendere dalle forze della natura e le strettezze di un’esistenza faticosa avevano instillato, con l’andar del tempo, alla nostra famiglia ormai invecchiata una tendenza alla riflessione profonda che ben si adattava alle facce aspre e stagliate, ma non recava altri frutti: frutti buoni, s’intende. Appunto perciò si era contenti di quei quattro matti che, abbastanza quieti e serii, pur recavano un po’ di colore e qualche occasione di risa e di sarcasmi. Quando uno di loro faceva parlare di sé per qualche nuovo tiro, sui visi abbronzati e rugosi dei figli di Nimikon passava un lampeggiare allegro, e al piacere dello spasso si aggiungeva, fine condimento da farisei, il sapore della propria superiorità che faceva schioccare la lingua per la gioia, e la convinzione di essere immune da siffatti errori e passi falsi. Tra coloro che in buon numero stavano nel mezzo fra giusti e peccatori e avrebbero volentieri assaporato il lato piacevole degli uni e degli altri, c’era anche mio padre. Non maturava alcun tiro birbone che non gli mettesse addosso una beata inquietudine, e allora egli titubava fra l’ammirazione simpatizzante per l’ideatore e la grassa coscienza della propria illibatezza.
Tra i matti stessi c’era mio zio Konrad, senza che per questo egli avesse meno intelligenza di mio padre e di altri eroi. Era anzi una testa scaltra, sempre agitato da un irrequieto spirito inventivo che gli altri potevano tranquillamente invidiargli. Vero è che nulla gli riusciva. Che poi, invece di accasciarsi e di mettersi a rimuginare con le mani in mano, corresse sempre a nuove imprese e avesse il senso insolitamente vivo del tragicomico in quelle sue trovate, era indubbiamente un vantaggio che però gli si ascriveva come ridicola originalità per la quale veniva annoverato fra i pagliacci non stipendiati del comune. I rapporti di mio padre con lui erano un continuo ondeggiare fra l’ammirazione e il disprezzo. Ogni nuovo progetto del cognato provocava la sua enorme curiosità e inquietudine, che invano egli cercava di nascondere sotto caute domande e ironiche allusioni. Quando poi lo zio riteneva di essere sicuro del successo e incominciava a darsi grandi arie, mio padre si lasciava ogni volta trascinare e si univa a quel genio in speculazioni fraterne finché arrivava l’inevitabile fallimento che lo zio accoglieva con una alzata di spalle, mentre mio padre in collera lo copriva di sarcasmi e di offese, e per mesi non lo degnava d’uno sguardo o di una parola.
Se il nostro villaggio poté vedere la prima barca a vela, fu per merito di Konrad, e a ciò si dovette prestare la barca di mio padre. La vela e i cordami furono preparati dallo zio per benino, in base a incisioni in legno del calendario, e se la nostra barchetta era troppo sottile per essere una barca a vela, dopotutto non fu colpa di Konrad. I preparativi durarono settimane: mio padre, per l’orgasmo e la speranza, era quasi diventato argento vivo, e anche il resto del villaggio non parlava se non del nuovissimo progetto di Konrad Camenzind. Fu una giornata memorabile per noi, quando la barca, in un mattino ventoso dell’estate avanzata, prese il largo la prima volta. Mio padre, con il timido presentimento di un’eventuale catastrofe, si tenne lontano: e con mio grande rammarico aveva proibito anche a me di partecipare alla gita. Soltanto il figlio del fornaio Füssli accompagnò il mago della vela; ma tutto il paese raccolto sullo spiazzo inghiaiato del nostro giardino assistette all’inaudito spettacolo. Soffiava sul lago, verso valle, un forte vento di levante. Da principio il fornaio dovette remare finché la barca giunse nella corrente d’aria che gonfiò la vela spingendola a una corsa superba. Ammirati, la vedemmo doppiare il primo promontorio, e ci preparammo ad accogliere trionfalmente al ritorno l’astuto zio e a vergognarci delle nostre ironiche riserve mentali. Ma quando durante la notte la barca tornò, non aveva più vela, i naviganti erano più morti che vivi e il fornaretto ci disse tossendo: «Avete perduto un magnifico spettacolo: poco è mancato che questa domenica doveste dare due banchetti funebri». Mio padre dovette inserire nella barca due nuove coste, e da quel giorno nessuna vela si è mai specchiata nell’azzurro piano. Per molto tempo, quando Konrad aveva qualche motivo di fretta, gli gridavano: «Konrad, prendi la vela!». Mio padre inghiottì il dispetto, e quando incontrava il povero cognato guardava dall’altra parte lanciando uno sputo per indicare il suo indicibile disprezzo. Così si andò avanti finché un giorno Konrad venne a parlargli di un progettato forno a prova di fuoco che procurò all’inventore beffe senza fine e a mio padre la perdita di quattro talleri in contanti. Guai a chi osava rammentargli la storia di quei quattro talleri! Una volta, molto tempo dopo, ci si trovava in bisogno, mia madre senza pensarci disse che sarebbe stato bello avere quei soldi sprecati così iniquamente. Mio padre diventò rosso fino al collo, ma si contenne limitandosi a dire: «Vorrei averli bevuti in una sola domenica all’osteria!».
Al termine di ogni inverno arrivava lo scirocco con il suo rombo profondo che l’alpigiano ode con tremore e spavento, mentre in paesi stranieri lo bramano con struggente nostalgia.
Uomini e donne, montagne, selvaggina e bestiame lo sentono molte ore prima che si avvicini. La sua venuta, quasi sempre preceduta da freschi venti contrarii, si annuncia con un sibilo caldo e profondo. Per qualche istante il lago verdazzurro diventa nero come l’inchiostro e all’improvviso s’incorona di spume candide e irrequiete: tranquillo e silenzioso fino a qualche minuto prima, incomincia a tuonare con l’accanita risacca di un mare contro la riva. Nello stesso tempo tutto il paesaggio si rannicchia per paura. Sulle cime che di solito sognano in remote lontananze si possono ora contare i macigni, e nei villaggi che normalmente sembrano macchie brune laggiù in riva al lago, si distinguono ora tetti, cornicioni e finestre. Tutto si restringe, monti, prati, case, come un gregge impaurito. Poi incominciano i fischi rabbiosi e la terra trema. Onde del lago sollevate si disperdono nell’aria come fumo e, specialmente di notte, si ode la disperata battaglia tra l’uragano e le montagne. Poco tempo dopo si sparge la notizia di torrenti colmati, di case divelte, di barche fracassate, di padri e fratelli dispersi.
Quando ero ragazzo avevo paura dello scirocco e anzi lo odiavo. Ma con il destarsi della fierezza adolescente incominciai a benvolerlo, quel ribelle eternamente giovane, quell’insolente e pugnace apportatore di primavera. Era pur bello vederlo intraprendere, pieno di vita, di slancio e di speranze, la sua lotta selvaggia e infuriare e ridere e dolersi, mentre infilava le gole urlando, divorava la neve dei monti, piegava con mano rude i vecchi abeti tenaci e li faceva gemere. Più tardi il mio amore si approfondì e nello scirocco salutava il dolce, bello e fin troppo delizioso Mezzogiorno donde sempre nuovi fiumi di piacere, di calore e di bellezza sgorgano per cozzare contro la montagna e infine dissanguarsi, stanchi e sfiniti, nel piatto e freddo Settentrione. Non vi è nulla di più strano e delizioso della dolce febbre sciroccale che, alla sua stagione, coglie gli uomini dei paesi alpini e specialmente le donne e ruba il sonno e stimola i sensi con le sue carezze. È il Sud che impetuoso e infiammato butta le braccia al collo al Nord più povero e ritroso, e ai villaggi alpini sepolti nella neve annuncia che in riva ai vicini laghi purpurei dell’Italia sono rifioriti narcisi e primule e i rami del mandorlo.
Quando poi lo scirocco ha finito di soffiare e le ultime sudicie valanghe si sono dileguate, allora viene il bello. Tappeti giallognoli e fioriti salgono da ogni parte verso i monti, le cime nevose e i ghiacciai si ergono nell’alto puri e beati, il lago si fa azzurro e caldo e rispecchia il sole e le nuvole migranti.
Tutto questo può ben riempire un’infanzia, e al caso una vita intera. Tutto questo parla infatti a voce alta e spiegata il linguaggio di Dio come non è mai uscito da labbra umane. Chi lo ha inteso nell’infanzia lo sente per tutta la vita, dolce e forte e tremendo, e al suo fascino non sfugge più. Quando uno è nato fra i monti può studiare per anni filosofia o storia naturale e far sgomberare il vecchio Padreterno... ma se un giorno risente lo scirocco o avverte una frana che precipita nel bosco, il cuore gli trema nel petto, e il suo pensiero si rivolge a Dio e alla Morte.
Attiguo alla casetta di mio padre c’era un minuscolo orto cintato. Vi crescevano un’insalata stenta e rape e cavoli, e oltre a ciò mia madre aveva disposto una misera aiuola per i fiori, stretta da commuovere, dove smorivano senza speranza due piante di rose d’ogni mese, un ciuffo di giorgine e una manciata di reseda. Accanto all’orto, in un breve tratto inghiaiato che scendeva fino al lago, c’erano due botti sfondate, alcune tavole e qualche palo, e giù nell’acqua era ormeggiata la barca che veniva rattoppata e calafatata ogni due anni. I giorni destinati a questo lavoro mi sono rimasti fissi nella memoria. Erano caldi pomeriggi di prima estate, nell’orto svolazzavano al sole le cedronelle color zolfo, il lago era un olio silenzioso, azzurro e leggermente cangiante, le cime erano avvolte in radi vapori e nel piccolo spiazzo inghiaiato alitava un acuto sentore di pece e di colore a olio. Anche in seguito, per tutta l’estate, la barca odorava di catrame. Ogni qualvolta in riva al mare, molti anni dopo, sentivo nel naso il caratteristico odore d’acqua e di catrame bollente, mi pareva di rivedere il nostro posticino in riva al lago e mio padre in maniche di camicia con il pennello in mano; vedevo le nuvolette azzurrognole che dalla pipa salivano nella quieta aria estiva, e le farfalle guizzanti che saettavano pavide e incerte. In quei giorni mio padre era di umore insolitamente sereno, fischiettava egregiamente i suoi trilli e talvolta mandava persino un breve grido di gioia, ma a mezza voce soltanto. Mia madre preparava qualcosa di buono per la cena, e ora penso lo facesse con la tacita speranza che quella sera Camenzind non andasse all’osteria. Ma egli ci andava lo stesso.
Non saprei dire se i miei genitori abbiano favorito o turbato lo sviluppo della mia giovane mente. La mamma era sempre indaffarata, e il babbo non si era certo mai occupato di problemi educativi. A sua volta aveva abbastanza da fare per coltivare quei quattro alberi da frutto, vangare il campicello delle patate e badare al fieno. Ogni due settimane all’incirca, la sera prima di uscire, mi prendeva per mano e in silenzio mi conduceva nel fienile sopra la stalla. Là si compiva uno strano rito di castigo e di espiazione: mi prendevo una scarica di busse senza che mio padre o io stesso sapessimo veramente perché. Erano segreti sacrifici sull’altare della Nemesi, offerti da parte sua senza rimproveri, da parte mia senza grida, come imprescindibile tributo a un ignoto potere. Sempre più in là negli anni, quando udivo parlare della sorte “cieca” ricordavo quelle scene misteriose che mi parevano un’immagine molto plastica di quel concetto. Senza saperlo, il mio buon babbo seguiva quella semplice pedagogia che la vita stessa esercita su noi in quanto ci manda ogni tanto un fulmine a ciel sereno, lasciandoci a riflettere con quali misfatti abbiamo sfidato i poteri superni. Purtroppo questa riflessione io non la facevo mai o solo di rado: prendevo invece quella punizione a rate, rassegnato o magari indignato, senza l’auspicato esame di me stesso, e quelle sere ero contento di aver pagato la mia tassa e di avere davanti a me qualche settimana d’intervallo senza castighi. Con molto maggiore indipendenza mi opposi ai tentativi del mio vecchio di avviarmi al lavoro. La natura incomprensibile e prodiga aveva abbinato in me due doti contrastanti: una insolita forza fisica e una purtroppo non minor avversione al lavoro. Mio padre si sforzava in tutti i modi di fare di me un bravo figliolo e collaboratore, mentre io scantonavo con mille sotterfugi per evitare i lavori che mi erano affidati, e fino al ginnasio non ebbi per nessun eroe antico tanta compassione quanta per Ercole costretto alle famose e noiose fatiche. Per il momento nulla sapevo di più bello che vagabondare oziando per prati e rupi o lungo il lago.
Le montagne, il lago, le tempeste e il sole erano i miei educatori ed amici, che per molto tempo mi furono più cari e più noti degli uomini e del loro destino. Ma le cose preferite e a me ancor più dilette del lago splendente, degli abeti malinconici e delle rocce solatie, erano le nubi.
Mostratemi nel vasto mondo l’uomo che conosca e ami le nuvole più di me. O mostratemi una cosa al mondo che sia più bella delle nuvole! Sono gioco e conforto agli occhi, sono benedizione e dono di Dio, sono collera e potenza mortale. Sono tenere, delicate e pacifiche come le anime dei neonati, belle, ricche e generose come angeli buoni, scure, inesorabili e spietate come gli araldi della morte. Si librano argentee a strati sottili, veleggiano ridendo bianche e orlate d’oro, si soffermano a riposare tinte di giallo, di rosso e d’azzurro. Strisciano sinistre e lente come assassini, passano sibilando a rompicollo come folli cavalieri, pendono tristi e sognanti in pallide altezze come malinconici anacoreti. Assumono la forma d’isole beate e di angeli benedicenti, somigliano a mani minacciose, a vele schioccanti, a gru trasmigranti. Si librano fra il cielo di Dio e la povera terra come belle similitudini dell’umana nostalgia, appartenenti all’uno e all’altra, sogni della terra, nei quali la loro anima contaminata si stringe al cielo puro. Sono l’eterno simbolo del viaggiare, della ricerca, del desiderio e della nostalgia. E come pendono pavide, desiderose e caparbie fra cielo e terra, così le anime umane pendono pavide, desiderose e caparbie fra il tempo e l’eternità.
Oh, le nuvole belle, sospese, instancabili! Ero fanciullo, ignorante, e le amavo, le guardavo e non sapevo che anch’io sarei passato come una nuvola attraverso la vita, migrando forestiero dappertutto e sospeso fra il tempo e l’eternità. Fin dall’infanzia mi sono state care amiche e sorelle. Non posso passare per la strada senza che ci scambiamo un cenno, che ci salutiamo e ci soffermiamo un istante a guardarci. Né ho dimenticato ciò che allora da esse imparai: le loro forme, i colori, i lineamenti, i loro giochi, le danze e i riposi, e le lo...