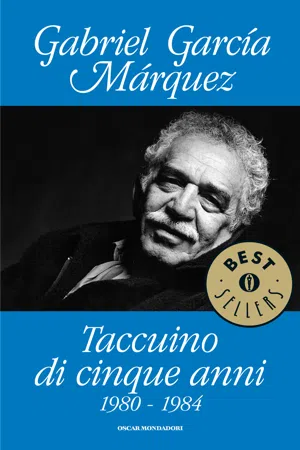
- 672 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Gli eroi e i sogni, la politica e la storia, i viaggi e gli incontri, le città e i ricordi. Gabriel García Márquez racconta una parte importante della sua vita: esperienze personali che per molti aspetti si intrecciano con avvenimenti e personaggi in primo piano sulla scena internazionale e per altri, invece, ispirano le sue più famose invenzioni narrative.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Taccuino di cinque anni di Gabriel García Márquez, Angelo Morino in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804521662eBook ISBN
97888520160111981
Caraibi magici
Il Suriname – come non tutti sanno – è un paese indipendente sul mar dei Caraibi, che sino a pochi anni or sono fu una colonia olandese. Comprende 168.820 chilometri quadrati e un po’ più di 384.000 abitanti di origine molteplice: indiani dell’India, indiani locali, indonesiani, africani, cinesi ed europei. La sua capitale, Paramaribo – che noi di lingua spagnola pronunciamo come parola piana e che i nativi pronunciano come sdrucciola – è una città fragorosa e triste, dallo spirito più asiatico che americano, dove si parlano quattro lingue e numerosi dialetti aborigeni, oltre alla lingua ufficiale (l’olandese) e si professano sei religioni: induista, cattolica, musulmana, morava, olandese riformata e luterana. Attualmente, il paese è governato da un regime di militari giovani, di cui si sa molto poco, persino nei paesi vicini, e nessuno si ricorderebbe del Suriname se non fosse perché una volta alla settimana è il consueto scalo di un aereo olandese in volo da Amsterdam a Caracas.
Avevo sentito parlare del Suriname fin da bambino, non per via del Suriname stesso – che allora si chiamava Guyana Olandese – ma perché era ai confini della Guyana Francese, la cui capitale, Caienna, fu sino a poco tempo fa la terribile colonia penale nota, nel bene e nel male, come Isola del Diavolo. I pochi riusciti a fuggire da quell’inferno, che potevano essere terribili criminali o idealisti politici, si disperdevano per le isole numerose delle Antille finché non riuscivano a tornare in Europa o si stabilivano sotto una nuova identità in Venezuela o sulla costa caraibica della Colombia. Il più celebre fra tutti fu Henri Charrière, autore di Papillon, che prosperò a Caracas come promotore di ristoranti e altri mestieri meno diafani, e che morì pochi anni fa all’apice di una gloria letteraria effimera, ma meritoria quanto immeritata. Questa gloria, in realtà, spettava, con migliori titoli, a un altro fuggiasco francese che descrisse molto prima di Papillon gli orrori dell’Isola del Diavolo, e tuttavia non figura oggi nella letteratura di alcun paese, né il suo nome si trova nelle enciclopedie. Si chiamava René Belbenoit, aveva fatto il giornalista in Francia prima di essere condannato all’ergastolo per un fatto che nessun giornalista di oggi è riuscito a precisare, e continuò a farlo negli Stati Uniti, dove trovò asilo e dove morì in età veneranda.
Alcuni di questi profughi si rifugiarono nel paese dei Caraibi colombiani dove io sono nato, ai tempi della «febbre del banano», quando i sigari non li si accendeva con fiammiferi, ma con biglietti da cinque pesos. Parecchi si fusero con la popolazione e divennero cittadini rispettabilissimi, che sempre si distinsero per il loro parlare ostico e per l’ermetismo del loro passato. Uno di loro, Roger Chantal, che era arrivato senza altro mestiere che quello di cavadenti senza anestesia, divenne milionario dalla sera alla mattina senza alcuna spiegazione. Dava certe feste babiloniche – in una cittadina inverosimile che aveva pochissimo da invidiare a Babilonia –, si ubriacava a morte e gridava nella sua felice agonia: «Je suis l’homme le plus riche du monde». In preda al delirio assunse certi atteggiamenti da benefattore che nessuno gli conosceva fino ad allora, e regalò alla chiesa un santo di gesso a grandezza naturale, che fu intronizzato con una baldoria di tre giorni. Un martedì qualunque arrivarono col treno delle undici tre agenti segreti che si recarono subito a casa sua. Chantal non era lì, ma gli agenti fecero una perquisizione minuziosa in presenza della sua moglie indigena, che non oppose alcuna resistenza, tranne quando vollero aprire l’enorme armadio nella camera da letto. Allora gli agenti ruppero gli specchi e trovarono oltre un milione di dollari in banconote false nascoste fra il vetro e il legno. Non si seppe mai più nulla di Roger Chantal. In seguito circolò la leggenda secondo cui il milione di dollari falsi era entrato nel paese dentro il santo di gesso, che nessun agente della dogana aveva avuto la curiosità di controllare.
Tutto questo mi tornò d’improvviso alla memoria poco prima del Natale del 1957, quando dovetti fare uno scalo di un’ora a Paramaribo. L’aeroporto era una pista di terra spianata con una baracca di legno di palma, al cui palo di sostegno centrale c’era uno di quei telefoni da film di cow-boy, con una manovella che si faceva girare con forza e molte volte fino a ottenere la risposta. Il caldo era torrido, e l’aria, polverosa e immobile, aveva l’odore di caimano addormentato con cui si identificano i Caraibi quando si arriva da un altro mondo. Su uno sgabello appoggiato al palo di sostegno c’era una donna nera molto bella, giovane e massiccia, con un turbante a molti colori come quelli che portano certe donne dell’Africa. Era incinta, prossima a partorire, e fumava una sigaretta in silenzio e come ho visto fare solo nei Caraibi: col fuoco dentro la bocca e soffiando il fumo dall’altra estremità, come la ciminiera di un bastimento. Era l’unico essere umano nell’aeroporto.
Dopo un quarto d’ora arrivò una jeep decrepita avvolta in una nuvola di polvere ardente, da cui scese un nero in pantaloni corti e casco di sughero con i documenti per far partire l’aereo. Mentre si occupava delle varie pratiche, parlava al telefono, gridando in olandese. Dodici ore prima io ero su una terrazza sul mare a Lisbona, davanti all’immenso oceano portoghese, guardando gli stormi di gabbiani che si infilavano nelle cantine del porto fuggendo dal vento glaciale. L’Europa era allora una terra decrepita coperta di neve, le giornate di luce non avevano più di cinque ore, ed era impossibile immaginare che esistesse davvero un mondo di sole canicolare e guayabe marce, come quello in cui eravamo appena calati. Tuttavia, l’unica immagine che sopravvisse a quell’esperienza, e che conservo ancora intatta, fu quella della bella nera impassibile, che aveva fra le gambe un canestro con rizomi di zenzero per venderli ai passeggeri.
Adesso, viaggiando sempre da Lisbona a Caracas, sono atterrato di nuovo a Paramaribo, e la mia prima impressione è stata che avessimo sbagliato città. Il terminal dell’aeroporto è ora un edificio luminoso, con grandi vetrate, aria condizionata tenuissima, odorosa di medicine per bambini, e quella musica in scatola che si ripete senza misericordia in tutti i luoghi pubblici del mondo. Ci sono negozi di articoli di lusso esentasse, numerosi e vari come in Giappone, e una caffetteria affollata dove si trovano mescolate e in fermento le sette razze del paese, le sue sei religioni e le sue lingue innumeri. Quel cambiamento non sembrava di vent’anni, ma di parecchi secoli.
Il mio professore Juan Bosch, autore, fra molte altre cose, di una monumentale storia dei Caraibi, disse una volta in privato che il nostro mondo magico è come quelle piante inarrestabili che rinascono sotto il cemento, finché non lo screpolano e lo spezzano, e rifioriscono nello stesso posto. L’ho capito meglio che mai quando sono uscito da una porta imprevista dell’aeroporto di Paramaribo e ho trovato una fila di vecchie donne sedute impavide, tutte nere, tutte con turbanti colorati e tutte intente a fumare con la brace dentro la bocca. Vendevano frutta e oggetti di artigianato locale, ma nessuna faceva il minimo sforzo per convincere la gente. Solo una di loro, che non era la più anziana, vendeva rizomi di zenzero. La riconobbi subito. Senza sapere da dove cominciare né che farmene davvero di quella scoperta, le comprai una manciata di radici. Mentre lo facevo, rammentando le sue condizioni della prima volta, le domandai senza preamboli come stava suo figlio. Non mi guardò neppure. «Non è un figlio, è una figlia», disse, «e a ventidue anni mi ha dato il mio primo nipote.»
6 gennaio 1981
Bisogna salvare El Salvador
Un amico, rincasato tardi dal lavoro, trovò la moglie che guardava alla televisione uno spettacolo orribile. Era una folla di uomini, donne e bambini massacrati dalle forze pubbliche sul sagrato di una chiesa. Molti erano morti, altri agonizzavano come vermi in un pantano di sangue e gli ultimi sopravvissuti si disperdevano spaventati sotto il fuoco delle mitragliatrici. Sembrava un’imitazione povera del massacro di Odessa in La corazzata Potëmkin, il memorabile film di Sergej Eisenštein. Ma più feroce e senza alcuna considerazione artistica. Il mio amico, che si spaventa col cinema dell’orrore, rimproverò alla moglie di star lì a guardare un film simile. Ma lei gli rispose impassibile: «Non è un film, sono le notizie da El Salvador». Questo accadde all’inizio dello scorso anno. Da allora, fino al dicembre appena trascorso, diecimila persone sono morte in quella carneficina continua. Come se l’anno bisestile fosse stato più bisestile a El Salvador che nel resto del mondo.
Ronald Reagan ha detto poco tempo fa che quella è una guerra civile in tre direzioni. Voleva sicuramente dire che da una parte c’è la dittatura militare, dall’altra ci sono le bande di criminali dell’estrema destra e dall’altra parte ancora le forze della rivoluzione. Ma l’aritmetica sociale di El Salvador è più semplice. A dire il vero, questa guerra civile, che è ormai la più sanguinosa dell’America Latina in tutta la sua storia, ha solo due contendenti: l’aristocrazia feudale, da una parte, e il resto della nazione dall’altra. Il 90 per cento della popolazione del paese – la cui densità demografica è una delle più alte del mondo – è composta da indiani e da meticci. Solo il 10 per cento è di bianchi, ma sono loro che controllano da sempre e con pugno di ferro la totalità del potere economico e politico. La proporzione delle vittime è pari: il 90 per cento dei morti del terribile anno bisestile appena trascorso erano dalla parte dei poveri. Tanto dei poveri in armi quanto degli inermi, incluso l’arcivescovo. Questo significa che, a differenza del Nicaragua, dove il Fronte sandinista è riuscito a mettere d’accordo gli antisomozisti di ogni grandezza e di ogni livello, le tensioni sociali di El Salvador si sono risolte in un irrimediabile scontro di classi. Il che spiega in gran parte la polarizzazione radicale di questa guerra, la sua ferocia insaziabile e la decisione di sterminio da entrambe le parti, con episodi così bestiali che sono ormai divenuti insopportabili persino alla televisione.
È una guerra antica. Fra il 1931 e il 1934, il paese ebbe a patire la dittatura del generale Maximiliano Hernández Martínez, un despota dalle arie di teosofo il cui difetto più notevole era il fatto di essere pazzo. Aveva inventato un pendolino magico che sospendeva sopra i cibi per controllare, secondo il suo oscillio, se erano avvelenati. In un’occasione cercò di scongiurare un’epidemia di scarlattina coprendo con carta rossa l’illuminazione pubblica del paese. Queste fantasie folcloristiche che, in fin dei conti, non molestavano nessuno, ebbero un’espressione brutale nel 1932, quando le forze armate affrontarono con armi da fuoco una vasta insurrezione agraria e uccisero trentunmila contadini. Lo ripeto affinché rimanga ben chiaro: trentunmila contadini. Da allora in poi, El Salvador è passato attraverso tutte le sfumature del potere militare e, per un verso o per l’altro, la guerra impari fra i ricchi e i poveri non ha avuto un istante di tregua. Il dissenso secolare si esprime oggi con i movimenti armati, le organizzazioni di massa e i partiti politici all’opposizione che hanno infine trovato una formula unitaria, la cui faccia pubblica è il Fronte democratico rivoluzionario. Si presume che abbiano cinquemila uomini forniti di armi, inclusi i pezzi di artiglieria media, e circa trentamila di riserve pronte per l’offensiva finale annunciata in questi giorni. Ma chi negli ultimi tempi si è recato a El Salvador sa che è un esercito popolare infiltrato ovunque. I suoi soldati sono vestiti da camerieri nei ristoranti, da domestiche negli alberghi, da autisti sui taxi e persino da preti con sottana nei confessionali. In queste condizioni, l’assalto decisivo di questi giorni potrebbe non essere illusorio come altri precedenti.
Il potere feudale, da parte sua, dispone dell’appoggio degli Stati Uniti e di forze armate benissimo armate. Dispone di ghenghe di assassini al soldo che fanno il lavoro sporco che il governo non si azzarda a fare per non mostrare la sua autentica faccia. Dispone, infine, di una frazione della Democrazia cristiana che si è dimenticata di Cristo e sembra disposta a non lasciare alcun cristiano vivo. A questa frazione appartiene anche l’attuale presidente della repubblica, Napoleón Duarte, che non è stato eletto da nessuno, bensì nominato dai militari in un momento critico per avere uno schermo civile.
Non è casuale questo atteggiamento della Democrazia cristiana. Al contrario, fa parte di una strategia globale, il cui paladino in America Latina è il nuovo presidente del Venezuela, Luis Herrera Campins, e la cui finalità immediata è fermare l’avanzata democratica nei Caraibi e nell’America Centrale, col pretesto di contrarrestare l’influenza cubana. Herrera Campins, di cui si dice che mangi caramelle tutto il giorno e che faccia la siesta dopo colazione, non ha esitato in questa operazione. In primo luogo, perché corrisponde alla sua ideologia, e in secondo, perché corrisponde alla sua ossessione di disfare tutto quel che ha fatto il suo predecessore, Carlos Andrés Pérez, contro il quale continua a opporsi dalla presidenza. Finora è riuscito a far schierare i governi del Patto andino contro la liberazione di El Salvador, con l’eccezione del presidente dell’Ecuador, Jaime Roldos, la cui vocazione progressista è indiscutibile. Ma il suo capolavoro è stato far sì che Napoleón Duarte fosse invitato come presidente legittimo al sesquicentenario di Simón Bolívar, mentre non è stato invitato il dittatore della Bolivia, come se il suo regime fosse più dittatoriale, più sanguinario e di origine meno legittima che quello di El Salvador. Comunque, e con pari diritto che Napoleón Duarte, avrebbero potuto invitare il presidente del Guatemala, il generale Romero Lucas, che almeno è salito al potere mediante una farsa elettorale.
Questo è il panorama che troverà Ronald Reagan la settimana prossima, quando si siederà sulla poltrona presidenziale degli Stati Uniti. Il presidente del Messico, José López Portillo, gli ha fatto dire in pubblico, e pensando sicuramente a El Salvador, che non interverrà in America Latina, che rispetterà la volontà dei paesi in cerca di definizioni nuove, che sono maggiorenni e capaci di occuparsi da soli dei loro affari. È probabile, inoltre – conoscendo il carattere di López Portillo – che gliel’abbia ripetuto in privato, e specificando i nomi, durante il loro recente incontro alla frontiera.
Tuttavia – in conformità a un memorandum del Dipartimento di Stato diffuso da «The New York Times» un mese fa – l’intervento degli Stati Uniti a El Salvador è già pronto fin nei minimi dettagli politici e militari. L’ha preparato il presidente Carter, e il presidente Reagan dovrà solo premere un bottone. Così come fece John F. Kennedy vent’anni fa, quando arrivò al potere e trovò il piano di invasione di Cuba preparato da Eisenhower. Dice il proverbio che nessun cane lo castrano due volte, ma il pericolo in questo caso è che si tratta di due cani diversi.
13 dicembre 1981
Venticinquemila milioni di chilometri quadrati senza un solo fiore
Quando Neil Armstrong sbarcò sulla superficie lunare, undici anni or sono, l’annunciatore televisivo esclamò emozionato: «Per la prima volta nella storia, l’uomo ha messo il piede sulla Luna». Un bambino che si trovava con noi, e che aveva seguito con ansia i dettagli dello sbarco, gridò sorpreso:
«Ma è la prima volta? Che stupidaggine!»
Il suo disincanto era comprensibile. Per un bambino del suo tempo, abituato a vagare ogni sera nello spazio siderale della televisione, la notizia del primo uomo sulla Luna era come un ritorno all’età della pietra. Anch’io rimasi con una sensazione di sconforto, ma per motivi più semplici. Stavamo passando l’estate nell’isola di Pantelleria, all’estremo sud della Sicilia, e non credo che esista al mondo un luogo più consono per pensare alla Luna.
Ricordo come in un sogno le pianure interminabili di roccia vulcanica, il mare immobile, la casa dipinta a calce fin negli scalini, dalle cui finestre si vedevano nelle notti senza vento i fasci luminosi dei fari dell’Africa. Esplorando i fondali addormentati intorno all’isola, avevamo scoperto una fila di siluri gialli lì incagliati dall’ultima guerra; avevamo recuperato un’anfora con ghirlande pietrificate che dentro aveva ancora i residui di un vino immemore corroso dagli anni, e avevamo fatto il bagno in una gora fumante le cui acque erano così dense che si poteva quasi camminarvi sopra.
Io pensavo con una certa nostalgia premonitrice che così doveva essere la Luna. Ma lo sbarco di Armstrong aumentò il mio orgoglio patriottico: Pantelleria era meglio.
Per noi che perdiamo tempo pensando a queste cose, ci sono a partire da allora due lune. La Luna astronomica, con la maiuscola, il cui valore scientifico dev’essere grandissimo, ma che manca completamente di valore poetico. L’altra è la Luna di sempre che vediamo sospesa nel cielo; la Luna unica dei licantropi e dei boleros, e che – per fortuna – nessuno raggiungerà mai.
Finora, la conquista dello spazio sembra condannata a questo tipo di delusioni. La più triste è che, dopo lo stupefacente viaggio del Voyager I, si può già affermare senza alcun dubbio che almeno in questa minuscola provincia del sistema solare non esiste la vita come noi la intendiamo. Venere e Mercurio, i due pianeti più vicini al Sole, sono stati scartati da molto tempo trattandosi di due palle incandescenti prive di valore commerciale. I canali di Marte, che presumevamo scavati dai nostri cugini dello spazio, non sembrano essere molto di più che pura illusione. Giove, trecentodiciassette volte maggiore della Terra, è un globo gigantesco con duecento gradi sotto zero. Dopo la fruttuosa esplorazione di Saturno, ci mancano solo da conoscere Urano, Nettuno e Plutone, i tre vecchi solitari dei sobborghi solari, le cui orbite sono così smisurate che l’ultimo di loro impiega più di duecentoquarantotto dei nostri anni per completare un giro intorno al Sole.
L’utilità scientifica di queste scoperte è incalcolabile, ma una cosa è chiara: lassù non c’è nessuno. È un’immensa notte glaciale di venticinquemila milioni di chilometri quadrati dove ci sono oceani di nitrogeno liquido, venti che sono dieci volte più devastanti dei tifoni di Sumatra e tempeste apocalittiche che possono durare persino trentamila anni. Ma non c’è un solo fiore. Neppure una misera rosa come questa sopra la mia scrivania, che si annoia forse perché non è nulla più di quel che è, senza sapere che da sola è un prodigio irripetibile dell’universo.
Luciano di Samosata – secondo quanto dice Jorge Luis Borges nel suo prologo a Cronache marziane di Bradbury – scrisse che i seleniti filavano e tessevano i metalli e il vetro, si toglievano e si mettevano gli occhi e bevevano succhi d’aria. È una citazione, come quasi tutte quelle di Borges, al contempo abbagliante e sospetta, ma illustra benissimo l’immagine che si aveva nel II secolo delle creature extraterrestri. Con i progressi della scienza e il raffinarsi dell’immaginazione, la visione non è migliorata, al contrario. Gli scrittori di fantascienza descrivono i nostri parenti siderali come esseri orrendi con orecchie da pipistrello, antenne invece di corna, membrane interdigitali e ventose nei sensi. Tutto quanto ha a che vedere con loro è di natura viscosa e infame, e il loro unico vantaggio su di noi sono le armi luciferine e la prodigiosa intelligenza nella malvagità. Il cinema non ha mai ottenuto effetti di terrore più intenso che quelli dei film spaziali.
Forse la delusione circa il nostro vicinato celeste ci serve per rimediare a questo grave e ingiusto malinteso universale. Forse, dopo tanti millenni di fantasie meschine, cominceremo a capir...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Taccuino di cinque anni
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- Indice dei nomi e dei luoghi
- Copyright