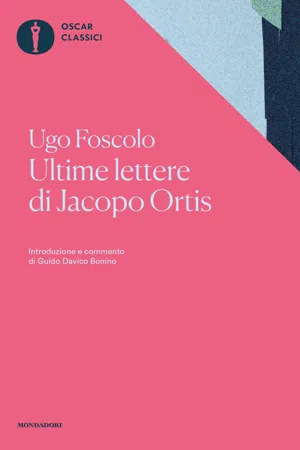
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Una nuova edizione del romanzo epistolare del Foscolo, uno dei libri più "sperimentali" della letteratura italiana, con un commento e un'interpretazione minuziosi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Ultime lettere di Jacopo Ortis di Ugo Foscolo in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804287520eBook ISBN
9788852016943di Guido Davico Bonino
Al Lettore
L’immaginario «editore» delle Lettere postume dell’Ortis assume il nom de plume di Alderani solo a partire da 1817: in 1798 si chiamava Lorenzo F., tramutato poi in Lorenzo A*** in 1802.
PARTE PRIMA
Solo da 1817 appare la divisione in due parti, cui corrispondeva, editorialmente, una partizione in due tomi.
Da’ colli Euganei, 11 Ottobre 1797.
Il celebre incipit (“Il sacrificio della patria nostra è consumato”) appare la prima volta in 1802. Il riferimento è al Trattato di Campoformio, ratificato, per l’esattezza, il 17 ottobre 1797, in base al quale il territorio della Repubblica Veneta, in cambio della Lombardia, veniva da Napoleone ceduto all’Austria. Viene così affrontato, senza perifrasi, il tema politico, in toni subito biblici (“E noi, pur troppo, noi stessi italiani ci laviamo le mani nel sangue degl’italiani”), e in base alla dicotomia, di elementare efficacia, patria-straniero (e a quella, che ne consegue, esilio-persecuzione).
13 Ottobre.
Gli “stranieri”, in mezzo ai quali il “patriota” Ortis è attanagliato, sono di due nazioni diverse: i francesi di Napoleone, “che ci hanno spogliati, derisi, venduti”, e gli austriaci, che “hanno comperato la nostra schiavitù”. Chiuso come in una morsa, Ortis prende a vagheggiare subito il suicidio, nella sottospecie del suicidio politico (“mi caccerei un coltello nel cuore per versare tutto il mio sangue fra le ultime strida della mia patria”): ma di ben altra valenza simbolica (nel gioco stretto delle opposizioni vita-morte, luce-tenebra) e di ben più forte efficacia espressiva è la metafora, che segue, del sepolto vivo, di evidente ascendenza shakespeariana (si pensa a Romeo and Juliet, ovviamente): metafora che fa la sua comparsa in 1802. Il “dolce lume della vita” è, com’è noto, un’eco dantesca (Inferno, X, 69).
16 Ottobre.
La solitudine deambulatoria di Jacopo (“Non vedo persona del mondo: vo sempre vagando per la campagna”) trova una sua prima, timida modulazione: mentre già s’accampa con pieno rilievo il figurino di Lauretta, figurino di morte (“Ella amava Eugenio, e l’è morto fra le braccia”) e di follia (“Bella e giovine ancora, ha pur inferma la ragione”): con “quella povera famiglia” di patrioti-esuli, sullo sfondo, fratelli in spirito di Ortis, vittime come lui della “Libertà” (ma in 1802 la parola, più esplicita, era “rivoluzione”).
18 Ottobre.
Il “divino Plutarco”, libro-chiave della giovanile formazione foscoliana, nella traduzione del Pompei (Verona, 1772) sulle orme del “maestro” Alfieri, è lettura prediletta di Jacopo. Compare già in 1798, al termine di una sequenza di immersione panica nella natura, dopo un bagno ristoratore in un “limpido lago” (“Così io riflettea diguazzandomi. Mi son rivestito e con due grappoli colti di fresco son ritornato a passare il resto della mattina in compagnia del mio Plutarco”: è la chiusa della prima parte della Lettera III). Ma qui se ne penetra, con lucida concisione, la pregnanza del messaggio morale: ed è chiaro che Ortis si specchia nei “quasi primati dell’umano genere” che sono gli eroi delle Vite parallele, perché sa d’essere eroe a sua volta.
23 Ottobre.
La scena di Jacopo che legge, “a mezzodì sotto il platano della chiesa”, ai contadini “le vite di Licurgo e di Timoleone” (e si badi quali eroi plutarchei sono scelti: due eroi di rigidissima tempra morale, un legislatore incrollabile e un odiator di tiranni) compare in 1802. In 1798 c’è già, invece, tutta la riflessione sul “conoscere la storia de’ tempi andati” (qui divenuta “sapere e ridire”) come illusoria prosecuzione del presente: una calata su uno sfondo idillico, di natura incontaminata, all’alba: “Quando sull’alba escono i più giovani con le gregge, e con l’aratro i più vecchi, io m’accompagno con uno di questi, il quale mi parla di mio nonno [...]”.
Tutto diverso, in 1798, l’approccio di Jacopo al “signore T***” e a “lo sposo promesso di sua figlia”. Jacopo ha una “lettera in tasca” di Lorenzo per un’amica di lui, che abita “discosta due miglia”. Nei pressi del “laghetto” in cui s’è bagnato, scorge “un giovane seduto sul tronco d’un albero tagliato” che sta disegnando a matita. Chiede al giovane che lo indirizzi alla villa dell’amica di Lorenzo. Lorenzo, che vi abita, gli fornisce indicazioni. L’indomani si ritrovano nei paraggi e insieme si recano alla villa. L’incontro è segnato da un primo giudizio positivo (“in verità non è bello, ma di una fisonomia così liberale, ch’io mi sono sentito in vederlo una delle mie solite simpatie”), subito dopo corretto da una brusca divergenza d’opinioni su una questione squisitamente artistica: “Parlando delle belle arti lungo il cammino ci è mancato poco che non si svegliasse una contesa fra noi. Egli credeva indegno dell’immortalità quell’artista che non si studiasse di perfezionar la natura [...] io mi sentiva un certo dispetto, e una smania d’interromperlo [...]”.
In 1802 s’innesta, invece, all’improvviso quel giudizio che, nella sua sbrigatività, non lascia adito a dubbi: “Sarà forse un bravo e buono giovine; ma la sua faccia non dice nulla”.
24 Ottobre.
L’episodio appare in 1798, alla Lettera XIII (dove, per l’esattezza, il “ribaldo contadinello” scavezza un “pomajo”, da 1802 in poi tramutato in “pesco”): ed è chiara, sino all’esemplarità didattica, l’opposizione-isolamento tra l’“eroe” Jacopo e la disonestà vile della collettività (la “società in miniatura”).
26 Ottobre.
È il secondo celeberrimo incipit delle Lettere ortisiane (il primo, in senso assoluto, è l’attacco della tematica politica; questo, della tematica erotico-esistenziale): e, tra l’altro, nella stesura che abbiamo dinnanzi, è ancor più incisivo che in 1802, dove suonava: “La divina fanciulla! io l’ho veduta, Lorenzo [...]”.
Nulla di così fremente né di così suggestivo in 1798, dove Teresa è data per entrata in scena, molto piattamente: “Sai tu chi è il giovane del quale ti ho già parlato? l’amico di Teresa. I venti e le pioggie incominciano a vietare i passeggi, ed io passo le intere mezze giornate con Teresa e con Odoardo” (Lettera IV). Teresa, in 1798, è vedova ed ha una “figliuoletta”, Giovannina (Lettera VII), che da 1802 diverrà la “sorellina” Isabellina.
Significativa, in 1817, la correzione: “Proferì, parmi, queste parole come se volesse farmi sentire che gli mancava sua moglie”, che sostituisce in 1802: “Proferì egli queste parole come se volesse farmi partecipe delle loro disgrazie, e della loro felicità”: significativa, perché, come avremo modo di notare, l’Ortis è anche un romanzo di madri assenti.
Si noti, ancora, l’appena suggerita premonizione di morte, in quell’aggettivo: “vedi per me una sorgente di vita: unica certo, e chi sa! fatale”.
28 Ottobre.
In calcolata alternanza a una lettera «privata» (e di decisiva importanza, se non altro a livello dell’intreccio: la Lettera del primo incontro con Teresa) una lettera «pubblica», di vibrante passione politica e di alta retorica formale, tra i due opposti poli dell’impotenza dell’eroe (si noti quegli aggettivi: “conculcata”, “neghittoso”; e quella voce verbale: “incepparci”) e del suo desiderio di annientamento, di suicidio politico a scopo dimostrativo (“Ahi, se potessi, seppellirei la mia casa, i miei più cari e me stesso [...]”) al cospetto delle due “potenti nazioni”, la Francia e l’Austria.
Il richiamo erudito ai “popoli” che si autodistrussero per non cedere “a’ Romani ladroni del mondo” e agli abitanti di Numanzia assediati da Scipione Emiliano (134-133 a.C.).
1 Novembre.
Ritratto impietoso dello “sposo” (cioè, promesso sposo) Odoardo, “cuore sempre così morto” e “faccia magistrale” inanimata: ritratto di borghese freddo, calcolatore (“e tutto con l’oriuolo alla mano”), di pseudointellettuale pedante (“con quella sua voce cattedratica, ricca e scelta”; “e via sempre con queste dissertazioni”).
In 1798 Odoardo è, invece, un artista raté (“Odoardo nacque pittore”), ricco e dissipato (a “Roma sua patria”, dopo un’adolescenza di novizio controvoglia): poi “ricondotto al retto sentiero” da Teresa, che “lo guarda come sua creatura” (Lettera V). “Buono, esatto, liberale, paziente”, è soltanto un poco frivolo e loquace (“non ha che un po’ di garrulità”) (Lettera VII).
Ripreso da 1798, letteralmente, è, invece, il profilo di Isabellina (là “Giovannina”, figlia, come s’è detto, non sorella): profilo che vedremo farsi, dopo questi primi accenni, vagamente inquietante, di bimba-adulta (e già qualcosa di erotico, seppure involontario, è in quel “Se tu la vedessi [...] negarmi un bacio e poi improvvisamente attaccarmi que’ suoi labbruzzi alla bocca!”).
12 Novembre.
Lettera su un rito agreste celebrato dal “giolito” – cioè, dal giubilo – “de’ bicchieri”: rito di fecondità giacché si piantano e trapiantano alberi, pioppi e pini. È allietato da un “Sole più sereno del solito” sulle prime nebbie di un freddo autunno, uno dei rari momenti di idillio rustico dell’Ortis 1802-1817: con quelle “villanelle” “co’ loro grembiuli di festa”, i loro “giuochi” e “danze”. E idilliache, quindi ottimistiche, sono le due proiezioni di sé, che Jacopo vagheggia di lì a poco: in veste di “canuto” narratore di “umili storie”, e poi di “uomo dabbene” ormai trapassato, venerato dallo “stanco mietitore”.
Ma la chiusa è dolorosa (“O illusioni!”), sottolineata dalla voluta forzatura di una terzina dantesca (Paradiso, XV, 118-120: con passaggio dal femminile plurale dell’originale al maschile singolare e mutamento del “letto” dantesco in “talamo”), per marcare lo straniamento degli esuli a opera dei “tiranni” francesi: e compare, significativamente, per la prima volta in 1817.
20 Novembre.
La notissima (anche per l’abuso antologico) lettera della gita ad Arquà (dalla vicina Feriole, dove Jacopo s’era rifugiato) è espressivamente assai notevole per più ragioni.
La prima è d’ordine compositivo, giacché vi si propone e vi si utilizza suggestivamente il modulo del «racconto nel racconto»: Jacopo narra, infatti, la celebre passeggiata, ma racconta anche di sé, nell’atto di narrare, sullo sfondo di una tempestosa giornata d’autunno (“Piove, grandina, fulmina”), tra interruzioni e forzate riprese (“Per dio! e’ m’è forza di proseguire la lettera: su l’uscio della casa ci è un pantano d’acqua che mi contrasta il passo”), e un finale rasserenante (“Il mal tempo s’è diradato, e fa il più bel dopo pranzo del mondo”).
La seconda è l’adozione di una tecnica da «letteratura sulla letteratura», e più precisamente della tecnica del pastiche, in quella descrizione del paesaggio (da “S’apriva appena il più bel giorno d’autunno” a “[...] al Sole, ministro maggiore della Natura”) che altro non è che la messa in prosa di una quindicina di versi del Prometeo di Vincenzo Monti (per l’esattezza, i vv. 35-50 del primo Canto, edito nel 1797 dal Marsigli; presso il quale Foscolo poté leggerli e citarli, in quanto tali, in 1798).
Tutta la lettera, del resto, è nutrita di citazioni letterarie: quella, esplicita, di due versi di un sonetto alfieriano, O cameretta che già in te chiudesti; quella, lievemente deformata, da una lettera tassiana ad Antonio Costantini (1595); quella dei tre incipit petrarcheschi “sommessamente” recitati da Jacopo (delle Canzoni 126 e 129 e del Sonetto 192). Ma il tono culto e solenne che ne sprigiona è, volutamente, a contrasto con l’incandescente temperie esistenziale del racconto: che è il racconto della profonda infelicità (“Non sono felice!”) e disperata solitudine (“non ho che voi solo”) di Teresa, condannata a un matrimonio d’interesse.
Affiora, nelle parole di Teresa, il profilo della madre assente (“vive divisa da noi e forse per sempre!”: un motivo-simbolo assai foscoliano, e ricorrente, più innanzi, nel racconto): e, a contrasto, incombente si fa quello del padre, “fiero e assoluto nelle sue risoluzioni”, che “[a]ma svisceratamente sua figlia [...] e intanto le tiene la mannaja sul collo”, “e nondimeno è di ottimo cuore” (figura di contraddizione irrisolta, come noteremo a più riprese); mentre irrimediabile risulta la prosaicità di Odoardo, che, giunto dinnanzi alla “sacra casa” del Petrarca, devia per “rivedere i conti al fattore d’una tenuta ch’egli ha in que’ dintorni”.
22 Novembre.
Autoritratto morale dell’eroe Jacopo, secondo due tratti fondamentali: la solidarietà con gli infelici (“io sono sempre in perfetta armonia con gl’infelici”), a sigillo della propria infelicità cronica, si vorrebbe dire «costitutiva»; e costante passionalità, sotto la febbre dell’irrequietezza: “questo mio cuore non può sofferire un momento, un solo momento di calma”.
A contrasto netto con Jacopo, prototipo degli “uomini appassionati”, simile al Dio aquilonio e procelloso di una simulata citazione biblica (è procedimento caro al Foscolo, che tutt’al più poteva ricordarsi dei Salmi 49 e 103), sta la “infeconda apatia” dei saggi e l’“indifferenza” di Odoardo (che in 1798 era detta, addirittura, “placida”).
27 Novembre.
Il laconico biglietto, che attesta, per allusione, la meravigliosa solitudine di due spiriti affini (in 1802 l’allusione era marcata da alcuni punti di sospensione a mezza frase) compare già in 1798. Ma nella prima stesura l’antefatto della storia Odoardo-Teresa era, oltreché radicalmente diverso, assai minuziosamente raccontato. Odoardo e Teresa vengono sorpresi in affettuoso atteggiamento da Jacopo; i due, senza nascondere il loro sentimento, narrano a Jacopo l’amore che li legava sin dalla loro “prima gioventù”, l’opposizione al matrimonio del tutore di Odoardo, la malattia e la morte del padre di Teresa, il matrimonio di lei, sola e senza sostanze, con un “galantuomo di Padova” più vecchio di vent’anni (che sapeva di non essere amato e non se ne lagnava), la nascita di Giovannina e la morte di lui tre anni dopo le nozze. Dopo il racconto Odoardo parte per Roma a “chiedere conto de’ suoi beni a’ figli del suo tutore morto da pochi giorni” (Lettera X). Da 1802 in poi, più prosaicamente, in coerenza con la grettezza del personaggio, Odoardo si reca a Roma per garantirsi l’eredità di un cugino.
3 Dicembre.
È la Lettera della scoperta del fascino fisico di Teresa, di cui, sino ad ora, avevamo, con Jacopo, ammirato, durante la passeggiata ad Arquà, i “grandi occhi neri”.
Teresa, conosciuta da Jacopo mentre “dipingeva il proprio ritratto”, qui suona l’arpa e canta: pittura dunque e musica, due arti belle che troveranno nelle Grazie compiuta celebrazione (e l’arpa è strumento prediletto, in quel contesto).
La scena era già in 1798, dove Teresa cantava la strofetta: “Sparir le Pleiadi – sparì la luna, – è a mezzo il corso – la notte bruna; – io sola intanto – mi giaccio in pianto”, uno dei frammenti di Saffo tradotti dal Foscolo nel 1794. Ma in quella stesura (Lettera XV) la fascinazione sensuale era assai più esplicita: “Posava un suo piede sui pedali dell’arpa, e sebbene mi fosse semirapito dalla veste e da uno scarpino color di giacinto, io mi sentiva una certa delizia nel contemplarlo...”. Qui Teresa (che ora ha “chiome biondissime”, mentre in 1798 era di “nere chiome”) ammalia Jacopo per quel vestir negletto e discinto, che insinua un tocco di rapinosa disarmonia nella sua tutto armonica bellezza (“[...] tutto tutto era armonia: ed io sentiva una nuova delizia nel contemplarla”).
Ed intanto siamo dinnanzi alla prima, pudica ancora e stentata, confessione d’amore all’amico Lorenzo: “Certo ch’io non potrei né asserire né negare a me stesso ch’io l’amo [...]”.
page_no="171" Padova, 7 Dicembre.
A meno di due mesi dal ritiro a Feriole, una prima, rapida fuga silenziosa (“senza dire addio ad anima vivente”) a Padova (tutto l’Ortis è, del resto, un disordinato, febbrile alternarsi di fughe e ritorni al “dolce romitorio”).
Ma non sarà “lunga stanza” per il ribellismo individualistico di chi vive guidato soltanto dal proprio “libero genio”, anzi dal proprio “capriccio”.
La Lettera, col numero XVI, era già, con varianti, in 1798.
Padova, 11 Dicembre.
Già in 1798, come Lettera XVII, la lettera dell’incontro con l’“altra”, il doppio negativo di Teresa (nella verità dell’esperienza Isabella Teotochi, divorziata nel 1795 dal patrizio veneziano Carlo Antonio Marin e risposatasi l’anno dopo col conte Giuseppe Albrizzi). Non ha, infatti, la “vereconda ingenuità” di Teresa, ma è “dotta assai nella donnesca galanteria [...]”.
Che sia introdotta nell’Ortis come figura speculare e oppositiva a Teresa lo dice chiaramente la scena di seduzione che segue. Improntata tutta ad un’evidente ironia (“[...] ov’era il talamo della Dea”; “[...] l’aere d’improvviso odorato di mille quintessenze”; “[...] tutta molle e rugiadosa”), la scena ha il suo climax nella descrizione della seminudità della donna (“[...] ella non era vestita che di una lunga e rada camicia”; “[...] mostrando in questo modo, forse sopra pensiero, un braccio bianchissimo e tondeggiante scoperto dalla camicia che nell’alzarsi della mano cascava fin oltre il gomito”), che richiama, per contrasto, “la immagine di Teresa”, ben più castamente “discinta”.
Estremamente significativa la chiusa «in codice» (“[...] perch’io ho voluto sfoggiare lo bello stile”) che, sotto un evidente richiamo dantesco (Inferno, I, 87), nasconde un assai meno evidente rinvio alla fonte della sequenza: una scena del Socrate delirante del Wieland, come ha dimostrato Walter Binni.
Padova. –
Un altro montaggio all’insegna della «letteratura sulla letteratura»: l’utilizzazione, a collage, di lettere (scritte, ovviamente, con piena consapevolezza retorica e stilistica, e realmente spedite a suo tempo a donna amata) come lettere di romanzo.
L’amata è, nella fattispecie, Antonietta Fagnani Are...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Colophon
- Introduzione
- Al Lettore
- Parte prima
- Parte seconda