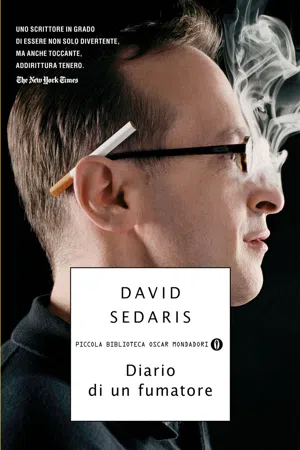![]()
F.D.S.
L’autobus che va dal North Carolina all’Oregon impiega quattro giorni, che equivalgono a circa settantacinquemila ore, se uno viaggia senza il supporto di un forte anestetico per animali. Era mio destino che qualsiasi marine disertore o ragazza in fuga col trucco sbavato di lacrime o detenuto in libertà vigilata ubriaco mi si sedesse così vicino che, nel caso si fosse addormentato, di sicuro la sua bava mi sarebbe colata nel colletto della camicia. Libri e riviste non offrivano alcun conforto. Inutili perfino come scudi, la loro presenza riusciva ad attirare ogni tipo di stato d’animo, dalla vaga curiosità all’odio esplicito.
«Pensi di imparare qualcosa, dai libri?» disse un signore, colpendo il mio poggiatesta con le nocche tatuate. «Dammi retta, secchione, se davvero vuoi imparare la verità, c’è un solo posto dove la insegnano: il carcere di Chatham. È la miglior scuola che abbiamo in questo cazzo di paese di merda. A me ha insegnato tutto quello che so, e anche di più. Impari più su questo cazzo di autobus che in una...» Si interruppe, tentando di ricordare che nome avevano quei posti. «Impari più qui che in una cazzo di piramide piena di libri. Con tutta quella merda scritta ci puoi anche riempire uno stadio, ma qui impari di più.»
Non avendo mai visto uno stadio pieno di libri, contraddirlo mi parve prematuro. «Forse ha ragione lei» risposi, osservando le cicatrici che gli adornavano la faccia scassata e cotta dal sole. «La prossima è la sua fermata, vero? No, perché se vuole posso mettermi su quell’altro sedile, così le lascio un po’ di spazio per distendersi.»
«Io gli ho detto di sì!» esclamò una ragazza, mettendosi a sedere accanto a me. «Gli ho detto: “Puoi scommetterci le palle che lo tengo, questo cazzo di bambino”. Questo stronzo io lo cago fuori comunque, che quel figlio di troia voglia fargli da padre oppure no.» Si interruppe per asciugarsi il naso piccolo e schiacciato con un calzino che portava con sé esclusivamente a quello scopo.
«Gli ho detto: “Questa merda me la sono già ciucciata per quattro anni con Big T, e se pensi che me ne sto qui a sopportare ancora la stessa roba puoi anche metterti in ginocchio e leccarmi il culo dopo che ho cagato, brutto figlio di puttana”. Gli ho detto: “Ne ho i coglioni pieni di stare appresso a un mezzo negro che passa tutto il suo cazzo di tempo a correre dietro alla fica, invece di alzare il culo e andare a cercarsi una merda di lavoro”. Stavolta non me sono stata zitta, no. Col cazzo!
«Gli ho detto: “Brutto pezzo di merda, hai meno coglioni tu che un cazzo di topo di campagna. Ti sei messo a ciucciare tette dopo che tua madre ti ha cagato, e da lì non hai più smesso, grandissimo rottinculo”. Gli ho detto: “Se tu questo bambino non lo vuoi, allora vaffanculo, mi trovo un altro coglione che se lo piglia, magari uno che non guarda il mondo dal taglietto in cima al suo microcazzo da frocio imbrattato di merda”. Gli ho detto: “Sarà anche un bastardo, ’sto bambino, ma puoi scommettere su quella troia di tua madre che non sarà mai bastardo quanto te, brutto pezzo di merda! ’Sto cazzo di bambino puoi scordarti di vederlo anche solo in cartolina, coglione. Non te lo faccio vedere nemmeno se ti metti a ciucciare la sborra dal cazzo di mio nonno”. Gli ho detto proprio così, perché ormai non me ne frega più un cazzo, giuro. Un cazzo!»
Dopo aver condiviso queste informazioni con un perfetto sconosciuto, la ragazza si mise a rovistare nella borsetta che teneva appoggiata sul pancione. Tirò fuori una spazzola e aggrottò la fronte, sfilando i capelli rimasti impigliati tra le setole e lasciandoli cadere sul pavimento dell’autobus. «Gli ho detto... gli ho detto: “E ricordati: se quando questo bastardo viene al mondo lo guardo e vedo che somiglia anche solo una scheggia a quella tua faccia di merda, gli faccio segare la testa dal dottore e ci gioco a pallone. Giuro su Dio che lo faccio, e di quello che pensi tu non me ne fotte un emerito cazzo”. Dopo tutta la merda che mi ha fatto mangiare, quel figlio di troia ha pure avuto la faccia di cazzo di chiedermi come penso di chiamarlo. Ti rendi conto? Io non... Gli ho detto: “Io non ci posso credere, faccia di merda!”. Gli ho detto: “Io lo chiamo come cazzo mi pare, brutto coglione! Stavo pensando di chiamarlo Cecil Rottinculo Succhiacazzi, come suo padre. Che te ne pare, eh? Ti piace l’idea, sacco di merda?”.»
Si asciugò un po’ di saliva dalle labbra, dopodiché si adagiò contro lo schienale. Nell’utero, il bambino scalciò e si mosse, e lei reagì dapprima con un urlo di dolore, poi sbattendosi il dorso della spazzola sulla pancia. «Figlio di puttana!» esclamò. «Riprovaci e ti sfondo la testa con un ferro da calza, così vedi se poi tiri ancora calci.»
Quell’autobus era l’America come l’avrebbero concepita dei capi della propaganda sovietica: un paesaggio disumano, abitato da idioti disperati che parlavano a raffica, spostandosi da un posto orrendo a uno peggio ancora. Se eri fortunato, la gente sull’autobus ti svegliava per scroccarti una sigaretta. Il tizio seduto accanto al finestrino quasi sicuramente si sarebbe presentato con la frase “Cazzo guardi?”. A causa della natura instabile dei passeggeri, i conducenti di questi autobus sono addestrati a gestire le situazioni di conflitto, e capita spesso che si fermino per dirimere qualche lite.
“Continua a rubarmi i dolci!”
“Chiedo scusa, signore, ma deve restituirgli il torrone.”
L’autobus avanzava lento, fermandosi in posti che ero sicuro avessimo superato non più di un quarto d’ora prima. Dai, sbrighiamoci, pensavo. Questa è gente che porta solo rogne. Che se li facciano a piedi, i quaranta chilometri da qui al boschetto di cactus dove vivono. A differenza di tutti loro, io avevo posti dove andare, posti veri. C’erano persone che mi aspettavano perché arricchissi le loro vite. Non se ne rendevano conto?
“L’autobus non effettuerà più fermate fino a Odell, Oregon” immaginavo che annunciasse il conducente al microfono. “Chiunque non sia diretto a Odell deve scendere immediatamente e mettersi in fila ai margini di questo deserto inospitale.”
I miei compagni di viaggio, borbottando e lamentandosi, avrebbero recuperato dalle tasche dietro i sedili le loro dentiere coperte di lanugine e le lattine di birra mezze vuote. Io li avrei guardati scendere sull’autostrada polverosa, con in mano le loro valigie da quattro soldi, agitando i pugni contro il sole implacabile. Quando anche l’ultimo fosse stato sfollato, il conducente avrebbe chiuso le porte e si sarebbe voltato verso di me. Toccandosi il cappello, avrebbe detto: “Saremo a Odell in un batter d’occhio, signore. Nel frattempo, si metta comodo e si goda il viaggio”.
Dopo aver passato quasi dodici ore a spiegarmi quanto fosse scomodo dormire in carcere e lavorare fuori, l’uomo seduto accanto a me giunse finalmente a destinazione. Il suo posto fu occupato da un burbero donnone senza mento che fumava come una ciminiera e aveva un dolcevita senza maniche color cenere. Non faceva conversazione in senso classico: ogni tanto mi dava una gomitata e mi indicava qualcosa che secondo lei potevo trovare significativo. «Un camion frigorifero» sussurrava. «Una stazione di servizio abbandonata.» Non andava mai in bagno, e non cambiava mai posizione, nemmeno durante i suoi frequenti pisolini. Il sonno sembrava sempre coglierla senza preavviso. «Una Plymouth con la targa del South Dakota» mi diceva, e appena mi giravo di nuovo verso di lei stava russando sommessamente, con la sigaretta accesa che le si consumava tra le dita.
Era quasi mezzanotte quando, in un punto imprecisato dello Utah, sull’autobus strapieno salì una ragazza con un sacco di plastica da lavanderia pieno di scarpe e vestiti. Dopo aver vagato su e giù per il corridoio nella vana ricerca di un posto a sedere, si piazzò accanto a me, spostando il peso da un piede all’altro e schiarendosi la gola con assillante regolarità. Si comportava come se da ore occupassi una cabina telefonica, parlando di stupidaggini, mentre lei doveva segnalare alla polizia una sparatoria avvenuta in un asilo. Mi faceva sentire a disagio.
«Senta» le dissi, «vuole sedersi un po’?»
Accettò senza dire una parola. Per me “un po’” significava un quarto d’ora, venti minuti al massimo. Se per allora non avessimo ancora raggiunto la sua destinazione, il posto glielo poteva cedere qualcun altro. Potevamo collaborare un po’ tutti, forgiando quello speciale legame che nasce soltanto dal sacrificio comune. Due minuti dopo essersi seduta, la ragazza si addormentò come un sasso, con la bocca aperta. Di tanto in tanto la richiudeva di scatto, borbottando qualcosa che suonava come “coglione”.
Mi spostai nella parte anteriore dell’autobus e mi sedetti sui gradini, ma il conducente mi fece alzare tirando in ballo il regolamento. Erano le sue uniche ore di privacy, ed era fermamente intenzionato a godersele. A partire dalle prime luci dell’alba avrebbe dovuto tenere testa ai vecchietti svitati che requisivano i sedili davanti, ignorando il cartello VIETATO PARLARE AL CONDUCENTE e bombardandolo di domande come: “Lei si è mai trovato un serpente nell’asciugabiancheria?”.
Tornai vicino al mio posto, sperando che al più presto qualcuno scendesse, ma fuori non c’era nulla per cui fermarsi. Il paesaggio circostante non mostrava segni di vita. Era un unico, gelido e sconfinato mondo fatto di pietre. Mi accovacciai per un po’, finché, in preda ai crampi, non decisi di infilarmi sotto il mio ex sedile. La vecchia ciminiera sedeva con le gambe allungate in avanti, mentre la mia peggior nemica tendeva a dimenarsi e sussultare, rompendomi letteralmente le palle ogni pochi secondi. La coppia seduta dietro si occupava del resto del corpo, sferrandomi alternativamente calci in testa o sulla spina dorsale con qualcosa di simile a stivali da cowboy dotati di punte in ferro. Cercai di convincermi che mi ero trovato in situazioni peggiori ma, per quanto mi sforzassi, non me ne venivano in mente. Il gigantesco motore dell’autobus era situato proprio sotto la mia testa, e da lì irradiava calore agli innumerevoli pezzetti di caramella sparsi per terra, che si fondevano formando un fragrante tappetino appiccicoso. C’era qualcosa di molto sbagliato in tutto ciò. Com’era possibile che io, la persona più importante su quell’autobus, fossi costretto a passare la notte accoccolato non “sul”, ma “sotto” il sedile che mi spettava di diritto? Su un aereo non sarebbe mai successo.
«Ah, guardi» avevo detto a vari ex compagni di viaggio, «dovrebbe provarlo, una volta o l’altra. Volare è bello. Ti servono da mangiare e da bere, e quando vai in bagno puoi lasciare il bagaglio sul sedile.»
«Davvero?» mi rispondevano, «e nessuno ci infila le mani?»
Lo sguardo di meraviglia stampato sulle loro facce era uno dei motivi per cui avevo scelto di prendere quell’autobus. Avendo passato gli ultimi nove mesi a lavare i piatti in college per studenti benestanti, pensavo che trovarmi in mezzo al popolo dei Greyhound sarebbe stato divertente. E invece. La situazione doveva per forza contenere una qualche lezione di vita, e un giorno, con un po’ di fortuna, quella massa di imbecilli inetti l’avrebbe imparata.
Rimasi disteso lì fino all’alba, quando l’autobus imboccò una salita, e una bottiglietta di bibita al cioccolato rotolò sul pavimento schiantandosi contro la mia fronte. Strisciai fuori da sotto il sedile e andai in bagno a estirpare i vari chewing-gum che mi si erano saldati al cuoio capelluto. Uno dopo l’altro, i passeggeri cominciarono a svegliarsi, tutti tranne la ragazza che occupava il mio sedile, che di certo non soffriva di insonnia: riaprì gli occhi intorno alle dieci, e mi chiese di tenerle il posto mentre andava a lavarsi i denti.
Crollai in un nanosecondo, ma solo per essere svegliato pochi minuti dopo dalla ragazza, che mi stava sbattendo un tubetto di dentifricio in testa. «Oh, sveglia!»
Feci finta di niente, pensando che si sarebbe arresa.
«Ehi, questo stronzo mi ha rubato il posto» gridò lei. «Sono andata un attimo in bagno a lavarmi la faccia, e adesso non so più dove cazzo sedermi!»
«Puoi sederti su di me» sentii qualcuno strillare dal fondo dell’autobus. «Ti faccio fare il viaggio della tua vita!»
«Okay, adesso basta con gli scherzi.» Era una voce maschile, ma non poteva essere quella del conducente perché l’autobus era in movimento. «Forza, mezza sega, restituisci il posto alla signora.»
Un mano mi afferrò per il colletto e mi sollevò in piedi senza alcuno sforzo. Era una mano robusta e coperta di vesciche, che rispecchiava alla perfezione la faccia e il temperamento del proprietario. L’uomo non mi fece domande, né minacce. Non ne aveva bisogno. Una volta liberato il sedile, lo ripulì dalle briciole e fece cenno alla ragazza di accomodarsi. Per un attimo pensai di spiegare a tutti come stavano davvero le cose, ma era chiaro che quel pubblico non era dalla mia parte. Mentre io ero in piedi in mezzo al corridoio fingendo di essere uno straniero ignaro degli usi e costumi di quel grande paese, gli altri passeggeri si sporgevano in avanti e allungavano il collo per guardare, ridendo e bisbigliando tra loro. Potevo anche aver occupato per sbaglio il posto di un’altra persona, ma accidenti se apprezzavo quel paesaggio brullo che tutti loro davano per scontato. Mi chinai in avanti, abbassando la testa per guardare fuori dal finestrino, e inarcando le sopracciglia deliziato alla vista di qualunque ammasso di roccia ci sfrecciasse accanto. Guardate! sembrava che dicessi. Quello pare un cardinale seduto sul bordo di una gigantesca torta! E quell’altro ricorda uno zoccolo capovolto, con sopra un masso identico alla faccia butterata di quella rozza ignorante che sta occupando il mio posto!
Intorno a mezzogiorno qualcuno scese, e io mi accasciai sul suo sedile. Ero esausto, ma non riuscivo a dormire per via dalle manovre di corteggiamento che si stavano svolgendo sui due sedili accanto. Dopo essersi voltata diecimila volte a ringraziarlo per il coraggio, Lady Lavanderia aveva ottenuto, mediante uno scambio di posti, di sedersi accanto a Lord Cinghiale, per approfondire la conoscenza. Nel giro di pochi minuti avevano infilato le teste sotto un maglione e avevano cominciato a esercitarsi nel richiamo dello scoiattolo, o forse a succhiarsi la pomata antiacne dai pori della faccia. La musica heavy metal che usciva dalla radio, le grida laceranti di un bambino agitato, il cicaleccio ininterrotto dei due pezzi da museo seduti davanti a me: qualunque cosa l’avrei sopportata meglio dei palpeggiamenti, dei baci e dei gridolini di piacere della coppietta.
Quando lui dovette scendere, lei si mise a piangere. Il suono dei suoi singhiozzi soffocati fu un vero balsamo, che mi spedì in un sonno profondo e impenetrabile fino a Reno.
Era la seconda volta che andavo nella Hood River Valley. La prima c’ero finito per sbaglio. Io e la mia amica Veronica eravamo a San Francisco da qualche mese, quando lei, richiudendo la sua copia di Furore, mi annunciò che con la vita di città avevamo chiuso. Aveva l’abitudine di parlare a nome di entrambi, cosa che raramente mi dava fastidio perché mi evitava di dover prendere decisioni da solo. «Ora dobbiamo dirigerci a nord e raggiungere i nostri fratelli e le nostre sorelle nei frutteti» disse, sistemandosi la sciarpa che aveva preso l’abitudine di portare intorno alla testa. «Lavoro stagionale: è quella la vita che fa per noi.» In tutto il paese c’era brava gente che aveva bisogno del nostro aiuto, e ci immaginammo distesi su covoni di fieno inondati di sole, a consumare rustici pranzetti cucinati per noi dalla moglie del contadino.
“È la gente che sgobba come voi a far girare il mondo” ci avrebbe detto la donna. “To’, prendete un altro pezzo del mio pollo da concorso: dovete mantenervi in forze.” Dopo pranzo, la contadina gentile avrebbe imbracciato il violino e avrebbe scatenato il finimondo con una trascinante versione di Turkey in the Straw Polly Wolly Doodle. Nel tardo pomeriggio ci saremmo rimessi al lavoro, raccogliendo da terra le mele e deponendole in deliziosi cestini con la scritta “Piccolo pellerossa” o “Cocco della maestra”. Avremmo condotto vite semplici ma assolutamente eroiche. Come avesse fatto Veronica a estrapolare una simile idea da un romanzo di Steinbeck rimane un mistero, ma io decisi ugualmente di seguirla, se non altro perché ero sicuro che mio padre sarebbe andato in bestia.
Arrivammo in Oregon facendo l’autostop, e saltammo giù dalla macchina non appena intravedemmo la cima innevata del Mount Hood, perfetto simbolo della magnificenza che ci aspettava. Il primo contadino si rifiutò di assumerci perché non avevamo esperienza. Il secondo e il terzo ci scartarono per lo stesso motivo. Al quarto mentimmo. Era un ometto anziano di nome Hobbs, la cui squadra di lavoratori messicani era appena stata spazzata via da una retata del servizio immigrazione.
«A questo punto assumerei chiunque riesca a raccogliere anche solo una margherita.» Guardò gli alberi, i rami curvi sotto il peso della frutta. «Pensavo che mi avrebbe potuto dare una mano mia moglie, ma adesso è lì in casa che sta morendo di cancro. Vero, Ringo?»
Se la moglie di Hobbs stava morendo, il suo beagle decrepito non era da meno. Rantolava e guaiva incessantemente, tormentandosi le chiazze di pelle spelacchiate che gli stavano marcendo alla base della coda artritica.
«Caspita, Ringo» disse Hobbs gettando la sigaretta accesa sull’erba bagnata. «Come sono contento che ci sei anche tu.»
Non ci sarebbero stati picnic sui covoni di fieno, né polli da concorso, né violini. Nascosto dietro una spessa coltre di nuvole permanenti, il sole non inondava un bel niente. Contrariamente all’idea che c’eravamo fatti, le mele non si raccoglievano da terra, ma dai rami impervi di alberi protetti da una corteccia punitiva, che tendeva a trattenere buona parte dell’acqua caduta in dodici ore filate di pioggia. Si lavorava sette giorni su sette, dall’alba al tramonto, quando piovigginava e quando diluviava. Se a far girare il mondo era la gente come noi, allora doveva essere un segreto davvero ben custodito. Fummo sistemati in una delle cinque o sei casette di legno disposte in fila lungo la stradina di ghiaia che portava alla fattoria. Non c’era l’elettricità e, a parte la doccia situata nel fienile, l’unica fonte d’acqua era un rubinetto gelido coperto di ruggine. Cucinavamo su una stufa a legna, e dormivamo su materassi che come minimo dovevano essere imbottiti di scarpe col tacco a spillo. Ma noi vivevamo quelle scomodità come vantaggi. Indossavamo tute da lavoro, ammirando nelle finestre illuminate dalla luce delle candele i nostri cupi riflessi chini su ciotole di zuppa d’avena fumante. Non ci serviva altro. Eravamo pionieri. La gente come noi non aveva bisogno di cuscini o ganci per gli asciugamani. Indossavamo i lividi come medaglie, e ogni bronchite era un inno alla nostra forza d’animo. Stavo per comprarmi un berretto con la coda di procione, quando la stagione di raccolta finì e ce ne tornammo a casa nel North Carolina, dove in un batter d’occhio mi riadattai a vivere con acqua calda ed elettricità. Eravamo rimasti d’accordo che avremmo fatto anche la stagione succ...