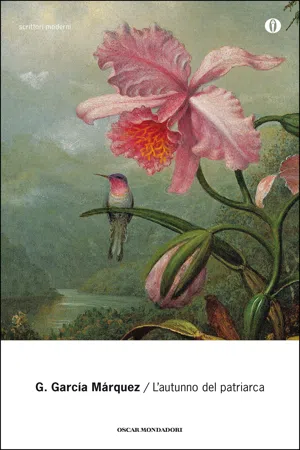
- 238 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'autunno del patriarca
Informazioni su questo libro
"Il tema della dittatura è stato una costante della letteratura latino-americana fin dalle origini, e suppongo che continuerà a esserlo. È comprensibile, dato che il dittatore è l'unico personaggio mitologico che ha prodotto l'America Latina, e il suo ciclo è ben lontano dall'essere concluso. Ma, in realtà, a me non interessava tanto il personaggio in sé (il personaggio del dittatore feudale), quanto l'opportunità che mi offriva di riflettere sul potere. È un tema latente in tutti i miei romanzi. Perché ho sempre creduto che il potere assoluto sia la realizzazione più alta e più complessa dell'essere umano e che per questa ragione riassuma forse ogni sua grandezza e miseria."
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'autunno del patriarca di Gabriel García Márquez, Enrico Cicogna in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788804545064eBook ISBN
9788852015984L’autunno del patriarca
Durante il fine settimana gli avvoltoi s’introdussero attraverso i balconi della casa presidenziale, fiaccarono a beccate le maglie di fil di ferro delle finestre e smossero con le ali il tempo stagnato all’interno, e all’alba del lunedì la città si svegliò dal suo letargo di secoli con una tiepida e tenera brezza di morto grande e di putrefatta grandezza. Solo allora ci azzardammo a entrare senza prendere d’assalto i muri corrosi di pietra fortificata, come volevano i più risoluti, o sbandellare con coppie di buoi l’entrata principale, come proponevano altri, poiché bastò che qualcuno li spingesse per far cedere nei loro gangheri i portoni blindati che nei tempi eroici della casa avevano resistito alle bombarde di William Dampier. Fu come penetrare nell’ambito di un’altra epoca, perché l’aria era più tenue nei pozzi di macerie del vasto covo del potere e il silenzio era più antico, e le cose erano difficilmente visibili nella luce decrepita. Tutt’attorno al primo cortile, dove le mattonelle avevano ceduto alla pressione sotterranea della malerba, vedemmo il rione in disordine della guardia fuggiasca, le armi abbandonate negli armadi, il lungo tavolo di assi grezze coi piatti degli avanzi del pranzo domenicale interrotto dal panico, vedemmo il capannone in penombra dove avevano operato gli uffici civili, i funghi colorati e i gigli pallidi tra le pratiche inevase il cui corso ordinario era stato più lento delle vite più aride, vedemmo nel centro del cortile la cisterna battesimale dov’erano state cristianizzate con sacramenti marziali più di cinque generazioni, vedemmo in fondo l’antica scuderia dei viceré trasformata in rimessa, e vedemmo tra le camelie e le farfalle la berlina dei tempi del rumore, il furgone della peste, la carrozza dell’anno della cometa, il carro funebre del progresso nell’ordine, la limousine sonnambula del primo secolo di pace, tutti in buono stato sotto le ragnatele polverose e tutti dipinti coi colori della bandiera. Nel cortile successivo, dietro una grata di ferro, c’erano i roseti innevati di polvere lunare alla cui ombra dormivano i lebbrosi nei tempi di magnificenza della casa e avevano proliferato tanto nell’abbandono che era molto se rimaneva un cantuccio senza odore in quell’aria di rose mista alla pestilenza che giungeva fino a noi dal fondo del giardino e al tanfo di pollaio e al fetore di sterco bovino e di fermenti di piscio di vacche e di soldati della basilica coloniale trasformata in stalla da mungitura. Facendoci strada tra la sterpaia asfissiante vedemmo la galleria ad arcate con vasi di garofani e festoni di astromelie e di buganvillee dove un tempo erano le baracche delle concubine, e dalla varietà dei residui domestici e dalla quantità di macchine da cucire ci parve possibile che lì avessero vissuto più di mille donne col loro gregge di settimini, vedemmo il disordine di guerra delle cucine, la biancheria marcita al sole nelle tinozze del bucato, la sentina aperta del cacatoio comune delle concubine e dei soldati, e vedemmo in fondo i salici babilonici che erano stati trasportati vivi dall’Asia Minore in gigantesche serre di mare, con la loro terra, con la loro linfa e la loro pioggerellina, e dietro ai salici vedemmo il palazzo, immenso e triste, attraverso le cui persiane scheggiate continuavano a introdursi gli avvoltoi. Non dovemmo forzare l’entrata, come avevamo pensato, perché la porta principale parve aprirsi al solo impulso della voce, di modo che salimmo al piano principale su per una scala di pietra viva i cui tappeti da melodramma erano stati triturati dagli zoccoli delle vacche, e dal primo vestibolo fino alle camere private vedemmo gli uffici e le sale di rappresentanza in rovina nelle quali vagavano le vacche impavide che mangiavano le tende di velluto e mordicchiavano il raso delle poltrone, vedemmo quadri eroici di santi e di militari gettati per terra tra mobili rotti e mucchi recenti di sterco di vacca, vedemmo la sala dove si mangiava mangiata dalle vacche, il salone da concerti profanato dal caos delle vacche, e le tavole da biliardo fatte fuori dalle vacche, vedemmo abbandonata in un angolo la macchina del vento, che falsificava qualsiasi fenomeno dei quattro quadranti della rosa nautica di modo che la gente della casa sopportasse le nostalgie del mare che se n’era andato, vedemmo gabbie di uccelli appese in ogni luogo e ancora coperte coi panni per dormire di qualche notte della settimana precedente, e vedemmo dalle finestre numerose l’esteso animale addormentato della città ancora innocente del lunedì storico che cominciava a vivere, e oltre la città, fino all’orizzonte, vedemmo i crateri morti di aspre ceneri lunari della pianura senza fine dov’era stato il mare. In quel luogo proibito che pochissima gente privilegiata era riuscita a conoscere, sentimmo per la prima volta l’odore di carname degli avvoltoi, percepimmo la loro asma millenaria, il loro istinto premonitore, e lasciandoci guidare dal vento di putrefazione dei colpi d’ala trovammo nella sala delle udienze le carcasse verminose delle vacche, i loro quarti posteriori di femmine ripetuti più volte negli specchi a corpo intero, e allora spingemmo una porta laterale che conduceva in un ufficio dissimulato nel muro, e lì lo vedemmo, con l’uniforme di tela senza insegne, con le uose, con lo sperone d’oro al tallone sinistro, più vecchio di tutti gli uomini e di tutti gli animali vecchi della terra e dell’acqua, ed era disteso sul pavimento, bocconi, col braccio destro piegato sotto la testa in modo che gli servisse da cuscino, come aveva dormito notte dopo notte per tutte le notti della sua lunghissima vita di despota solitario. Solo quando lo rivoltammo per guardargli la faccia capimmo che sarebbe stato impossibile riconoscerlo anche se non lo avessero roso gli avvoltoi, perché nessuno di noi lo aveva mai visto, e benché il suo profilo fosse su ambedue i lati delle monete, sui francobolli della posta, sulle etichette dei depurativi, sui cinti erniari e sugli scapolari, e benché la sua fotografia incorniciata con la bandiera sul petto e col drago della patria fosse esposta a ogni ora in ogni luogo, non ignoravamo che erano copie di ritratti che venivano già considerati infedeli ai tempi della cometa, quando i nostri stessi genitori sapevano che era lui perché lo avevano sentito raccontare dai loro genitori, così come quelli dai loro, e fin da bambini ci avevano abituato a credere che lui fosse vivo nella casa del potere perché qualcuno aveva visto accendersi i globi luminosi dei lampadari in una notte di festa, qualcuno aveva raccontato di aver visto gli occhi tristi, le labbra pallide, la mano pensosa che andava accennando commiati da nessuno attraverso gli ornamenti da messa della carrozza presidenziale, perché una domenica di molti anni prima si erano portati via il cieco girovago che per cinque centavos recitava i versi del dimenticato poeta Rubén Darío ed era tornato felice con un’oncia d’oro con la quale gli avevano pagato un recital che aveva fatto solo per lui, benché non lo avesse visto, naturalmente, non tanto perché era cieco ma perché nessun mortale lo aveva visto fin dai tempi della febbre gialla, e tuttavia sapevamo che era lì, lo sapevamo perché il mondo andava avanti, la vita andava avanti, la posta arrivava, la banda municipale suonava in piazza la sfilza di valzer sciocchi del sabato sotto le palme polverose e sotto i fanali tetri della plaza de Armas, e altri musicanti vecchi sostituivano nella banda i musicanti morti. Negli ultimi anni, quando non si tornarono a sentire né rumori umani né canti di uccelli all’interno e si chiusero per sempre i portoni blindati, sapevamo che c’era qualcuno nel palazzo perché di notte si vedevano luci che sembravano di navigazione attraverso le finestre dalla parte del mare, e chi ebbe il coraggio di avvicinarsi udì disastri di zoccoli e sospiri di animale grande dietro le pareti fortificate, e una sera di gennaio avevamo visto una vacca che contemplava il crepuscolo dal balcone presidenziale, figuriamoci, una vacca sul balcone della patria, che iniquità si devono mai vedere, che paese di merda, ma si fecero tante congetture su come fosse possibile che una vacca arrivasse fin sopra un balcone quando tutti sappiamo che le vacche non si arrampicano per le scale, tanto meno se sono di pietra, e tanto meno ancora se sono coperte di tappeti, che alla fine non riuscimmo a capire se davvero l’avevamo vista o se invece eravamo passati una sera nella plaza de Armas e avevamo sognato camminando di aver visto una vacca su un balcone presidenziale dove niente si era visto e niente si sarebbe veduto per molti anni fino all’alba di quel venerdì della settimana scorsa quando cominciarono ad arrivare i primi avvoltoi che si sollevarono da dove stavano sempre appisolati sul cornicione dell’ospedale dei poveri, ne vennero altri dall’interno, vennero in ondate successive dall’orizzonte del mare di polvere dove c’era stato il mare, volarono un giorno intero in cerchi lenti sulla casa del potere finché un re con piume da sposa e collare rosso carne impartì un ordine silenzioso e cominciò quello strepito di vetri, quel vento di morto grande, quell’entrare e uscire di avvoltoi dalle finestre com’era concepibile solo in una casa senza autorità, di modo che anche noi ci azzardammo a entrare e trovammo nel santuario deserto le macerie della grandezza, il corpo sbeccuzzato, le mani lisce di donzella con l’anello del potere sull’osso dell’anulare, e aveva tutto il corpo coperto di licheni minuscoli e di animali parassitari dei fondali marini, soprattutto nelle ascelle e all’inguine, e aveva il brachiere di tela sul testicolo ernioso che era l’unica cosa che gli avvoltoi avevano eluso nonostante fosse grande quanto un rognone di bue, ma nemmeno allora ci azzardammo a credere alla sua morte perché era la seconda volta che lo trovavano in quell’ufficio, solo e vestito, e morto a quanto pareva di morte naturale nel sonno, com’era annunziato da molti anni nelle acque premonitrici dei catini delle pitonesse. La prima volta che lo avevano trovato, all’inizio del suo autunno, la nazione era ancora abbastanza viva da fare in modo che lui si sentisse minacciato di morte perfino nella solitudine della sua stanza da letto, e tuttavia governava come se si sapesse predestinato a non morire mai, giacché quella allora non sembrava una casa presidenziale ma un mercato dove bisognava farsi strada tra attendenti scalzi che scaricavano asini di ortaggi e ceste di galline nei porticati, scavalcando comari con figliocci famelici che dormivano rannicchiate sulle scale per aspettare il miracolo della carità ufficiale, dove bisognava eludere i rovesci di acqua sporca delle concubine linguacciute che cambiavano con fiori nuovi i fiori notturni dei vasi e che lavavano il pavimento e che cantavano canzoni di amori illusori al ritmo dei rami secchi coi quali sbattevano i tappeti sui balconi, e tutto ciò tra lo scandalo dei funzionari a vita che trovavano galline in cova nei tiretti delle scrivanie, e traffici di puttane e di soldati nelle latrine, e schiamazzo di uccelli, e lotte di cani randagi nel bel mezzo delle udienze, perché nessuno conosceva nessuno né sapeva chi mandava chi in quel palazzo dalle porte aperte nel cui disordine inaudito era impossibile stabilire dov’era il governo. Il padrone di casa non soltanto partecipava a quel disastro da fiera ma lui stesso lo promuoveva e lo comandava, poiché non appena si accendevano le luci della sua camera, prima che cominciassero a cantare i galli, la diana della guardia presidenziale mandava l’avviso del nuovo giorno alla vicina caserma del Conde, e questa lo ripeteva per la base di San Jerónimo, e quella per la fortezza del porto, la quale tornava a ripeterlo per le sei diane successive che svegliavano prima la città e poi tutto il paese, mentre lui meditava sul cesso portatile cercando di soffocare con le mani il ronzio delle sue orecchie, che allora cominciava a manifestarsi, e guardava passare la luce delle navi sul volubile mare di topazio che in quei tempi di gloria era ancora davanti alla sua finestra. Tutti i giorni, fin da quando aveva preso possesso della casa, aveva sorvegliato la mungitura nelle stalle per misurare di mano sua la quantità di latte che avrebbero trasportato i tre carri presidenziali nelle caserme della città, faceva colazione in cucina con un tazzone di caffè nero e focaccia di manioca senza sapere molto bene dove lo trascinavano i ghiribizzi della nuova giornata, sempre attento al cicaleccio della servitù che era la gente della casa con la quale parlava la stessa lingua, le cui serie blandizie stimava di più e i cui cuori decifrava meglio, e un po’ prima delle nove faceva un lento bagno in acqua con foglie bollite nella vasca di granito costruita all’ombra dei mandorli nel suo cortile privato, e solo dopo le undici riusciva a imporsi all’inquietudine dell’alba e affrontava i casi della realtà. Prima, durante l’occupazione dei fanti di marina, si chiudeva nell’ufficio per decidere il destino della patria col comandante delle truppe di sbarco e firmava ogni sorta di leggi e di mandati con l’impronta del pollice, perché allora non sapeva né leggere né scrivere, ma quando lo lasciarono di nuovo solo con la sua patria e il suo potere non tornò ad avvelenarsi il sangue con il sopore della legge scritta ma governava a viva voce e di persona a ogni ora e in ogni luogo con una parsimonia rupestre ma anche con una diligenza inconcepibile alla sua età, assediato da una moltitudine di lebbrosi, di ciechi e di paralitici che supplicavano dalle sue mani il sale della salute, e da politici letterati e da adulatori impavidi che lo proclamavano correttore dei terremoti, delle eclissi, degli anni bisestili e degli altri errori di Dio, strascicando per tutta la casa le sue grandi zampe di elefante nella neve mentre risolveva problemi di stato e faccende domestiche con la stessa semplicità con la quale ordinava toglietemi quella porta da lì e mettetemela là, la toglievano, rimettetemela lì, la rimettevano, o che l’orologio del campanile non battesse le dodici alle dodici bensì alle due di modo che la vita sembrasse più lunga, si obbediva, senza un istante di esitazione, senza una pausa, tranne nell’ora mortale della siesta quando si rifugiava nella penombra delle concubine, ne sceglieva una d’assalto, senza svestirla né svestirsi, senza chiudere la porta, e nell’ambito della casa si udiva allora il suo ansito senza anima di marito urgente, il tintinnio anelante dello sperone d’oro, il suo piagnucolio di cane, lo spavento della donna che sperperava il suo tempo d’amore cercando di togliersi di dosso lo sguardo squallido dei settimini, le sue grida di fuori dai piedi, andate a giocare in cortile ché i bambini non devono vedere queste cose, ed era come se un angelo attraversasse il cielo della patria, si spegnevano le voci, si è fermata la vita, tutti sono rimasti pietrificati con l’indice sulle labbra, senza respirare, silenzio, il generale sta fottendo, ma chi lo aveva conosciuto meglio degli altri non aveva fiducia nemmeno nella tregua di quell’istante sacro, poiché sembrava sempre che si sdoppiasse, e lo videro giocare a domino alle sette di sera e nello stesso tempo lo avevano visto dar fuoco allo sterco di vacca per scacciare le zanzare nella sala delle udienze, e nessuno si cullava nell’illusione fintanto che non si spegnevano le luci delle ultime finestre e non si udiva il gran fracasso dei tre paletti, dei tre chiavacci, dei tre chiavistelli della camera presidenziale, e non si sentiva il tonfo del corpo quando crollava per la stanchezza sul pavimento di pietra, e la respirazione da bambino decrepito che si faceva sempre più profonda man mano che montava la marea, finché le arpe notturne del vento acquietavano le cicale dei suoi timpani e un’ampia mareggiata di spuma devastava le strade della vecchia città dei viceré e dei bucanieri e irrompeva nel palazzo attraverso tutte le finestre come un tremendo sabato d’agosto che faceva crescere balani sugli specchi e lasciava la sala delle udienze alla mercé dei deliri dei pescicani e oltrepassava i livelli più alti degli oceani preistorici, e straripava dalla faccia della terra, e dello spazio e del tempo, e rimaneva soltanto lui a galleggiare bocconi sull’acqua lunare dei suoi sogni di annegato solitario, con la sua uniforme di tela da soldato semplice, con le sue uose, col suo sperone d’oro, e col braccio destro piegato sotto la testa di modo che gli servisse da cuscino. Quell’essere presente simultaneamente in ogni luogo durante gli anni pietrosi che precedettero la sua prima morte, quel salire mentre scendeva, quell’estasiarsi nel mare mentre agonizzava di mali amori non erano un privilegio della sua natura, come proclamavano i suoi adulatori, né un’allucinazione collettiva, ma era la fortuna di poter contare sui servizi integri e sulla lealtà canina di Patricio Aragonés, il suo sosia perfetto, che era stato trovato senza che nessuno lo cercasse quando gli avevano recato la notizia signor generale, che una falsa carrozza presidenziale girava per villaggi di indios e faceva ottimi affari sostituendosi a lui, che avevano visto gli occhi taciturni nella penombra mortuaria, che avevano visto le labbra pallide, la mano di sposa sensitiva con un guanto di raso che andava gettando manciate di sale ai malati inginocchiati lungo la strada, e che dietro la carrozza venivano due falsi ufficiali a cavallo che riscuotevano in moneta sonante il favore della salute, s’immagini un po’ signor generale, che sacrilegio, ma lui non aveva dato alcun ordine contro il soppiantatore e aveva invece chiesto che lo portassero in segreto nella casa presidenziale con la testa infilata in un sacco di iuta ché non corressero il rischio di confonderlo, e allora soffrì l’umiliazione di vedere se stesso in tale stato di uguaglianza, cazzo, ma se quest’uomo sono io, disse, perché in effetti era come se lo fosse, tranne che per l’autorità della voce, che l’altro non riuscì mai a imitare, e per la nitidezza delle linee della mano dove l’arco della vita si prolungava senza inciampi attorno alla base del pollice, e se non lo fece fucilare all’istante non fu per l’interesse di tenerlo come sostituto ufficiale, perché a quello ci pensò più tardi, ma perché l’inquietò l’illusione che le cifre del suo stesso destino fossero scritte nella mano dell’impostore. Quando si convinse della vanità di quel sogno Patricio Aragonés era ormai sopravvissuto impassibile a sei attentati, aveva acquistato l’abitudine di strascicare i piedi appiattiti a colpi di maglio, gli ronzavano le orecchie e gli cantava l’ernia nelle albe d’inverno, e aveva imparato a togliersi e a infilarsi lo sperone d’oro come se gli s’imbrogliassero le corregge solo per prendere tempo durante le udienze borbottando cazzo i ferraioli di Fiandra non le sanno più fare le fibbie, e da motteggiatore e linguacciuto com’era quando soffiava bottiglie nella vetreria di suo padre si fece meditabondo e ombroso e non faceva attenzione a quello che gli dicevano ma scrutava la penombra degli occhi per indovinare quello che non gli dicevano, e non rispose mai a una domanda senza prima domandare a sua volta e lei che cosa ne pensa e da scioperato e crapulone com’era quando vendeva miracoli si fece diligente fino al tormento e camminatore implacabile, si fece taccagno e rapace, si rassegnò ad amare d’assalto e a dormire per terra, vestito, bocconi e senza cuscino, e rinunciò alle sue aspirazioni precoci d’identità propria e a tutta la vocazione ereditaria di velleità dorata di limitarsi a soffiare e a fare bottiglie, e affrontava i rischi più tremendi del potere posando prime pietre dove non si sarebbero mai posate le seconde, tagliando nastri inaugurali in terra di nemici e sopportando tanti sogni annacquati e tanti sospiri repressi di illusioni impossibili incoronando quasi senza toccarle tante e tanto effimere e irraggiungibili regine di bellezza perché si era rassegnato per sempre al destino semplice di vivere un destino che non era il suo, anche se non lo fece né per bramosia né per convinzione ma perché lui gli cambiò la vita con l’impiego vitalizio d’impostore ufficiale con uno stipendio nominale di cinquanta pesos mensili e col vantaggio di vivere come un re senza la calamità di esserlo, cosa vuoi di più. Quella confusione di identità raggiunse il suo massimo tono in una notte di grandi venti nella quale lui trovò Patricio Aragonés che sospirava verso il mare nel vapore fragrante dei gelsomini e gli domandò con un’apprensione legittima se per caso non gli avessero messo aconito nel cibo ché andava alla deriva e come spinto da un’aria cattiva, e Patricio Aragonés gli rispose no signor generale, il guaio è peggiore, sabato aveva incoronato una regina di carnevale e aveva ballato con lei il primo valzer e adesso non trovava la porta per uscire da quel ricordo, perché era la donna più bella della terra, di quelle che non sono state fatte per te, se la vedesse, ma lui ribatté con un sospiro di sollievo che cazzo dici, questi sono guai che capitano agli uomini quando sono a corto di donne, gli propose di mandarla a sequestrare come aveva fatto con tante donne recalcitranti che erano state sue concubine, te la metto con la forza nel letto con quattro uomini della truppa che te la tengono per i piedi e per le mani mentre tu te la pappi col cucchiaione, che diamine, te la pappi impastoiata, gli disse, perfino le più bacchettone sulle prime si torcono di rabbia e poi ti supplicano non mi lasci così signor generale, come una povera melarosa con la semenza sciolta, ma Patricio Aragonés non voleva tanto ma voleva di più, voleva che gli volessero bene, perché questa è una di quelle che sanno distinguere il pane dai sassi, signor generale, vedremo se non lo vedrà anche lei quando la vede, e così lui gli indicò come formula di sollievo i sentieri notturni delle stanze delle sue concubine e lo autorizzò a usarle come se fosse lui stesso, d’assalto e di fretta e con i vestiti indosso, e Patricio Aragonés si sommerse in buona fede in quella palude di amori prestati credendo così di mettere un bavaglio alle sue brame, ma era tanta la sua ansietà che a volte si dimenticava delle condizioni del prestito, si sbracava per distrazione, si soffermava su particolari, inciampava per incuria nelle pietre occulte delle donne più meschine, sviscerava i loro sospiri e le faceva ridere dalla sorpresa nelle tenebre, che birbante signor generale, gli dicevano, ci diventa vorace da vecchio, e da allora nessuno dei due uomini e nessuna delle donne seppe mai chi era figlio di chi, né di chi con chi, perché anche i figli di Patricio Aragonés come i suoi nascevano settimini. Fu così che Patricio Aragonés divenne l’uomo essenziale del potere, il più amato e forse anche il più temuto, e lui dispose di maggiore tempo per occuparsi delle forze armate con la stessa diligenza dell’inizio del suo mandato, non perché le forze armate fossero la base del suo potere, come tutti credevamo, ma al contrario, perché erano il suo nemico naturale più temibile, di modo che faceva credere a certi ufficiali di essere sorvegliati da altri, gli rimescolava le destinazioni per impedire che complottassero, dotava le caserme di otto cartucce a salve ogni dieci autentiche e le riforniva di polvere da sparo mescolata con sabbia del mare mentre lui manteneva il deposito buono a portata di mano in un magazzino della casa presidenziale le cui chiavi si portava addosso in un anello con altre chiavi senza copie di altre porte che nessun altro poteva varcare, protetto dall’ombra tranquilla del mio compare di tutta la vita il generale Rodrigo de Aguilar, un artigliere d’accademia che era inoltre il suo ministro della Difesa e nello stesso tempo comandante delle guardie presidenziali, direttore dei servizi di sicurezza dello stato e uno dei pochissimi mortali che furono autorizzati a vincergli una partita a domino, perché aveva perso il braccio destro nel tentativo di neutralizzare una carica di dinamite qualche minuto prima che la berlina presidenziale passasse nel luogo dell’attentato. Si sentiva così sicuro sotto la protezione del generale Rodrigo de Aguilar e con la presenza di Patricio Aragonés, che cominciò a trascurare i suoi presagi di conservazione e si andò facendo sempre più visibile, si arrischiò a passeggiare per la città con un solo aiutante di campo in una carrozza chiusa senza insegne contemplando attraverso le tendine la cattedrale arrogante di pietra dorata che lui aveva dichiarato per decreto la più bella del mondo, spiava le antiche magioni di pietra e calce con portali di tempi addormentati e girasoli girati verso il mare, le strade lastricate con odore di lucignolo del rione dei viceré, le signorine livide che facevano il pizzo al tombolo con una decenza ineluttabile tra i vasi di garofani e i tralci di buganvillee nella luce dei balconi, il convento a scacchiera delle biscagline con lo stesso esercizio di clavicordio alle tre del pomeriggio col quale avevano commemorato il primo passaggio della cometa, attraversò il labirinto babelico delle botteghe e la sua musica letale, i labari di biglietti della lotteria, i carrettini della melassa, le filze di uova di iguana, le paccottiglie dei turchi scolorite dal sole, la tela paurosa della donna che si era trasformata in scorpione per aver disobbedito ai suoi genitori, la viuzza di miseria delle donne senza uomini che uscivano nude al crepuscolo per comprare corvine azzurre e pagri rosa e a prendersi a male parole con le ortolane mentre gli si asciugava la biancheria sui balconi di legno lavorato, sentì il vento di molluschi marciti, la luce quotidiana dei pellicani dietro l’angolo, il disordine di colori delle baracche dei negri sui promontori della baia, e ad un tratto, eccolo lì, il porto, ah, il porto, il molo di tavolati spugnosi, la vecchia corazzata dei fanti più lunga e più oscura della verità, la stivatrice negra che si scostò troppo tardi per fare strada alla carrozzella spaurita e si sentì toccata dalla morte alla vista del vecchio crepuscolare che contemplava il porto con lo sguardo più triste del mondo, è lui, esclamò spaventata, evviva il macho, gridò, evviva, gridavano gli uomini, le donne, i bambini che uscivano correndo dalle osterie e dalle bettole dei cinesi, evviva, gridavano quelli che intralciarono le zampe dei cavalli e bloccarono la carrozza per stringere la mano del potere, una manovra così riuscita e imprevista che lui ebbe appena il tempo di scostare il braccio armato dell’aiutante di campo rimproverandolo con voce tesa, non sia coglione, tenente, lasci che mi amino, così esaltato da quello slancio d’amore e da altri simili dei giorni seguenti che il generale Rodrigo de Aguilar riuscì a fatica a togliergli dalla testa l’idea di andare a spasso su una carrozza scoperta in modo che possano vedermi da capo a piedi i patrioti della patria, che cazzo, poiché lui non sospettava nemmeno che se l’assalto del porto era stato spontaneo gli assalti successivi li avevano organizzati i suoi stessi servizi di sicurezza per compiacerlo senza rischi, così ingolosito dalle arie d’amore delle vigilie del suo autunno che si azzardò a uscire dalla città dopo molti anni, fece rimettere in moto il vecchio treno dipinto coi colori della bandiera che si arrampicava gattoni verso le cornici del suo vasto regno d’incubo, facendosi strada tra frascami di orchidee e balsamine amazzoniche, sconvolgendo scimmie, uccelli del paradiso, leopardi addormentati sulle rotaie, fino ai villaggi glaciali e deserti del suo altipiano natale nelle cui stazioni lo aspettavano con bande di musiche lugubri, gli suonavano campane a morto, gli mostravano cartelli di benvenuto al patrizio senza nome che è seduto alla destra della Santissima Trinità, gli reclutavano indios sbandati che scendevano a conoscere il potere occultato nella penombra funebre del vagone presidenziale, e coloro che riuscivano ad avvicinarsi non vedevano altro che gli occhi attoniti dietro i vetri polverosi, vedevano le labbra tremule, il palmo di una mano senza origine che salutava dal limbo della gloria, mentre qualcuno della scorta cercava di scostarlo dal finestrino, faccia attenzione, generale, la patria ha bisogno di lei, ma lui ribatteva sonn...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Introduzione di Cesare Segre
- L’autunno del patriarca
- Copyright