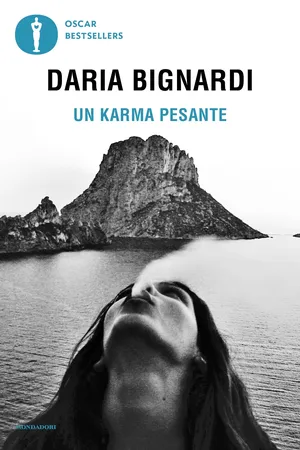Sono a novemila metri di altezza e sto morendo. L’aria si blocca dentro al petto, non va giù. Ho il fiato mozzo e un macigno sul petto. Soffoco. Da due giorni respiro male. Pensavo fosse ansia: è un periodo di centocinquanta cose insieme. Invece sto morendo soffocata.
O è un infarto?
È iniziato quando il comandante ha detto di allacciare le cinture per una turbolenza. Era mezz’ora che mi scappava la pipì ma mi dispiaceva svegliare Pietro che dormiva. Mi sono decisa, l’ho scavalcato e ho camminato fino in fondo al corridoio, barcollando per gli scossoni. Al ritorno sudavo. Mi sono seduta in fretta nel posto libero accanto a Pietro e l’ho chiamato battendogli un dito sulla clavicola: «Parlami. Prova a distrarmi. Sento che mi sta venendo qualcosa».
Comincio a piangere e lui mi stringe la mano cercando argomenti: «Come si chiama il tedesco che devi vedere a Taormina per il film?».
Pietro pensa che solo il lavoro mi distragga, ma io sto morendo, non respiro più. Ansimo e piango, con la faccia schiacciata contro la sua spalla. Arriva una hostess e sento che le dice: «Ha mal d’orecchi», per proteggere una privacy della quale non mi importa più niente, dal momento che sto morendo. Singhiozzo più forte mentre ascolto la mia voce chiedere aiuto piano, ma non abbastanza perché i vicini dall’altra parte del corridoio non domandino a Pietro cosa sta succedendo. Non vedo niente ma sento tutto amplificato.
«Quanto manca?» biascico.
Pietro risponde: «Pochissimo», e mi stringe la mano più forte. Mi fanno davvero male le orecchie adesso – malissimo –, ma è niente in confronto al senso di oppressione che mi schiaccia il petto.
È un infarto, ho capito. Devo sdraiarmi per terra. Devo provare a respirare. Faccio per alzarmi ma sono paralizzata. Il sussulto del carrello che sbatte sulla pista di atterraggio mi riscuote, ma ormai è troppo tardi.
Muoio.
Pietro mi fa alzare prendendomi sotto le ascelle, non riesco a camminare. Mi aggrappo alle poltrone del corridoio, che non finisce più. Non eravamo seduti alla fila dieci? Non vedo niente e nessuno, so solo che devo sdraiarmi e respirare a fondo, se no muoio. Sento che qualcuno mi supera, voci confuse, non distinguo nulla.
Pietro poi mi dirà di avermi trascinata fuori dal finger finché sono crollata con la testa tra le braccia su un banco, accanto ai carabinieri, ma io non ricordo niente. A un certo punto ero dentro all’infermeria dell’aeroporto, sdraiata su un lettino, e una dottoressa bionda con l’accento siciliano chiedeva a Pietro di che malattie soffro.
Ho detto a Pietro di chiamare sul cellulare il mio ginecologo: ieri ho avuto la solita emorragia mensile, forse c’entra con quel che mi sta capitando. Il ginecologo si chiama Angelo, mi conosce da sempre: è lui che ha fatto nascere le bambine. Consiglia a Pietro di fare subito un emocromo per togliersi il dubbio che sia anemia grave: i sintomi sono simili. Si fa passare la dottoressa, che dopo aver riattaccato dice: «Se il fibroma è accussì grosso è meglio togliere l’utero, se no rischia un’anemia brutta. Le emorragie debilitanti sono, si tenga controllata. Pi’ mia, il suo, attacco di panico è».
Arriva un altro medico con una polo blu che mi misura la pressione: «Sta risalendo», e poi sussurra: «La collega non l’ha riconosciuta».
E quando me l’avevano misurata, prima, la pressione? Sto meglio, il terrore sta passando, ma non ho la forza di alzarmi in piedi. Arriva una sedia a rotelle e il medico con la polo blu mi ci fa sedere. Pietro mi spinge fino ai taxi, fuori dall’aeroporto. Mi aiuta a salire su una macchina bianca e dà l’indirizzo del pronto soccorso dell’ospedale Santo Bambino. Suo padre gli ha mandato il numero di un collega che ha un figlio che lavora lì. Il taxi ci lascia davanti all’entrata. Altra sedia a rotelle.
Mi portano in una sala d’attesa quadrata, piena di donne, nonni e bambini. Mi accascio con la testa sul petto: non ho forze, ma sto meglio. Ho ripreso a respirare. Di fianco a me, un signore anziano apre un pacchetto di rosticceria e porge un grosso arancino al ragù a un bimbo di quattro o cinque anni. Penso che è la prima volta che vedo un arancino al ragù e non ho voglia di dargli un morso.
Arriva un’infermiera bruna e sbrigativa, con un camice azzurro. Si capisce che non le piacciono i raccomandati, ma mi accompagna in una camera a due letti aprendo la porta dal maniglione antipanico con il gomito. Mi fa sdraiare su un letto. Chiede i miei dati mentre prepara la siringa per il prelievo. Quando sente il nome alza la testa, mi guarda e dice: «La regista? Ho visto Torno presto con mia sorella, un Natale. Come si sente adesso?».
Meglio. Sto meglio. Sfinita, ma la paura sta passando, e respiro. Ora sono certa che è stato un attacco di panico come ha detto la dottoressa bionda in aeroporto, che non ho niente, ma allungo il braccio destro indicando l’incavo: «Guardi, c’è un punto solo, lo metta qui». Dopo il prelievo mi chiede se voglio qualcosa. È diventata gentile.
«Un caffè dal distributore?» provo.
«Ora glielo porto. Stia sdraiata dieci minuti.»
Nel letto di fianco al mio è seduta una ragazza alta. Mi dà le spalle. Ha i capelli lisci e neri lunghi fino alla vita: non la vedo in faccia ma la immagino triste e bella. Una dottoressa le fa una carezza sul viso: «La prossima volta andrà meglio». Intuisco che ha perso il bambino.
È successo anche a me, anni fa, in un pronto soccorso di Milano identico a questo. Quando la dottoressa esce vorrei dirle qualcosa, ma lei non si volta e capisco che non ha voglia di parlare con me.
Dopo un quarto d’ora arriva il figlio del collega di mio suocero, in jeans e camicia azzurra. È sorridente e dice che l’emocromo va bene.
«12,1. L’ho già detto a suo marito. Sopra il 12 può star tranquilla.»
Stretta di mano. Grazie, grazie. Io lo sapevo, però. Saluto l’infermiera ormai gentilissima e scendo dal letto, da sola, finalmente. Spingo la porta antipanico in fondo al corridoio. Nella sala d’attesa esterna c’è Pietro che beve una Coca-Cola del distributore e parla al cellulare. Quando ha finito dice: «Ho riferito ad Angelo i valori dell’emocromo, sono buoni».
«Ha detto che sono pazza?» chiedo.
«No.»
E mi mostra l’sms del mio ginecologo: “È stressata, stanchissima e rompicoglioni”.
Strappo la busta gialla.
I risultati sono dentro una cartellina trasparente. Scorro in fretta le pagine segnate da asterischi fino alla conclusione: “Stress index 250,2 in clinostatismo e 139,1 in ortostatismo. Il quadro generale indica un elevato grado di stress protratto tanto a lungo da ridurre in maniera potenzialmente allarmante le riserve cognitive, emotive e fisiche dell’organismo”.
Non c’era bisogno di fare un check-up per saperlo. Sono esaurita, da mesi.
Lo so che lavoro troppo. Sono vent’anni che lavoro troppo, ma quassù sembra non esserci altro modo: o troppo o troppo poco. O tutto o niente.
Mi piace il “tutto o niente”. Fosse per me vivrei così. Ma tutto o niente vale soltanto nei sogni degli adolescenti, dei mistici e dei pazzi. Perciò me lo concedo solo sul lavoro, dove posso rompermi la schiena sul set e perdere il sonno in montaggio senza che nessuno abbia da ridire, anzi.
C’è un’impresa che campa sulla mia ossessione. Un indotto e stipendi che ruotano intorno alla mia mania. Fossi nata vent’anni prima, finivo terrorista o chissà che altra integralista testa di cazzo, ma quando avevo diciotto anni io, le strade per chi aveva il mio carattere erano due: fare la punk o la manager.
Ho scelto la prima, e stavo per morire.
Quella era la filosofia: meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. E si brucia davvero in fretta, più in fretta di quanto possiate immaginare. Anche facendo carriera si brucia, ma più lentamente: le braci ardono per anni prima di consumarsi del tutto.
Così, invece che una punk morta, oggi sono una regista, viva. Forse avete sentito parlare di Torno presto. Non è il mio miglior film, ma ha avuto successo. Io preferisco Ore felici e La ragazza morta. Con La ragazza morta ho vinto un premio internazionale, e adesso i produttori mi chiedono sempre la stessa storia. Quella di Torno presto.
Sono viva, ma stressata. E rimbambita. Io non ce l’ho il fisico per fare tutto. “Tutto” si fa per dire: figlie e lavoro. Ci sono molte cose che ho trascurato, nella vita. Cose importanti: bellezza, armonia, amore.
Non sono sempre stata così, da bambina ce l’avevo un centro. Da sola stavo bene e con gli altri la risolvevo a parole. Se loro correvano più forte, io parlavo meglio. Partivo bene. Fino a che non ho letto Sologub.
Ho tredici anni, faccio la terza media. Sono già io. Al mattino esco di casa in anticipo per andare a scuola a piedi. Mi piace svegliarmi presto e camminare. Penso. Penso alla vita e al mio futuro, mi sento che sarà intenso e bello. Lo covo nella pancia, come una palla di luce.
Cammino sul marciapiede, osservo i platani in mezzo al viale. Mi piacciono i platani, hanno il tronco splendente.
A scuola non mi diverto e non mi annoio. I professori sono insulsi, i compagni incolori. Tutto mi viene facile, vivo di rendita e aspetto il liceo. Aspetto anche le mestruazioni: sono venute a tutte le mie compagne tranne che a me. Non che mi dispiaccia, ma ne sono curiosa. Quando mia madre si preoccupa la prendo in giro: «Non mi vengono perché sono un maschio, mammina».
Lei inveisce, ma le scappa da ridere.
Il pomeriggio vado in parrocchia. Ci troviamo in sei o sette su una panchina di fronte alla chiesa. Parliamo.
Il più bello della compagnia, Sergio, un pomeriggio che piove mi chiede di diventare la sua ragazza. A me Sergio non piace, ma non mi azzardo a dire no. Mi accompagna a casa tenendomi per mano. Sono a disagio, ma so che è una trafila da seguire. Sopporto. Sergio è bruno, abbronzato e campione regionale di scherma. Io sono indifferente a ogni sport. Non sappiamo che dirci, ci teniamo per mano.
A una festa di compleanno balliamo allacciati He dei Today’s People e sento una cosa dura che mi preme addosso. Non so cosa sia, ma istintivamente ci strofino la coscia e a lui vengono le orecchie viola.
Un sabato pomeriggio Sergio mi invita a casa sua. Nel garage mi spinge contro il muro e mi mette la lingua in bocca. La lingua molle e bagnata mi fa senso, ma resisto. Però Sergio mi annoia, e piuttosto che uscire con lui passo i pomeriggi in casa a leggere i romanzi dei miei genitori, fingendo di studiare.
Un giorno pesco dalla libreria un tascabile impolverato. S’intitola Il demone meschino, l’autore è un certo Fëdor Sologub.
Ciò che accade con quel libro è un mistero.
Il protagonista è un professore russo...