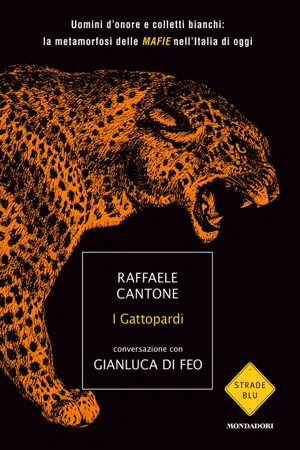![]()
Il fattore «c»
«Totò Riina i soldi li tiene nella calcestruzzi.» Quando Leonardo Messina parlò del tesoro del capo dei capi non ebbe dubbi. Era giugno del 1992, con l’Italia sotto choc per la strage di Capaci pochi compresero l’importanza delle dichiarazioni di quel collaboratore di giustizia che stava guidando i magistrati nel cuore del potere di Cosa Nostra. E verbalizzarono «calcestruzzi» con la c minuscola. Perché scrivere quel nome con la C maiuscola significava entrare nell’incredibile. Solo Paolo Borsellino, pochi giorni prima di morire, chiese al pentito di esplicitare: «Riina tiene i soldi nella Calcestruzzi spa». Ossia in uno dei pilastri dell’impero di Raul Gardini che assieme a Giovanni Agnelli e Silvio Berlusconi formava la triade degli imprenditori più ricchi e più noti agli italiani, l’uomo che al timone del Moro di Venezia aveva sfiorato l’America’s Cup, che aveva scalato la Montedison e sfidato la politica nel braccio di ferro su Enimont. Immaginare una delle sue aziende in affari con lo stragista corleonese era impossibile, superava ogni immaginazione. E la sua morte un anno dopo, quel proiettile alla testa nell’estate più buia della Repubblica, con tutta la sua catena di misteri, lascia la questione senza una certezza penale. I magistrati hanno approfondito il comportamento dei suoi manager, arrivando a delineare un accordo con i boss per la gestione degli appalti in Sicilia. Un cammino di cemento che è proseguito dopo la morte di Gardini e si è trascinato nel nuovo millennio anche quando alla ravennate Ferruzzi sono subentrati i bergamaschi del gruppo Pesenti.
Ad aprire gli occhi sulla sbornia di quei formidabili anni Ottanta in cui i soldi correvano veloci e nessun socio sembrava disdicevole, le sorprese non mancano. Pochi ricordano le condoglianze espresse per la morte di Sabato Galasso da Vittorio Chiusano, presidente della Juventus e legale di fiducia di Gianni Agnelli: i Galasso avevano l’esclusiva per la vendita dei camion Iveco in molte regioni meridionali. Solo dopo l’arresto e il pentimento del boss Pasquale Galasso, figlio di Sabato, si comprese la potenza economica della famiglia che da Poggiomarino con omicidi e tangenti aveva costruito una holding senza frontiere, partendo proprio da quella azienda monopolista dei tir Fiat. Quanto a Berlusconi, poi, accuse e archiviazioni per presunti rapporti con la mafia continuano a susseguirsi da un decennio: indagini che affondano proprio in quella stagione d’oro degli anni Ottanta. Quando tanti imprenditori – per scelta o per necessità – vengono a conoscere il fattore «c».
È una fase sperimentale, in cui si intrecciano le radici di accordi sbocciati con il tempo. Padrini e industriali si guardano negli occhi, spesso alla tavola dei politici o dei mediatori d’affari massonici, imparano a mettersi d’accordo nei cantieri delle grandi opere, si studiano fino a definire regole e perfezionare un modo di operare insieme. Per molti cavalieri del lavoro venuti dal Nord è il male minore, che come tutti i mali minori implica però l’accettazione del male: la connivenza per convenienza. Per tanti industriali nati al Sud è l’unica strada per non soccombere, costretti a convivere con clan sempre più ricchi e sempre più spietati. Boss che non si accontentano di taglieggiare le aziende ma vogliono diventarne soci e, quando possibile, proprietari. Parecchi imprenditori emigrano: vendono gli stabilimenti creati con sacrifici di generazioni e riaprono mille chilometri più a nord. Pochi resistono, con orgoglio e ostinazione, pagando con la vita come Libero Grassi, assassinato a Palermo per la sua plateale rivolta contro il racket. I più si piegano, limitandosi a pagare o spingendosi oltre per cavalcare l’onda della mafia imprenditrice.
È il fattore «c»: convivenza, connivenza, convenienza, le tre parole chiave che declinano l’evoluzione di questo patto criminale che ha falciato tante vittime. Uccide il mercato, assassina la possibilità di concorrenza e libera impresa. Poi su questa tomba si creano nuove regole, alimentando assunzioni pilotate e legalizzando capitali sporchi di sangue che diventano sfarzo, ma spesso anche nuove imprese. Un circuito viziosissimo, che in vent’anni ha avvelenato l’economia meridionale e contagiato quella settentrionale. Fino a creare una realtà bifronte che è radicalmente cambiata: le armi e i soldi, la violenza e gli affari. Le mafie oggi si presentano sulla scena imprenditoriale soprattutto come un service: offrono servizi, efficienti, rapidi e poco costosi. Mettono a disposizione capitali cash con tassi spesso inferiori a quelli delle banche: pacchi di banconote pronta cassa. Garantiscono manodopera disciplinata e qualificata con costi ridotti e nessuna rivendicazione sindacale. Tengono lontani ladri e ricattatori con una giustizia inesorabile e dirimono qualunque controversia con i fornitori senza bisogno di finire nel labirinto dei tribunali civili più lenti d’Europa. Aprono le porte della burocrazia sbloccando rapidamente pratiche comunali e regionali incagliate da tempi biblici: licenze e autorizzazioni spuntano dai cassetti come per magia, vanificando ogni ostacolo. Chi può offrire di più?
Le cosche sono altamente competitive. Il modello antico di Cosa Nostra come industria della protezione, quello che imponeva una tassa tutto sommato accettabile in cambio della sicurezza, quello dei guardiani con la lupara che vigilavano sui latifondi dei baroni siciliani, è stato surclassato dalla nuova mafia cooperante, partner perfetto per ogni impresa che voglia mettere piede al Sud o che sia in cerca di un acceleratore per moltiplicare le sue attività al Nord. Non c’è bisogno di esplicitare la minaccia, non c’è bisogno di mostrare le armi: che quei partner non abbiano studiato alla Bocconi lo sanno tutti e tutti conoscono cosa si rischia nel tradire i patti. Il paradosso è che la violenza diventa un «asset», come lo definiscono i bilanci aziendali, uno degli elementi che rendono interessante il socio: il passe-partout decisivo per scavalcare qualsiasi ostacolo.
In principio le mani dei padrini e quelle degli industriali si sono strette nei cantieri. Le opere pubbliche realizzate – o lasciate incompiute – negli anni Ottanta e Novanta hanno fatto crescere questa mafia cooperante. Quelle mani sporche di sangue le hanno strette tutti. E le stringono anche oggi, alimentando un’economia parallela che si allarga senza frontiere, macinando guadagni e consenso. Che, insieme alle armi, formano il triangolo del vero potere mafioso.
All’inizio i soldi della mafia imprenditrice venivano concentrati nei settori dominati in monopolio. Il cemento, per esempio. Quel calcestruzzo – con la c minuscola e maiuscola – che tanto piaceva a Totò Riina. I pilastri dei lavori infiniti lungo la Salerno-Reggio Calabria. E le betoniere degli stabilimenti delle famiglie casalesi lungo l’asse strategico che unisce Napoli a Roma. Stesso copione per il movimento terra, fondamentale per ogni grande opera: le cave che hanno divorato i fianchi delle montagne e i letti dei fiumi, gonfiando di sabbia i piloni e di sassi le massicciate di autostrade e treni ad alta velocità. Anche in Lombardia da vent’anni tutti i rapporti degli inquirenti indicano i calabresi come signori degli sbancamenti, arbitri del viavai di ruspe e camion ribaltabili. C’è una dinastia che domina i dossier delle polizie, quella creata da Franco Coco Trovato: una storia come tante, di un muratore venuto dalla provincia di Catanzaro fino alla feconda Brianza lecchese, e diventato capace di riempire i suoi tir con ghiaia e miliardi di lire. Sia lui che il figlio sono finiti in cella, ma ancora oggi le fondamenta dell’Expo futura vengono scavati da bulldozer che oltre alla polvere sollevano gli stessi sospetti. Il rapporto annuale della Superprocura redatto nei primi mesi del 2010 non usa mezzi termini: «Le indagini consentono di appurare come le organizzazioni di matrice calabrese in Lombardia siano diventate vera e propria mafia imprenditrice, e mirino ad accaparrarsi appalti pubblici e commesse private. Non v’è chi non veda che trattasi di una realtà estremamente grave che suscita particolare allarme specie se si considera che il territorio in questione sarà interessato dalle grandi opere che si eseguiranno in funzione dell’Expo 2015». Uno scenario cupo, che ha trovato conferme anche nell’ultima inchiesta condotta dal pm Ilda Boccassini.
Una torta ricca come quella dell’Esposizione universale, con la prospettiva di rifare il volto della metropoli, impone anche di sporcarsi le mani e giocare duro per tenere lontani dal banchetto i concorrenti, legali o criminali. Perché la leadership di Trovato è rimasta ai suoi alleati storici, gente spietata venuta dall’Aspromonte che ha legato le sue origini ai primi grandi sequestri di persona, usati come strumento per accumulare i capitali di partenza per il narcotraffico e gli investimenti: «Si era già parlato nella relazione dello scorso anno degli esiti della indagine all’ordinanza di custodia contro la articolazione lombarda delle famiglie Barbaro-Papalia di Platì (tra loro legate anche da vincoli parentali) per aver acquisito il controllo della attività di movimento terra nell’ambito territoriale della zona sudovest dell’hinterland milanese, in particolare nel territorio del Comune di Buccinasco, imponendo agli operatori economici la loro necessaria presenza negli interventi immobiliari. Il tutto attraverso intimidazioni consistite in danneggiamenti e incendi sui cantieri, esplosioni di colpi d’arma da fuoco contro beni di altri imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti o a pubblici amministratori, minacce a mano armata, imposizione di un sovrapprezzo nei lavori di scavo».
Un modello d’intervento vecchio stile, sempre più raro nelle cronache. Sia perché gli imprenditori preferiscono tacere e non denunciare gli attentati, sia perché solo eventi eccezionali come l’Expo, che fanno accorrere nuovi concorrenti in territori prima saldamente controllati, impongono di impugnare le armi. Non bisogna però pensare che quello delle cave e del movimento terra sia un business all’antica: è il paradigma invece della capacità di sfruttamento totale dei clan, che sanno creare sempre nuove opportunità. Modernissime. Lo dimostra il monitoraggio di Bankitalia sui flussi di denaro sospetti, realizzato dall’Unità di informazione finanziaria, un gruppo di detective dell’analisi economica che applicano la massima aurea di Giovanni Falcone sulla necessità di seguire i soldi per scoprire il potere dei boss. Proprio il database di Bankitalia illumina le potenzialità di questo mercato: gli «Untouchables» di Mario Draghi hanno evidenziato 139 operazioni nel 2007 e ben 154 nel 2008
relative a imprese operanti nel settore dello smaltimento e riciclaggio di rifiuti, specie di quelli pericolosi. L’operatività segnalata riguarda principalmente cospicui giri di fondi attuati mediante bonifici (anche tramite remote banking) che coinvolgono più società attive, oltre che nel settore della raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti, anche nell’attività di movimento terra e nella gestione di cave. Il legame tra il ciclo dei rifiuti e il ciclo del cemento è, infatti, molto stretto e si fonda sull’utilizzo delle cave abusive, che, una volta esaurite, vengono utilizzate come discariche illegali. La ricostruzione dei flussi ha consentito di osservare che, a giustificazione di tali giri di fondi, vengono emesse fatture per operazioni inesistenti di recupero e smaltimento dei rifiuti, che permettono di «declassificare» i rifiuti da pericolosi a non pericolosi e di avviarli, così, a procedure di recupero semplificate e, quindi, meno costose. Il sistema delle fatturazioni garantisce, altresì, l’incasso per intero dei proventi dello smaltimento illecito, caricandone i costi sulle strutture pubbliche.
Perfetto, quasi geniale. Uno sfruttamento totale. La terra per le grandi opere, i rifiuti sepolti nelle cave, la collettività che paga per lo smaltimento e si accolla il danno incalcolabile per l’ambiente e per la salute provocato dall’avvelenamento dei suoli. Anche qui i soci di mafiosi, ’ndranghetisti e camorristi sono imprenditori che si muovono nella legalità e a cui gli emissari dei clan magnificano un servizio completo e competitivo. Il broker di Gomorra interpretato sullo schermo da Toni Servillo è ancora al lavoro: si presenta tutti i giorni negli uffici delle aziende con il suo catalogo di offerte molto speciali. E trova sempre nuovi clienti, nonostante adesso – dopo il libro di Saviano e il film di Garrone – tutti sappiano.
D’altronde i veri mafiosi hanno sempre saputo come ottimizzare le risorse. Il potere dei corleonesi nasce così. Comprano camion negli anni Cinquanta per trasportare vitelli e agnelli, spesso rubati, nei mattatoi clandestini. Quando i primi appalti fanno piovere denaro e lavoro nei loro territori, usano quegli stessi camion per trasportare terra, cemento e manodopera nei cantieri. E poi salgono su quei camion per infilarsi nella corsa all’oro del sacco edilizio di Palermo, con i condomini che germogliano negli agrumeti e i mitra che aprono la strada all’ingresso di Totò Riina nel Gotha di Cosa Nostra. Un’evoluzione costante per sfruttare qualunque occasione si presenti. O per crearne di nuove. Quando alla fine degli anni Novanta nasce la stagione dei centri commerciali, e si innalzano dal nulla le cattedrali dello shopping che modificano persino le abitudini di vita delle città meridionali, sostituendo allo struscio nel corso principale il pellegrinaggio tra le vetrine, i picciotti sono i primi a intuirne le possibilità. Le indagini aperte in Sicilia mostrano come i clan hanno condizionato tutta questa rivoluzione dei consumi, pilotando ogni fase dell’operazione.
È la scoperta di una formula vincente, quella del franchising: lo strumento ideale per la criminalità organizzata, l’abito buono con cui rivestire i soldi sporchi. Ma in fondo quello del franchising è anche il modello a cui è approdato il loro sistema di fare azienda e stringere patti con l’imprenditoria: offrire una serie completa di servizi in cambio di un sovrapprezzo, in denaro cash, in beni e in assunzioni mirate. Il partner dei boss può fregiarsi di un’insegna, invisibile ma nota a tutti sul territorio, che garantisce una gamma di benefici: un marchio che funziona e che gli permette di entrare in mercati altrimenti difficili se non impossibili.
Questo sistema sembra avere risolto un altro dei problemi più forti dei padrini: godere materialmente dei propri beni o comunque averli sotto gli occhi. Perché detestano affidare i loro soldi a estranei. Paolo Borsellino, tre settimane prima della sua morte, spiegava che le famiglie non avevano mai digerito la lezione di Michele Sindona e Roberto Calvi: tesori consegnati in mani che poi non erano state capaci né di farli fruttare, né di restituirli. Il crollo delle due banche si era rivelato una batosta, carica di implicazioni negative: fondi bruciati, inchieste giudiziarie, scandali politici. «Il problema è lo stesso» sintetizzava Borsellino: «Se devi investire qualche centinaio di milioni puoi comprare un ristorante, una villa, un negozio. Beni che restano sotto i tuoi occhi. Ma se devi muovere pacchi di miliardi ci sono pochissime persone a cui puoi rivolgerti e sono sempre le stesse». Tanti soldi messi nella cassaforte di un esterno e investiti in iniziative complesse sono sempre un pericolo: se c’è un guaio, come si fa a recuperarli?
Un negozio, un palazzo, un ristorante si possono vendere o intestare a un prestanome. Quote azionarie, prodotti finanziari, conti offshore invece sfuggono al controllo. Nel dicembre 2009 la Procura di Bari ha ricostruito il rapporto tra Savino Parisi, il capo della cosca pugliese più importante, e Michele Labellarte, un manager spregiudicato della new economy. Labellarte, un quarantenne rampante con fama di playboy, nel 2003 aveva fatto crack con la sua New Memotech ed era finito in cella per bancarotta e frode fiscale. Proprio in carcere l’enfant prodige dell’informatica e il padrino si erano conosciuti e avevano usmato le reciproche capacità: un’intesa suggellata dopo il ritorno in libertà con la consegna di tre milioni di euro. Con quel denaro il rampante aveva garantito un profitto di ventimila euro cash al mese, fornito i fondi neri per acquistare partite di cocaina, sovvenzionato entrature politiche di altissimo livello. Aveva intestato un conto persino a Elvira Savino, giovane parlamentare del Pdl amica di Silvio Berlusconi. Ma aveva anche impegnato il denaro in società estere, in immobili con intestazioni fittizie, in operazioni immobiliari come il nuovo campus universitario del capoluogo pugliese. Quando nel maggio 2009 Labellarte viene colpito da un tumore fulminante, il padrino teme di perdere il suo capitale. Corre in ospedale, ignorando che i finanzieri del Gico (Gruppo d’investigazione sulla criminalità organizzata) vi avevano piazzato una microtelecamera: «La vita tua è la vita nostra... Noi per te vogliamo la vita lunga... Ma se succede qualcosa a te, noi dove dobbiamo andare? Noi dobbiamo mettere i soldi in sicuro, perché a livello di cognomi questi sono già bruciati». Labellarte gli risponde di mandargli Vito Valenzano, un imprenditore incensurato inserito come filtro pulito nella catena del riciclaggio, che troverà nuovi «soci». E i famosi tre milioni di euro iniziali? Labellarte: «Ho delegato un commercialista per tutta l’operazione... Allora, questi tre, se me li danno in nero, dovrei darveli in un paio di mesi. Ma se me li danno regolari, li devo tirare fuori in modo regolare tramite i miei soci...». Parisi s’illumina: «Ho capito: dobbiamo tenere le carte tutte in regola ... Noi possiamo aspettare».
Le mafie possono aspettare, perché sanno che nessuno riesce a fare a meno di loro.
Il «camorra service»
Dottor Cantone, lei nella sua lunga attività di pubblico ministero ha indagato spesso sull’infiltrazione della camorra nell’economia. Le inchieste della Procura antimafia di Napoli hanno dimostrato come la criminalità organizzata abbia creato in Campania nuovi metodi per condizionare la vita delle aziende, fino a prendere il controllo di cantieri, negozi e fabbriche: è nata una zona grigia dove prosperano gli investimenti dei clan. Come è cambiato oggi il rapporto tra cosche e imprese?
In un passato, anche recente, il rapporto mafia-impresa veniva letto in una chiave abbastanza semplicistica; gli uomini d’affari erano sempre considerati povere vittime delle consorterie criminali. Ancora all’inizio degli anni Novanta un giudice istruttore siciliano scriveva in una sentenza che il rapporto con l’associazione criminale sarebbe comunque «imposto dall’esigenza di trovare soluzioni di non conflittualità con la mafia, posto che nello scontro frontale risulterebbe perdente sia il più modesto degli esercenti sia il più ricco titolare di grandi complessi aziendali». Era questo il frutto di una visione manichea della realtà, in cui le imprese sono i buoni e i boss i cattivi, che nasceva evidentemente da una conoscenza riduttiva della mafia, percepita solo come «coppola e lupara». Non si voleva assolutamente tenere conto nemmeno di quello che stava avvenendo all’interno delle mafie medesime. Senza dilungarmi troppo, mi basta ricordare che quando Raffaele Cutolo instaura con lo Stato la trattativa per giungere alla liberazione di Ciro Cirillo, l’esponente della Dc campana rapito dalle Br, chiede non solo benefici carcerari e denari ma anche la possibilità di inserirsi nel sistema dei subappalti del dopo terremoto. E siccome Cutolo non era titolare di imprese edili è evidente che poteva contare su una rete di aziende su cui far confluire questi lavori pubblici. La novità è proprio questa: le società traggono vantaggio dal patto con i boss. In estrema semplificazione, le mafie non si limitano a essere un fattore di contrasto all’imprenditoria, spesso si presentano persino come un service, una società di servizi che in cambio di una tariffa – fissa o a percentuale – aiuta le aziende più spregiudicate a operare sul mercato.
Sembra di avere davanti il personaggio di Pulp Fiction: «Sono il signor Wolf. Risolvo problemi». Che poi infatti aggiungeva una dichiarazione dal sapore molto mafioso: «Mi rispettano tutti perché ho carattere». Nelle indagini che lei ha condotto sulla camorra non si incontra...