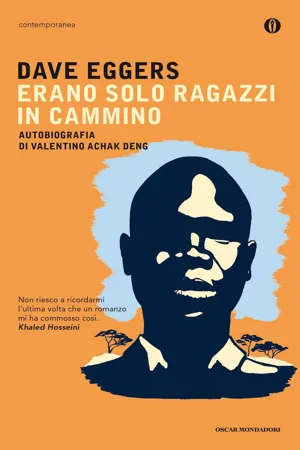Non ho ragioni per non farlo, quindi apro la porta. Non possiedo uno di quei minuscoli finestrini rotondi per ispezionare i visitatori, così apro e di fronte a me trovo una donna afroamericana alta e robusta, di qualche anno più vecchia di me, in tuta di nylon rossa. Mi parla ad alta voce: «Ha un telefono, signore?».
Ha un’aria familiare. Sono quasi certo di averla notata nel parcheggio un’ora fa, mentre facevo ritorno dal supermercato. L’ho vista ai piedi delle scale e le ho sorriso. Le dico che sì, ho un telefono.
«Mi si è rotta la macchina.» Alle sue spalle è quasi notte. Ho studiato per la gran parte del pomeriggio. «Mi farebbe chiamare la polizia dal suo telefono?»
Non so perché voglia chiamare la polizia per una macchina in panne, ma acconsento. Entra. Faccio per chiudere la porta ma lei la tiene aperta. «Ci vorrà un secondo» dice. Trovo che non abbia alcun senso lasciare la porta aperta ma lo faccio perché lei sembra desiderare così. È il suo paese, questo, non il mio.
«Dov’è il telefono?» chiede.
Le dico che il mio cellulare è in camera da letto. Prima ancora che abbia finito la frase mi ha già superato e si dirige in corridoio, una specie di Hulk in uno strofinio di nylon. Accosta la porta, sento uno scatto. Si è chiusa a chiave nella mia camera da letto. Sto per seguirla, quando una voce alle mie spalle dice: «Fermo, Africa».
Mi giro e vedo un afroamericano che indossa un giubbotto da baseball troppo grande color azzurro polvere e un paio di jeans. Non riesco a scorgere il suo viso sotto il berretto con la visiera ma noto che tiene una mano aggrappata a un punto della cintura, come se avesse bisogno di reggersi i pantaloni.
«Sei con quella donna?» chiedo. Non ci sto capendo niente e sono arrabbiato.
«Seduto, Africa» dice, indicando con un cenno il divano.
Rimango in piedi. «Che cosa sta facendo in camera mia?»
«Posa il culo» dice, questa volta con una nota velenosa nella voce.
Mi siedo e a questo punto mi mostra il calcio di una pistola. È da quando è entrato che ce l’ha in mano e avrei dovuto saperlo. Ma io non so niente. Non so mai quello che dovrei sapere. Adesso però so che mi stanno rapinando, e vorrei tanto essere altrove.
È strano, mi rendo conto, eppure in quel momento penso che vorrei essere di nuovo a Kakuma. A Kakuma non pioveva mai, i venti soffiavano per nove mesi all’anno e ottantamila rifugiati di guerra provenienti dal Sudan e da altre regioni vivevano con un pasto al giorno. Ma in quel preciso momento, mentre quella donna è nella mia camera da letto e l’uomo di fronte a me mi tiene sotto tiro, voglio essere a Kakuma, dove vivevo in una capanna fatta di plastica e sacchi di tela e avevo un solo paio di pantaloni. Non sono sicuro che al campo di Kakuma ci fosse quel genere di malvagità, e voglio farvi ritorno. O anche a Pinyudo, il campo in Etiopia dove ho vissuto prima di Kakuma; non c’era nulla lì, oltre a un paio di pasti al giorno, eppure anche quel luogo riservava i suoi piccoli piaceri. Ero un ragazzino e riuscivo a dimenticare di essere un profugo malnutrito a migliaia di chilometri da casa. In ogni caso, se questa è la punizione per il peccato di arroganza commesso nel lasciare l’Africa, nell’avere cullato sogni di istruzione e di benessere in America, sono pentito e faccio ammenda. Tornerò a capo chino. Perché ho sorriso a quella donna? Lo faccio sempre senza riflettere ed è un’abitudine che devo abbandonare. Invita alla ritorsione. Sono stato umiliato così tante volte dal mio arrivo che comincio a pensare che qualcuno stia cercando disperatamente di mandarmi un messaggio, e quel messaggio è “vattene”.
Non faccio in tempo ad assestarmi in questo mio stato mentale di rimpianto e sconfitta, che vengo colto da un moto di protesta che mi spinge ad alzarmi e rivolgermi all’uomo vestito in azzurro polvere. «Voglio che ve ne andiate» dico.
Azzurro Polvere si arrabbia all’istante. Ho disturbato l’equilibrio, gettando l’ostacolo della mia voce sul loro cammino.
«Mi stai dicendo quello che devo fare, figlio di puttana?»
Lo fisso nei piccoli occhi.
«Dimmi un po’, Africa figlio di puttana, mi stai dicendo quello che devo fare?»
La donna sente le voci e dalla camera dice: «Te ne vuoi occupare sì o no?». Ha un tono esasperato nei suoi confronti, proprio come lui verso di me.
Azzurro Polvere inclina il capo verso di me e alza le sopracciglia. Fa un passo in avanti accennando alla pistola che porta infilata alla cintura. Sembra in procinto di usarla, ma improvvisamente rilassa le spalle, crolla il capo. Si guarda le punte dei piedi e respira lentamente, come per riprendere il controllo. Quando solleva lo sguardo, è nuovamente padrone di sé.
«Tu vieni dall’Africa, giusto?»
Annuisco.
«Perfetto, allora. Siamo fratelli.»
Concordo malvolentieri.
«E dato che siamo fratelli e tutto il resto, ti voglio insegnare una cosa. Non lo sai che non si dovrebbe mai aprire la porta agli sconosciuti?»
La domanda mi fa sussultare. La rapina pura e semplice era, fino quel punto, più o meno accettabile. Ne ho viste di rapine, altre ne ho subite, anche se di scala infinitamente inferiore a questa. Fino al mio arrivo negli Stati Uniti il mio bene più prezioso era costituito dal materasso su cui dormivo, di conseguenza i furti erano assai più trascurabili: una macchina fotografica usa e getta, un paio di sandali, una risma di fogli di carta bianca. Tutto ciò aveva un valore, certo, ma adesso possiedo un televisore, un videoregistratore, un forno a microonde, una sveglia, parecchi altri elettrodomestici, tutti fornitimi dalla Chiesa Metodista Unita di Atlanta. Alcuni oggetti erano usati, la gran parte nuovi, tutti mi erano giunti anonimamente. Guardarli, usarli ogni giorno, mi faceva fremere di una strana ma genuina sensazione fisica di gratitudine. E ora immagino che tutti questi doni mi verranno sottratti nel giro di pochi minuti. Sono in piedi di fronte ad Azzurro Polvere e la mia memoria fruga alla ricerca dell’ultima volta in cui mi sono sentito tradito a tal punto, in cui mi sono sentito così temerario in presenza del male.
La mano ancora appesa al manico della pistola, l’uomo mi mette l’altra sul petto. «Perché adesso non posi il culo e ti godi lo spettacolo?»
Faccio due passi indietro e mi siedo sul divano, anche quello regalo della chiesa, portatomi da una donna bianca con la faccia di mela che indossava una maglietta colorata a mano, il giorno che Achor Achor e io ci siamo trasferiti qui. Si era scusata del fatto che non l’avessimo già trovato al nostro arrivo. La gente della chiesa si scusava spesso.
Osservo Azzurro Polvere e so chi mi ricorda. La soldatessa etiope che sparò a due miei amici e quasi ammazzò me. Aveva la stessa luce selvaggia negli occhi e anche lei sulle prime si era atteggiata a nostra salvatrice. Stavamo lasciando l’Etiopia, inseguiti da centinaia di soldati che ci sparavano addosso, il fiume Gilo era pieno di sangue, e all’improvviso era uscita dall’erba alta: Bambini, venite da me! Venite dalla mamma! Non era che un volto tra i fili d’erba e due mani tese, e io esitai un secondo. Due dei ragazzini con cui stavo scappando e che avevo incontrato sulla riva del fiume insanguinato si diressero verso di lei. Quando furono abbastanza vicini la donna imbracciò un fucile automatico e li crivellò di colpi allo stomaco e al petto. Caddero proprio di fronte a me e io mi girai e scappai. Torna qui! continuava lei intanto. Vieni dalla mamma!
Quel giorno corsi tra l’erba finché non incontrai Achor Achor e fu con lui che trovammo il Bambino Silenzioso e lo mettemmo in salvo e per qualche tempo ci considerammo dei dottori. È accaduto così tanti anni fa. Avevo dieci anni, forse undici. Impossibile stabilirlo per certo. Azzurro Polvere, qui di fronte a me, di sicuro non avrebbe mai sperimentato niente del genere in vita sua. Non gli sarebbe neppure interessato. Ripensare al giorno in cui venimmo condotti dall’Etiopia nuovamente in Sudan, a quelle migliaia di morti nel fiume, mi restituisce la forza per oppormi a quella persona. Mi alzo di nuovo.
Ora mi guarda come un genitore in procinto di fare qualcosa che non vorrebbe fare ma a cui suo figlio lo sta costringendo. Mi si fa talmente vicino che avverto un vago odore chimico che gli aleggia intorno, come di candeggina.
«Vuoi… Vuoi…?» Stringe le labbra e smette di parlare. Quindi afferra la pistola e la solleva sopra la testa. Una confusione di nero, i denti che sbattono violentemente gli uni contro gli altri e vedo il soffitto cadermi addosso.
In vita mia sono stato picchiato in parecchi modi ma mai con una pistola. Ho la fortuna di avere visto più sofferenza di quanta ne abbia dovuto subire, anche se ho patito la fame, sono stato colpito con bastoni, mazze, scope, pietre, lance. Ho viaggiato per otto chilometri su un camion carico di cadaveri. Ho osservato molti, troppi bambini morire nel deserto, c’era chi si accovacciava come per dormire, altri morivano dopo giorni e giorni di pazzia. Ne ho visti tre attaccati e divorati dai leoni, ho visto come li sollevavano da terra per poi trascinarli via tenendoli tra le zanne e divorarli nell’erba alta, abbastanza da vicino per riuscire a sentire lo schiocco umido della carne strappata. Ho visto un amico morirmi accanto in un camion ribaltato, i suoi occhi che mi fissavano, la vita che gli colava via da un invisibile buco. Eppure in questo momento, mentre sono riverso sul divano, la mano bagnata di sangue, sento che l’Africa mi manca. Mi manca il Sudan, mi manca l’ululato del deserto grigio del Nordovest del Kenya. Mi manca quel nulla giallo che è l’Etiopia.
Ora riesco a scorgere solo la vita e le mani del mio avversario. Ha messo via la pistola, le sue mani adesso mi afferrano la camicia, il colletto, e mi scaraventano per terra. Nel cadere sbatto la nuca sul bordo del tavolino e due bicchieri e una sveglia mi seguono sul pavimento. Disteso, la guancia che riposa in una pozza del mio stesso sangue, provo uno strano conforto nel pensare che con ogni probabilità ha finito. E io sono già talmente stanco. Mi sembra che potrei chiudere gli occhi e mollare tutto.
«E adesso chiudi quella cazzo di bocca» dice.
Sono parole che risuonano senza convinzione e questo mi dà sollievo. Capisco che non è in collera. Non intende uccidermi, forse è semplicemente manipolato dalla donna che adesso sta aprendo i cassetti e gli armadi in camera mia. È lei quella che pare avere il controllo della situazione, concentrata sul contenuto della mia camera, mentre il compito del suo compagno è semplicemente quello di neutralizzarmi. Sembra un lavoro facile, e l’uomo non sembra intenzionato a farmi ancora del male. Quindi mi riposo. Chiudo gli occhi e mi riposo.
Sono stanco di questo paese. Gli sono grato, certo, e nei tre anni che ci ho vissuto ne ho ammirato profondamente alcuni aspetti, ma sono stanco delle sue promesse. Sono arrivato fin qui, siamo arrivati in quattromila, nell’attesa e nella speranza di tranquillità, pace, istruzione, sicurezza. Ci aspettavamo un paese senza guerra e, immagino, una terra senza povertà. Eravamo inebriati e impazienti. Volevamo tutto e subito, case, famiglie, università, la possibilità di mandare soldi a casa, istruzione superiore e per finire una qualche forma di influenza. Ma per la gran parte di noi la lentezza della transizione – dopo cinque anni non ho ancora i crediti sufficienti per iscrivermi a un college e frequentare un corso quadriennale – ha significato il caos. Avevamo aspettato dieci anni a Kakuma e nessuno di noi desiderava ricominciare da capo in questo posto. Volevamo la fase successiva, e la volevamo presto. Ma nella maggior parte dei casi ciò non era successo, e nell’attesa ognuno di noi aveva trovato dei modi per passare il tempo. Io avevo intrapreso una serie fin troppo lunga di lavori temporanei, e al momento ero impiegato alla reception di un fitness club nel turno della prima mattina, con il compito di accogliere i membri e spiegare ai potenziali clienti i benefit della palestra. Niente di particolarmente esaltante, eppure rappresenta un livello di stabilità ancora sconosciuto ad alcuni di noi. In troppi sono caduti, in troppi sentono di avere fallito. Le aspettative, le promesse che non riusciamo a mantenere neppure con noi stessi, tutto ciò sta trasformando parecchi tra noi in mostri. E l’unica persona che sentivo avrebbe potuto aiutarmi a superare la delusione e la banalità di tutto questo, una classica donna sudanese di nome Tabitha Duany Aker, non c’è più.
Adesso sono in cucina. I due si spostano nella stanza di Achor Achor. Steso a terra, comincio a fare il computo di tutto quello che possono rubarmi. Mi rendo conto con una certa soddisfazione che il mio computer è in macchina, per cui si salverà. Ma il nuovo portatile di Achor Achor sparirà. E sarà colpa mia. Achor Achor è uno dei leader dei giovani profughi qui ad Atlanta e ho paura che, una volta rubatogli il computer, con esso scomparirà tutto quello di cui ha bisogno. I verbali delle riunioni, i conti, migliaia di e-mail. Non posso permetterlo. Achor Achor è con me dai tempi dell’Etiopia e non faccio altro che portargli sfortuna.
In Etiopia ho fissato un leone negli occhi. Avevo forse dieci anni, mi avevano mandato nella foresta a cercare legna e la belva emerse lentamente da dietro un albero. Per un istante interminabile, sufficiente per imprimermi nella memoria il muso e gli occhi privi di espressione, rimasi immobile, quindi cominciai a correre. La belva lanciò un ruggito ma non mi inseguì, amo pensare che mi abbia trovato un avversario abbastanza temibile. Ho affrontato un leone, ho affrontato le armi da fuoco, decine di volte, dei miliziani arabi a cavallo, le loro tuniche bianche che splendevano sotto il sole. Perciò posso fermare un ladruncolo da strapazzo. Mi alzo di nuovo sulle ginocchia.
«Stai, g...