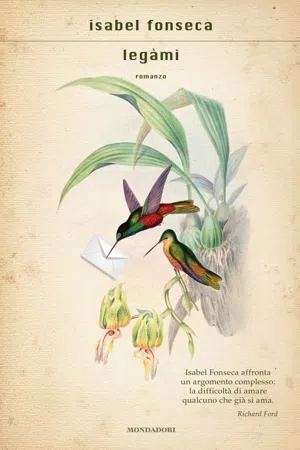![]()
St. Jacques
![]()
Un attimo di sconforto improvviso – tristezza di vita, la chiamava Aminata – veniva spiegato dai liberiani dell’isola come un problema di moleh aperta.
«Moleh» diceva Aminata, versando lo shampoo freddo sopra la testa di Jean, «fontanella, sai»: il punto dove le ossa del cranio non si saldano nelle prime settimane di vita, mentre i delicati organi vitali pulsano sotto la pelle nuova e liscia. Aminata Dia, orgogliosa proprietaria dell’unico salone di bellezza di St. Jacques, tracciava lenti cerchi sul cuoio capelluto di Jean. Procedeva dall’interno verso l’esterno, alzando le spalle larghe, e poi tornava indietro, abbassando i gomiti, le mani forti immerse in una schiuma densa e compatta come chiara d’uovo montata a neve.
«Problema è quando moleh si riapre e tu sei grande: da lì entrano problemi. Tu li fai uscire, li dici a me, e la moleh si richiude.»
Jean, arrivata sull’isola da appena una settimana, aveva ricavato un articolo da quella conversazione. Inoltrarlo era stato più difficile che scriverlo: le linee telefoniche sibilavano e crepitavano per l’umidità, e a volte saltavano del tutto. Ma quando era finalmente riuscita a spedire il pezzo al direttore della rivista “Mrs”, da un Internet café giù in paese, si era sentita ancora più soddisfatta per aver superato quelle difficoltà. Jean amava tutto dell’isola: le linee malfunzionanti erano una liberazione dal telefono, mentre l’Internet café, con il pavimento sabbioso e i cani addormentati davanti all’ingresso, offriva un’allettante tregua dalla sua innata solitudine, permettendole di stare in compagnia pur rimanendo per conto proprio.
Mark aveva ragione: lavorare dall’isola era una passeggiata. «Una passeggiata in un clima caldo e afoso» aveva detto, «con le idee per i tuoi articoli che cascano dalle palme come noci di cocco.» Quelle stesse noci di cocco che costellavano il terreno intorno alla loro casa sulla collina, l’ufficio abbandonato di una vecchia miniera di stagno sopra Grand Baie. Mark aveva sempre bisogno di un nuovo progetto, e questa volta aveva scelto St. Jacques. «A che serve» le aveva spiegato «avere un’attività in proprio, se poi ne diventi schiavo?» Dirigeva una delle agenzie pubblicitarie più innovative di Londra, e la sua caccia al trasgressivo era così estesa e spietata che lui stesso si paragonava all’Interpol. Era convinto che quel trasferimento avrebbe automaticamente condotto a nuove scoperte, anzi, a nuovi campi di scoperta. Anche Jean era relativamente libera: curava una rubrica di salute pubblicata da diverse riviste e poteva anche vivere su Marte, a patto che inoltrasse le sue 1150 parole ogni due mercoledì.
Anziché su Marte, Jean era sbarcata sulla minuscola St. Jacques, un puntino nell’Oceano Indiano. La scala ridotta dell’isola l’aveva subito affascinata: la foresta pluviale in miniatura; l’unica grande città, Toussaint, circondata da una serie di piccoli villaggi collegati da una strada di terra battuta rossa; i mercati affollati; la gente cordiale, e non troppo disperata; gli uccelli variopinti in pericolo di estinzione… per tre mesi aveva goduto di quella lunga scampagnata fra sole e lavoro, maneggevole come un diorama. Fino a quel momento.
Il lento ventilatore di legno non riusciva a rinfrescare la sala d’attesa della clinica ginecologica. Jean guardava il modulo per stranieri che le avevano dato da compilare, incapace di concentrarsi. Invece pensava alla moleh aperta e fingeva di non fissare la signora seduta davanti a lei, una donna grande e massiccia come Aminata, in abito tribale. Deve avere cinque metri di stoffa avvolti intorno alla testa, pensò Jean, resistendo alla tentazione di allungare la mano per collaudare la solidità di un copricapo più simile a un nido di falco che a un turbante.
Per sfuggire al vortice dei pensieri, Jean cercò di indovinare da dove venisse quella donna: dall’Africa occidentale, senz’altro, forse dal Senegal come Aminata? O magari dalla Liberia, o dalla Sierra Leone? Jean stava diventando un’abile catalogatrice di isolani: la piccola comunità di africani occidentali in esilio, le varie enclave di africani dell’Est e indiani del subcontinente, cristiani, musulmani e indù. Erano quasi tutti di sangue misto, ma c’era anche un gruppo isolato di cinesi, discendenti di lavoratori a contratto, mentre nella punta settentrionale dell’isola si trovava un insediamento di “francesi”, bianchi di antiche origini europee. Jean, dal canto suo, aveva l’incarnato rosa intenso di una neonata urlante, e non solo per via della giornata insolitamente calda; le sue guance ardevano per lo shock di quella mattina, quando aveva fatto una sgradevole scoperta.
Jean aveva trovato la lettera sepolta in mezzo a un pacco di vecchia posta logorata dal viaggio: per lo più riviste, ma anche cartoncini d’invito a cocktail party, feste di beneficenza e pranzi di lavoro di tanto tempo prima, perché gli inviti dovevano percorrere diecimila chilometri per raggiungere gli Hubbard.
Christian, il postino strafatto, arrivava ogni mese su un motorino scoppiettante dipinto d’oro. Portava la borsa legata in diagonale sulla schiena, con lo stesso sistema che le donne di St. Jacques usavano per portare i bambini. Il bambino di Christian era la sua capigliatura: una specie di pagnotta lunga cinquanta centimetri, una grossa spugna di mare amorevolmente avvolta in un calzino arcobaleno.
Lo aveva avvistato dalla finestra della cucina, mentre affettava una papaia. Era uscita asciugandosi le mani nel grembiule e si era fermata sulla soglia, con un sorriso cordiale e le mani sui fianchi, incorniciata da due cespugli di ibisco rosa in fiore.
«Bonjour, Madame Uubahd» aveva gridato Christian dal viale d’accesso. «Come sta la padrona di casa in questa giornata perfetta?»
«Mai stata meglio» aveva risposto Jean. Christian si era fermato proprio davanti alla porta e aveva sorriso, mostrando il dente d’oro. Jean aveva ripercorso cento volte ogni istante di quella mattina: Christian che scendeva con aria solenne dal suo cocchio dorato e si chinava verso di lei, lisciandosi il pizzetto e appoggiando un braccio al muro della casa. Jean sapeva che non si sarebbe avvicinato tanto se Mark fosse stato lì con lei: un metro e novantatré scalzo, e una presenza notevole con quei capelli grigi pettinati all’indietro, fili d’erba spazzati dal vento che lasciavano sempre più scoperto il volto da ragazzino.
No, Christian non avrebbe indugiato, esibendo il sorriso dell’instancabile seduttore che sicuramente era. A parte il grosso spinello infilato dietro l’orecchio, Jean aveva pensato che la camicia stirata gli impediva di apparire sciatto.
La brezza fresca, l’ibisco, il sole che le scaldava le spalle nude; era il primo di aprile, e che magnifica allucinazione, aveva pensato Jean, guardare Christian – seguito dal suo bozzolo per capelli lavorato all’uncinetto – allontanarsi sobbalzando lungo la strada fino a sparire. Forse fumare marijuana era una buona idea, magari poteva chiedergliene un po’. Era rientrata in casa, stringendo il pacco con la posta.
«Ah. Un bel mucchio di robaccia, già imballata per il cestino della spazzatura» aveva detto Mark con la sua allegria da imbonitore, togliendole di mano il sacchetto di plastica e conducendola sulla terrazza dietro casa. Da lì si godeva la vista migliore sul lungo pendio del giardino cosparso di noci di cocco, e poi, al di là del muro di cinta che delimitava la proprietà, giù fino alla strada di terra battuta rossa e alle colline azzurre a occidente. L’oceano, invisibile dalla casa, era subito dietro quelle colline nebbiose. La maggior parte degli stranieri veniva a St. Jacques per le spiagge bianche, ma secondo Jean e Mark, più si stava sull’isola più si finiva per apprezzarne l’entroterra: verde, selvaggio, poco frequentato. Al momento il loro sguardo era fisso sul pacco, che Mark aveva posato sopra il tavolo come un magnifico arrosto e aveva aperto con un coltello a serramanico. Jean aveva dato un’occhiata alle spoglie, godendosi l’esibizione, ed era tornata in casa a preparare il caffè.
«Il latte è andato a male!» aveva gridato dalla finestra della cucina. «Vuoi un tè al limone? Oppure caffè nero?»
«Caffè nero» aveva risposto Mark, addentando una fetta di pane stracarica di marmellata di mirtilli e cominciando a esaminare le riviste. Lì c’era tutto il materiale che non si poteva spedire via e-mail, inviato tramite corriere da Noleen, la segretaria non troppo sveglia di Mark, insieme alla posta di Albert Street. Tuttavia, in un luogo come St. Jacques, dove al massimo si riusciva a trovare qualche copia molliccia di “Paris Match” della stagione precedente – anzi, dell’anno precedente – l’arrivo della posta suscitava un’aspettativa festosa che coinvolgeva anche Jean e Mark.
Aspettando il caffè, Jean si era messa alla finestra a guardare Mark che smistava le riviste. Non si era infilato gli occhiali, ma entrambi sapevano cosa avrebbe trovato: l’“Atlantic Monthly” e il “New Yorker” (di Jean), lo “Spectator” (di Mark, e di Jean per la pagina dei cruciverba) e il “Private Eye” (di Mark), il “New Statesman” (di Jean, per i concorsi settimanali a premi), e un mucchio di “The Week” (di entrambi). Jean sapeva che Mark avrebbe guardato subito “The Week”, e in particolare il bollettino meteorologico del Regno Unito, sperando di trovare pioggia. «La raison d’être» diceva «di ogni inglese all’estero.» Tralasciando le copie di “American Health” e “Modern Maturity”, le riviste geriatriche che Jean setacciava in cerca di idee per la rubrica, Mark era tornato in casa per dare inizio alla quotidiana ricerca degli occhiali.
Jean si era vestita con cura, perché quel mattino aveva un appuntamento alla clinica ginecologica. In seguito avrebbe riflettuto su quell’impulso: dare il meglio di sé nei momenti di crisi. Il vestito tirolese a quadretti con la lucida cintura arcuata, la camicetta senza maniche con il collo arricciato. Se non stavi attenta, da quelle parti, finivi per andare in giro con addosso una tovaglia. Come diceva Mark, il sarong era “la tuta da ginnastica dei tropici”.
«Mmm. Buongiorno, Lois Lane, dove vai questa mattina?» aveva detto Mark, divertito, fermandosi sulla portafinestra per lasciarla passare. Jean gli era scivolata accanto con circospezione, reggendo il vassoio del caffè. Lo aveva sfiorato strizzandogli l’occhio. Non si era ancora sbarbato, e indossava l’accappatoio di cotone blu con la cintura semislacciata. Aveva un grumo di marmellata nera appiccicato all’angolo della bocca. Si impiastricciava spesso durante la colazione, aveva pensato Jean con affetto, mentre a cena non gli succedeva mai, come se ogni giorno dovesse imparare da capo a mangiare.
«Ho un appuntamento galante» aveva risposto impassibile, felice che Mark avesse scordato quella mammografia di controllo. Farsi schiacciare i seni era già abbastanza brutto di per sé, senza bisogno che qualcun altro si immaginasse la scena.
Era stata subito attratta dalla busta sigillata con sopra il nome di Mark. Non l’aveva aperta di nascosto,o per sbaglio, e nemmeno perché particolarmente incuriosita dal contenuto; aveva solo provato l’intenso desiderio di aprire l’unica vera lettera di tutto il pacco. Ma dopo averla aperta si era insospettita, perché il foglio che aveva trovato all’interno non era indirizzato a Mark, o almeno non al Mark che conosceva. Che calligrafia tremenda, aveva avuto il tempo di pensare, mentre dava una scorsa al rudimentale guazzabuglio di corsivo e stampatello inclinato a sinistra.
Caro Coso,
SALUTI DALLE ZONE BASSE! Mi manchi già, Bestione sexy. Ti ho trovato invecchiato. Più spazio per l’abbronzatura sulla fronte! Ma anch’io sono invecchiata. 26 questa settimana! Eppure ricevo ancora più proposte del solito, se possibile. Mi hai trovata più vecchia e saggia? Perfettamente matura, pronta da mangiare? O solo più vecchia e PORCA?
Ti mando un ricordino su cui sbavare, vecchio sporcaccione, se non sei troppo rimbambito per aprire l’allegato. Ma queste dolci cosce devono essere
SOLO XI TUOI OCCHI, e così ho creato un bell’indirizzo nuovo per te. (Non credo che quello dell’ufficio sia una buona idea.) Il tuo indirizzo del piacere è:
[email protected]. Ragazzaccio era già occupato, naturalmente… ma non da me, giuro! L’oggetto sarà 69. Come potevo resistere? Bel maschione, ricordati di lavarti le mani prima di tornare al lavoro. Ciao bello!
XXX Cosa
P.S. La password è M… Vediamo se riesci a indovinare. Una pianta succhio-lenta di cui si mangiano i semi, ricordi? MM-mmm.
Jean aveva alzato lo sguardo dalla lettera, ritrovandosi a fissare l’occhio nero di un camaleonte fermo sul muro della casa. Aveva la lunga coda mollemente arrotolata a spirale, e la pelle identica a quella della lucertola che sua figlia Victoria si era fatta tatuare nell’incavo della coscia (per dare l’impressione che la lucertola spuntasse dalle mutandine?). La creatura verde opaco era perfettamente immobile sul muro, animata quanto la spilla gemella del tatuaggio. Ma mentre continuava a fissarla, cercando di cogliere ogni particolare per poterla descrivere alla figlia, Jean aveva notato il suo respiro corto e affannoso. Poi d’un tratto, con sorprendente e disgustosa rapidità, l’animale si era infilato dentro una crepa. Un sacco di roba sorprendente e disgustosa, aveva pensato Jean, e siamo solo all’ora di colazione.
Aveva ripercorso i fatti delle ultime ore, cercando di mantenere la calma. Il vestito elaborato, l’arrivo della posta, il latte andato a male. Si sentiva depressa e stupida, gli abiti da città le mettevano caldo. E quel patetico compiacersi delle attenzioni di Christian. Ora capiva, finalmente: stava aspettando la mancia. Ma certo! L’ultima volta che era venuto, Mark gli aveva dato una mancia spropositata. E perché lei gli aveva strizzato l’occhio? Se c’era un gesto che odiava era proprio quello, con la sua furbesca leziosaggine. Stava rimandando la resa dei conti con il reale significato della lettera, lo sapeva, ma intanto percepiva un immediato adeguamento del proprio punto di vista. Mark, dentro casa, era già trasfigurato; quel grumo di marmellata, per esempio: d’un tratto non aveva più niente di carino.
Seduta in terrazza, circondata dagli strilli dei pappagalli sugli alberi di eucalipto, Jean aveva pensato all’altra signora Hubbard, la madre di Mark. La donna adorava suo figlio, gli concedeva tutto, e probabilmente gli aveva pulito la bocca così tante volte che Mark non aveva mai imparato a farlo da solo. Quella particolare inettitudine del marito, unita a una certa indifferenza verso gli altri – lasciava spesso i boxer sul pavimento del bagno, a pochi centimetri dal cesto della biancheria – le faceva sempre venire in mente la signora Hubbard. Quella vecchia snob, con il suo ingiustificato senso di superiorità, non aveva mai del tutto accettato la nuora americana, e sogghignava, Jean lo sapeva, all’idea che Mark dovesse raccogliersi i vestiti da solo: prova, questa, della pigrizia di sua moglie,o peggio, del suo femminismo pretenzioso.
Così si era ritrovata a incolpare la signora H anche di quella lettera. Benché naturalmente sapesse – mutande, cesto della biancheria e bocca sporca a parte – che la vecchia madre di Mark, con tutti i suoi limiti, non era responsabile di alcun aspetto del loro matrimonio. E mentre brancolava in cerca di una spiegazione, aveva avvertito dentro di sé un cambiamento primario, minerale, che andava oltre la pura delusione. Il giorno era cominciato da poche ore e lei si sentiva già gelare dentro, incapace di fermare il diffondersi dell’infezione. Doveva togliersi quei vestiti ridicoli, allontanarsi dal tavolo, da Mark, rimanere sola.
Jean era corsa dentro mentre Mark tornava in terrazza. «Si può sapere cosa… cara?» aveva detto, aggrottando le sopracciglia, quando lei lo aveva spinto da parte per passare. Dieci minuti dopo, più a suo agio in un prendisole di lino bianco e pronta ad avvicinarsi al tavolo e buttargli la lettera sul piatto, Jean era andata alla finestra e lo aveva visto alzarsi sbadigliando. Il fremito di preoccupazione era passato, a quanto pareva, e Jean aveva esitato. Mark si era rimesso in piedi, attorcigliandosi oziosamente i peli del petto intorno alle dita, si era incamminato con un giornale in mano e, sempre leggendo, era scomparso oltre la porta laterale con almeno altre due copie di “The Week” sottobraccio. Il piano di Jean, insieme a tutto il suo coraggio, era fallito a causa di una cacata mattutina.
Jean non era nuova ai disastri improvvisi, ma nessuna sofferenza precedente poteva aiutarla in quella situazione. La lettera che aveva letto era senza dubbio di un’amante, un pugno nello stomaco che l’aveva lasciata senza fiato. Doveva affrontare Mark immediatamente, quali che fossero le conseguenze. La sua strategia non andava oltre. Era convinta, e i fatti l’avrebbero dimostrato, che il vantaggio derivante dall’autocontrollo non potesse durare a lungo.
Nell’attesa, mentre Mark rimaneva barricato in bagno, Jean aveva disposto davanti a sé un solitario di vecchi inviti, ma non più, come aveva fatto altre volte, per tastare il livido della nostalgia di casa. Questa volta si trattava di una vera prova di pazienza.
Fino a quel momento, il rito della posta era stato un sollievo. La assolveva brevemente dal suo fallimento nel campo dell’amministrazione domestica, dalla sua eterna allergia ad affrontare ogni genere di richiesta. Non poteva essere colpa sua, nel bel mezzo dell’Oceano Indiano, se la corrispondenza rimaneva inevasa. Da quando sua figlia era nata, Jean era sempre stata oppressa da quelle comunicazioni superflue, che adesso le sembravano così innocenti: il modulo da firmare per il lavoro volontario in biblioteca, la fiera primaverile, la giornata di beneficenza, gli sgargianti inviti di compleanno con lo spazio bianco per la risposta da ritagliare e spedire (ma qualcuno la spediva davvero?), il buono d’ordine per l’uniforme che Victoria, a undici anni, compilava già da sola.
E Victoria, rimasta a Camden Town a badare alla casa di Albert Street, si occupava ancora della posta. Anche se laggiù, al contrario che a St. Jacques, non salutavano mai il postino: anzi, lo evitavano, il coreano malinconico che portava la posta in macchina eppure riusciva lo stesso a consegnarla bagnata.
Come doveva affrontare quella relazione, e inoltre, come avrebbe reagito Victoria, davanti al definitivo fallimento della madre nel campo dell’amministrazione domestica? Victoria non doveva sapere niente. Jean si sforzò di riportare l’attenzione sulle carte che coprivano la tovaglia azzurra: l’ultimo invio di partecipazioni scadute e offerte irripetibili sembrava dimostrare che, se si aspettava abbastanza a lungo, tutto perdeva importanza. Non bisognava più preoccuparsi di niente. Anche i RSVP più pressanti smettevano presto di essere urgenti. Lo stesso valeva per la lettera di un’amante.
Cose che perdono forza, aveva pensato Jean, come quella busta che aveva perso la colla e necessitava di un pezzo di scotch. Come ogni busta su quell’isola umida. Jean s’interessava al deterioramento in vari settori. Teneva una rubrica di salute: la decadenza era il suo mestiere. Ma fino a quel momento il suo matrimonio era un settore che non aveva mai preso in considerazione.
Erano passati altri dieci minuti, e Mark non si vedeva ancora. I gesti di Jean stavano diventando bruschi, nervosi. Si era alzata, aveva coperto la frutta con una cupola di rete, aveva lavato i piatti della colazione, accartocciato e buttato via le stampe pubblicitarie. Avrebbe impiegato un’ora buona per arrivare alla clinica, e doveva sbrigarsi.
«Mark?» aveva chiamato, ben sapendo che era il momento meno opportuno per consultare suo marito, o addirittura affrontarlo. (Era convinto che l’intero chilometro quadrato di terreno intorno al ...