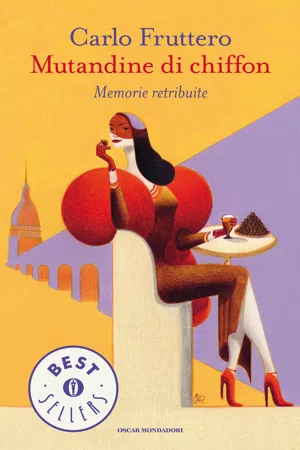![]()
![]()
Mi prendo una specie di rivalsa pensando a come l’ebreo Erich Linder riuscì a gabbare per diversi mesi quei creduloni della Kommandantur di Firenze. Linder era nel mondo editoriale internazionale un personaggio di primo piano, agente letterario amato, odiato, rispettato, ascoltato. Io fui a lungo suo cliente e poi amico, andavo a trovarlo in corso Matteotti 3, alla sede dell’agenzia, e ce ne stavamo a chiacchierare lì o in qualche bar della zona.
Era bilingue, cresciuto se non sbaglio in Austria e poi emigrato a Milano col padre, che vendeva loden e impermeabili viennesi. A vent’anni lavorava a Ivrea nel giro di Adriano Olivetti. Qui lo colse l’8 settembre, mi raccontò un giorno, e nemmeno per un momento pensò che i tedeschi l’avrebbero risparmiato. Bisognava sparire. Un amico gli procurò una carta d’identità vera, rubata al municipio di Strambino, e provvisto di falsi dati il giovane giudeo si rifugiò a Firenze, presso una famiglia sicura. Non ricordo i dettagli e i motivi, so soltanto che a un certo punto Linder venne a sapere che alla Kommandantur della città cercavano un interprete. «Ero giovane, e avevo la sfrontatezza, più che il coraggio, dei giovani» mi spiegò. Sfrontatamente (io direi follemente) si presentò a quei militari e non ho idea di cosa riuscisse a raccontargli circa il suo passato, la sua perfetta padronanza della lingua tedesca. Di sicuro non poteva passare per un contadino eporediese ma la storia che s’inventò non insospettì i suoi datori di lavoro. Fu assunto, con un buon stipendio, e cominciò a lavorare nella gola del lupo. «Sì, avevo paura» mi disse, «ma anche mi divertivo. Il paradosso era eccitante, la sfida, a quell’età, mi pareva irresistibile.»
Lavoratore puntuale e diligente fu presto ben voluto dai “colleghi” in divisa. Aveva molto da fare, fra scambi di prigionieri, arresti contestati, riunioni con intermediari di vario genere. «Non potevo fare molto per dare una mano alla mia gente, di cui si occupava la Gestapo, non la Wehrmacht. Ma insomma, se appena si presentava l’occasione, cercavo di intervenire.»
Giocava a carte, a biliardo, con quei soldati, mangiava alla loro mensa, girava tranquillo per i corridoi del palazzo, e dopo un po’, come succede, la routine rischiò di avere pericolosamente la meglio sulla prudenza. C’erano giorni interi in cui Linder “si dimenticava” di essere un infiltrato in quella trappola mortale, rideva e scherzava spensieratamente con i “padroni”. Solo al gabinetto, per via della circoncisione, doveva stare attentissimo a non scoprirsi.
Un giorno accompagnò il colonnello in una missione fuori Firenze, su una di quelle macchine scoperte che erano l’equivalente tedesco della jeep. Un caccia americano la individuò su una strada di campagna, si abbassò a mitragliare. L’autista perse il controllo, la vetturetta finì in un fosso e Linder fu scaraventato sopra il colonnello. Nessuno ci lasciò la pelle ma il colonnello si convinse che il giovane interprete s’era gettato eroicamente su di lui per salvargli la vita e lo voleva proporre per la croce di ferro. Sarebbe stato il trionfo della finzione romanzesca, ma era troppo anche per lo spavaldo giovanotto, che non senza difficoltà trovò modo di rifiutare l’ambita onorificenza (la prediletta da Hitler).
Quando nel maggio del 1944 gli alleati si stavano avvicinando a Roma, Linder escogitò un pretesto burocratico per fare un salto nella capitale. La sera prima della partenza, un ufficiale, salutandolo, gli chiese di portare i suoi saluti a un noto scrittore antifascista, se per caso l’avesse visto. Si guardarono, tutti e due sorrisero, si strinsero la mano senza una parola e Linder partì, raggiunse fortunosamente Roma e la sua temeraria avventura ebbe fine. «No» mi disse, «oggi non lo rifarei, non ne sarei capace, non è questione di nervi d’acciaio e simili, ma di irresponsabilità giovanile, d’incoscienza. E del gusto infantile di fare marameo alla Wehrmacht.»
![]()
Feci la conoscenza di Italo Calvino una sessantina di anni fa al primo piano di palazzo Campana, davanti a una bacheca gremita di avvisi. Il palazzo nero, tristissimo, era stato sede del fascio locale e adesso ospitava la facoltà di Lettere dell’Università di Torino. Ci presentò un comune amico che passava di lì e che se ne andò poco dopo. Calvino mi disse che stava preparando la tesi (su Conrad) e poi bruscamente, come per troncare sul nascere ogni chiacchierata letteraria, mi chiese se ero comunista. Gli dissi di no. Allora azionista? Nemmeno.
A quel tempo i partiti politici uscivano dalla clandestinità e dal silenzio e si sforzavano di presentarsi e spiegarsi agli italiani coi modesti media di allora, di cui il comizio era, se non il più efficace, certo il più divertente. Andare un po’ in giro a sentire quegli ignoti oratori da una piazza all’altra, da un teatro a un cinema di periferia, non sembrava il peggior modo per passare un pomeriggio o una sera. Le formule, gli slogan, le frasi fatte, i luoghi comuni della politica non avevano quel suono frusto che dovevano in seguito renderli intollerabili all’orecchio umano, tutto appariva meravigliosamente fresco, curioso, degno di attenzione. Cosa volevano i socialisti? Che raccontavano i liberali? Chi erano i qualunquisti? Dissi a Calvino che io andavo piuttosto a sentire i comizi degli anarchici, per aver letto durante lo sfollamento L’unico di Max Stirner, testo atto a promuovere l’egocentrismo di un giovane ex balilla poco incline, dopo tante adunate e sfilate, a nuovi intruppamenti. Calvino, che non doveva conoscerlo, lasciò cadere e se ne andò con un vago, forse condiscendente borbottio.
Molte altre cose ci dividevano. Gli anni dal ’42 al ’45 io li avevo passati quasi interamente e quasi tranquillamente in campagna, mere ragioni anagrafiche avendomi risparmiato il servizio militare prima, e dopo il richiamo tra le file del fascismo repubblicano, vale a dire l’obbligo di una scelta di campo nella guerra oggi detta civile. Calvino era stato partigiano, aveva combattuto sui monti della Liguria, nulla di più naturale che ora ci tenesse a conservare quel caldo cameratismo tra i “compagni” rossi. Non parlammo mai della sua adesione al PCI, né posso dire se davvero in quel periodo si augurasse una rivoluzione e una società di tipo sovietico. Quanto a me, alti concetti come democrazia, libertà, maggioranza, opposizione eccetera, increspavano appena la mia torbida coscienza di autodidatta politico; ma così, a fior di pelle, mi pareva quantomeno inappropriato voler passare da una dittatura a un’altra dittatura, fosse pure stavolta del proletariato.
Questo proletariato era un chiodo fisso degli intellettuali dell’epoca, lettori e chiosatori instancabili di Gramsci, Lenin, Stalin e altri insigni maestri. Come classe aveva molto di mitico, di tantalizzante, un po’ come le ballerine delle Ziegfeld Follies, così vicine sullo schermo sgranato di una terza visione, così lontane nella realtà. Era una classe che deteneva in ogni circostanza e per ogni occasione una sua profonda, istintiva verità, anzi la verità tout court. Bastava saperla interpretare e tradurre in una “linea”, e a tal compito, tra euclideo e non-euclideo, provvedeva appunto il Partito comunista, sudando le sue quattro camicie dal più informale capannello di strada o fabbrica ai rituali dibattiti di “sezione”, su su fino alla direzione romana, pronto ventiquattr’ore su ventiquattro a captare con l’orecchio a terra i segnali affluenti dalle masse.
Una bella macchina, da molti invidiata e imitata, entro la quale il compagno Calvino doveva trovarsi a suo agio, posso immaginare. Scriveva su “L’Unità” e su varie riviste del partito, partecipava a convegni, assemblee, cortei, incontrava dirigenti e luminari, non si tirava mai indietro. Era un intellettuale organico? Uno stalinista? Non ne ho idea, non so con quale spirito abbia vissuto la sua esperienza di militante dal disastro del fronte nel 1948 alla morte di Stalin nel 1953.
Non lo so perché ci eravamo persi di vista, io mi ero gettato proprio in quegli anni in una serie di individualistiche avventure lavorative a Parigi, in Belgio, a Londra, dove avevo avuto a che fare da vicino con gli alberi, mai con la foresta proletaria. Il succo di quelle mie astigmatiche esperienze era che esistevano proletari allegri e spiritosi, altri avarissimi, altri attaccabottoni, altri generosi, altri cupi e depressi; insomma lo stesso identico ventaglio di diversità riscontrabile in qualsiasi Circolo della Caccia o Jockey Club. Non vedevo nessuna differenza (a parte i soldi, talvolta le maniere) tra una marchesa logorroica e un logorroico manovale. Così, senza farci caso, attraverso l’assoluto di Stirner ero arrivato alla massima pluralità democratica. Nessuno era più importante o più trascurabile di nessun altro.
Ripresi i rapporti con Calvino grazie alla casa editrice Einaudi, che finì per assorbire me e le mie velleità di libero vagabondo. Dopo aver errato per diversi uffici distaccati e scrivanie provvisorie fui infine sistemato nella sua stessa stanza, abbastanza grande, ampia, algida. Calvino era piazzato spalle al muro, alla mia destra, faccia alla finestra; mentre il mio tavolo, ad angolo retto rispetto al suo, prendeva da quelle finestre una buona luce da sinistra anche d’inverno. Mi piaceva guardare la neve che veniva giù aggressiva come se ce l’avesse proprio con me. Mi piaceva il verde degli ippocastani, tenerissimo e stillante dopo un temporale a maggio. Lavoravamo chini sui nostri rispettivi dattiloscritti, tra lunghi silenzi e lunghe telefonate, in massima parte di Calvino, che teneva i contatti con un’infinità di gente.
«Aaah» sospirava rimettendo giù la cornetta. «Be’, meno male...» Oppure si lanciava in una breve, esasperata invettiva contro il suo misterioso interlocutore.
Un giorno ormai imprecisabile di un anno imprecisabile (ma c’è un termine ad quem) mi chiese perché non mi iscrivessi al Partito comunista. Era un segno di amicizia e di stima, giacché sarebbe stato eventualmente lui il presentatore, il garante del compagno Fruttero. Ma il compagno Fruttero aveva letto nel frattempo gli scritti di Köstler e di Victor Serge, nonché i romanzi di Ambler, e s’era messo in testa la romantica idea che per fare il comunista ci fosse bisogno di una autentica vocazione, in lui del resto mancante. Quei “rivoluzionari di professione” degli anni eroici avevano costituito una congregazione simile a quella dei Gesuiti, che imponeva ai suoi sceltissimi membri una disponibilità totale, voti di obbedienza e povertà, rinuncia come minimo a tutti gli agi della vita borghese. Se uno non faceva il comunista così, che comunista era? Calvino ridacchiò di quelle ingenue obiezioni. I tempi erano cambiati – minimizzava – il partito non ti chiedeva più un impegno così fanatico, una dedizione così integrale. Ma allora uno poteva – insistevo io – tenersi le giacche inglesi con le pezze di cuoio ai gomiti, aspirare a una potente auto sportiva, bere il suo sherry prima di cena? Come no – diceva Calvino, bonario –, come no. Quella mia visione estremistica, religiosa, non aveva nulla a che fare con un partito ormai di massa, che ai suoi intellettuali chiedeva semplicemente di essere presenti in sezione, e nemmeno sempre. «Te la cavi con qualche riunione noiosa e col carro allegorico del Primo Maggio» mi chiarì, incoraggiante.
Quale carro allegorico? Il carro che la sezione einaudiana apprestava ogni anno per la grande festa del lavoro e sul quale si saliva e si sfilava per il centro della città. Non chiesi se bisognava travestirsi, mettersi costumi da intellettuali, corone d’alloro in testa, levando alta un’enorme stilografica di cartapesta. Ma pensai, non so bene perché, a quando molti anni prima, ai tempi dell’asilo infantile (“Fedeli Compagne di Gesù”, si chiamavano quelle suore francesi), avevo sparso a manciate petali di rose sul cammino del Cardinale Arcivescovo, via via che avanzava per un vialetto del vasto giardino. Tutto fiero del mio cestino, del mio gesto, del mio impegno.
Il telefono di Calvino suonò, qualcuno lo incastrò in una lunga conversazione e il suo affettuoso tentativo di proselitismo, che a ripensarci gli doveva essere costato un certo sforzo, ebbe fine. Non tornammo mai più sull’argomento e a mettere un’ultima pietra sulle nostre giovanili frivolezze venne ben presto il termine ad quem, la rivolta di Budapest nel 1956, dopo la quale non credo ci siano più stati carri allegorici del Primo Maggio.
![]()
Le nostre case in quella pineta sulla costa toscana erano distanti cinque minuti l’una dall’altra, a piedi. Ma c’incontravamo anche nel paese, Castiglione della Pescaia, dove venivamo a volte spediti dalle donne di casa a fare la spesa, in bicicletta. Fu forse qui, ciascuno asimmetricamente appesantito dai suoi sacchetti di plastica, che ci vedemmo in una tarda mattinata d’estate. Italo mi chiese se potevo passare da lui nel pomeriggio, aveva qualcosa da farmi leggere. Quando arrivai a casa sua c’installammo nel prato e lui, un filo più imbarazzato del solito, mi passò il dattiloscritto del Viaggiatore.
Non è che mi considerasse il grande ayatollah della critica, ma voleva un primo parere rudimentale e tuttavia, per uno scrittore, decisivo. Il nostro linguaggio, quando ci capitava (raramente) di parlare di letteratura, era del resto ridotto a poche formule banalissime. «Cammina?», «Prende?», «Sta in piedi?», «Funziona?». Era questo il contributo che contava di poter avere da me dopo gli anni passati nella stessa stanza alla casa editrice Einaudi.
Mentre lui andava e veniva, portava il tè freddo, correva al telefono, tornava a sedersi, mi offriva nervosamente una pesca, io continuavo a leggere col massimo distacco possibile. Leggevo e fumavo. Lui se ne stava zitto, non faceva domande, mi lasciava lavorare. A me scappava ogni tanto un ghignetto, un grugnito. Ma stava in piedi? Sì, stava in piedi. Prendeva? Sì, prendeva, prendeva, bravo, bene. Mi chiese se alla fine dovesse chiudere il cerchio del gioco o lasciarlo aperto. Per me, gli dissi, quel tipo di gioco era meglio chiuderlo. Già, forse, disse Italo raccogliendo i fogli.
Il sole era appena tramontato, i tronchi dei pini intorno a noi erano rosa. Camminammo insieme sull’erba, in silenzio. «E allora grazie» disse Italo. «Figurati» dissi io. Mi accompagnò per un tratto, poi, al primo sentiero verso il mare e verso casa mia ci lasciammo. La stretta di mano non faceva parte delle nostre abitudini. Quando poi Se una notte d’inverno un viaggiatore fu pubblicato me ne arrivò una copia con la dedica: “A Carlo, primo lettore e mentore di questo libro”.
![]()
Onnivoro e casuale, leggo Don Segundo Sombra, un romanzo argentino (1926) di Ricardo Güiraldes. È una storia di iniziazione: un ragazzino ammira i gauchos, riesce a intrufolarsi nel loro mondo, fa la loro vita sotto la protezione del mitico Don Segundo Sombra, impara i fondamenti di quel duro mestiere, che è poi lo stesso dei cowboy nordamericani. Usare il lazo, guidare mandrie per centinaia di chilometri, battersi in duello con compagni aggressivi, bivaccare all’addiaccio, scommettere sui cavalli, rischiare incornate e disarcionamenti, mantenere un atteggiamento stoico di fronte a qualsiasi pericolo. E bere il mate. Ma come sarà mai questo mate che ricorre ogni tre pagine? Mi informo dall’unica persona di nazionalità argentina che conosca, la vedova di Italo Calvino, nata e cresciuta a Buenos Aires. Il suo nome è Esther, ma tutti la chiamano Chichita, un vezzeggiativo che le impose una tata messicana, mi pare, e che poi restò. È una donna piccola, molto lentigginosa, rossa di capelli e con occhi di rara luminosità. Al collo o ai polsi o alle dita porta sempre qualche squisito gioiello vittoriano. Ebrea, poliglotta, lavorò a lungo per l’Unesco, vivendo faticosamente un po’ dappertutto in Europa fino all’incontro con Italo. Insieme a lui si stabilì a Roma, poi a Parigi, poi di nuovo a Roma in un palazzo antico e complicato: tre piani, con tre terrazze lussureggianti affacciate sulla città. Ma d’estate è mia vicina nella pineta toscana in riva al mare dove anch’io ho una casa semi-detached. La sua è invece una vera villa con un gran prato che digrada verso una piscina incorniciata da ampie distese di cotto, un cotto specialissimo, cercato a lungo fra mille altri cotti e infine scelto e sistemato. Così è Chichita: esige sempre il meglio assoluto, dal ferro da stiro al cespuglio ornamentale, dalla sedia a sdraio al biscotto di Fortnum & Mason. Tipico vizio argentino, ammette lei stessa ridendo (ma intanto ti porge un cuscino da spiaggia che fabbricano in pochi esemplari soltanto a Lucca o sulla costa del Maine). Dopo la morte di Italo mi considerò per anni il suo migliore amico, cosa, si comprenderà, non poco lusinghiera. Lo ripeteva a destra e a sinistra, «È il mio migliore amico», e io mi sentivo come una composta di frutta accessibile esclusivamente ai radi abitanti di una valle dell’Auvergne. Mi passava romanzi polizieschi e non, di cui è sempre fornitissima per via di un network sterminato di informatori internazionali; e mi invitava a casa a vedere cassette di film che m’erano sfuggiti, Full Metal Jacket, per esempio, o musical del 1934 in cui appariva in una parte minore Eddie Cantor, di cui Borges aveva scritto una breve recensione.
Una notte mi telefonò ironicamente disperata. Era sola, stava malissimo, non sapeva che fare. Corsi a casa sua e, con un’amica comune convocata anche lei d’urgenza, cominciammo a parlare del 118. Ma la cocciutaggine di Chichita è leggendaria. Si sentiva sempre peggi...