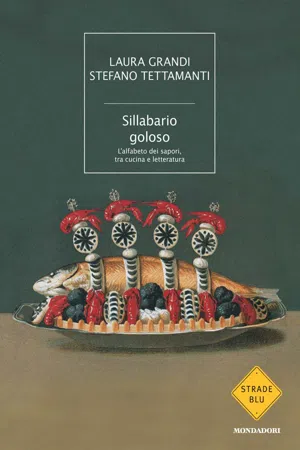![]()
![]()
MENU
Nello schema vincente di P.G. Wodehouse (applicato con successo per dodici romanzi e un’infinità di racconti, nell’arco di una parabola quasi sessantennale, dal 1917, anno d’esordio del personaggio in L’uomo dai due piedi sinistri, al 1974, ultima sua apparizione in Le zie non sono gentiluomini), Bertrand (Bertie) Wooster, gentiluomo inglese, ricchissimo e idiota, viene regolarmente cavato dai guai nei quali si infila con pervicacia dalle abili manovre del valletto personale Jeeves, uomo diabolicamente intelligente e mostruosamente colto. I piaceri della tavola giocano un ruolo non marginale nella inutile vita da perdigiorno di Bertie Wooster, di poco inferiore a quello delle vicende di cuore, e la strabiliante cucina di Anatole, cuoco francese al servizio dell’amata zia Dahlia Travers, è un approdo sicuro in cui appagare i più profondi desideri golosi. Nel Codice dei Wooster (in italiano anche tradotto come Jeeves non si smentisce), del 1939, Bertie, ingiustamente accusato di aver rubato una lattiera d’argento a forma di mucca, rischia di vedersi condannato a trenta giorni di carcere e accetta con stoica determinazione di andare incontro alla pena solo in virtù del pensiero della cena sontuosa, “destinata a vivere per sempre nelle leggende e nelle canzoni”, che Anatole avrebbe preparato in suo onore al momento del rilascio. Il menu, buttato giù in quattro e quattr’otto da Bertie con la complicità di zia Dahlia, è il più mirabolante della storia della letteratura, non c’è Babette che tenga. Ovviamente, come ogni menu che si rispetti, è redatto in francese e, altrettanto ovviamente, non può essere tradotto. Nessuna altra lingua renderebbe giustizia alla sua capacità di evocare scenari paradisiaci. Purtroppo per Bertie, Jeeves riuscirà in extremis, grazie a uno spregiudicato ricatto, a scongiurare la gattabuia al suo padrone, e Anatole non sarà chiamato ad allestire il menu da sogno anche nella forma. Così non rimane che leggerlo:
Caviar Frais
Cantaloupe
Consommé aux Pommes d’Amour
Sylphides à la Crème d’Ecrevisses
Nonats de la Méditerranée au Fenouil
Selle d’Agneau aux Laitiers à la Grecque
Mignonettes de Poulet Petit Duc
Points d’Asperges à la Mistinguett
Suprême de Foie Gras au Champagne
Neige aux Perles des Alpes
Timbale de Ris de Veau Toulousaine
Salade d’Endive et de Céleri
Le Plum Pudding
L’Etoile au Berger
Benedictins Blancs
Bombe Nero
Friandises
Diablotin
Fruits
P.G. Wodehouse, Il codice dei Wooster, trad. it. di Giovanni Viganò, Polillo.
LOCANDA
Ci sono attese e attese. I lettori dovettero aspettare decenni per godersi Il capitan Fracassa di Théophile Gautier, la cui imminente pubblicazione fu annunciata una prima volta, cui seguirono molte altre, nel 1836. Il romanzo iniziò a venire alla luce a puntate soltanto nel 1861 e in volume apparve nel 1863. Trent’anni, ma un’attesa ricompensata dalla lettura. Non capita di essere così soddisfatti quando si va al ristorante per mangiare un certo piatto e per ragioni non sempre “di mercato” non lo si trova sul menu. Ancor peggio può andare di fronte a liste virtuali di prelibatezze enunciate da sedicenti cuochi che però non invitano mai a cena. Per questo è del tutto comprensibile la delusione dell’amena combriccola che nel Capitan Fracassa entra affamata alla Locanda del sole turchino, osteria con alloggio, dove viene accolta da mastro Chirriguirri, il quale garantisce che la sua casa “è provvista di tutto ciò che a gentiluomini si conviene. Peccato che non siate arrivati ieri! Avevo preparato una coppa di cignale ai pistacchi, così deliziosa di profumo, così steccata di spezie, così delicata di sapore che, purtroppo, non ne è rimasta neppure la punta di un dente”. Stessa sorte toccata al pasticcio di selvaggina, di cui gli ospiti del mattino hanno fatto fuori anche la crosta. Alla fine i commensali si devono accontentare di stoccafisso e di una garbure preparata, secondo il non attendibile Chirriguirri, con “croste di pane fritte a fuoco lento nel grasso d’oca più fino, cavoli all’ambrosia che migliori non ne generò mai Milano e cotti con un lardo più bianco della neve”.
Nei cavoli all’ambrosia si coglie un’allusione alle verze tanto care alla cucina milanese, che le inserisce in vari piatti, dalla
casoeula in poi. La
garbure invece è tipica della Francia sudoccidentale, della Guascogna – la regione della Locanda del sole turchino – e si può preparare così: (
) si pongono 300 g di fagioli bianchi in una pentola capiente con 500 g di prosciutto crudo oppure pancetta, 1,2 l d’acqua circa, 1 mazzetto guarnito, 2 cipolle e 2 spicchi d’aglio tritati; si copre, si porta a bollore e si lascia sobbollire per 90 minuti; si uniscono quindi 350 g di patate sbucciate e tagliate a pezzetti, 200 g di verza, 2 cucchiai da minestra di confit d’oie, 200 g di fave sgusciate, e si lascia sobbollire per altri 40 minuti. Si controlla e si aggiusta di sale se necessario, si cosparge di pepe a piacere. Si serve versandola su dadini di pane sistemati nei piatti, cospargendoli di formaggio, ad esempio Roquefort.
La garbure è un robusto piatto popolare, di cui esistono infinite varianti che gli ospiti della locanda ottengono perché il Pedante invita mastro Chirriguirri a non “acuirci crudelmente l’appetito con piatti fantastici ormai digeriti [...] piatti defunti della cui succulenza non si può dubitare, ma che non ci potrebbero più sostentare, snocciolateci i piatti del giorno, perché l’aoristo è noioso soprattutto in cucina, mentre la fame a tavola ama l’indicativo presente”.
Théophile Gautier, Il capitan Fracassa, trad. it. di Giuseppe Lipparini, Mondadori.
SPAGHETTI ALLA CHITARRA
È il 30 luglio 1960. Sul “Giorno” di Milano – il quotidiano un tempo proprietà dell’editore Cino Del Duca e da poco ufficialmente dell’ENI di Enrico Mattei, dell’IRI e del ministero delle Partecipazioni statali, dunque interamente dello Stato italiano, e da qualche mese passato dalla direzione di Gaetano Baldacci a quella di Italo Pietra, ma ancora pur sempre, e per anni a venire, il quotidiano di Alberto Arbasino e Luciano Bianciardi, di Pietro Citati e Umberto Eco, di Pier Paolo Pasolini e Antonio Cederna, di Gianni Brera e Carlo Cassola, di Ottiero Ottieri e Mario Soldati e praticamente di chiunque altro scrivesse (bene) in quegli anni in Italia –, dunque sul “Giorno”, il 30 luglio 1960, esce un pezzullo di colore estivo dalla riviera ligure.
“Il golf di Rapallo è il ‘rilassatoio’ preferito dagli ‘sci-sci’ del Tigullio. Farsi trentasei buche senza accanimento e senza preoccuparsi troppo del numero di colpi è uno dei sistemi più efficaci per distendere i nervi e disintossicarsi delle fatiche accumulate in città. Uno dei più assidui frequentatori del golf rapallese è il commendator Piero Saltamerenda, imparentato, per via di moglie, coi marchesi Incisa di Camerana. Giorni fa, mentre mulinava la mazza sulla buca numero 12, un altro giocatore di mezza età, Guido Paneperso, commendatore anche lui, stava preparandosi a entrare in campo. ‘Paneperso e Saltamerenda’ osservò meditabondo un terzo golf-man. ‘Bei cognomi, non c’è dubbio, ma poco nutrienti.’”
La firma del pezzullo è di Gian Carlo Fusco, il più scentrato di tutti gli eccentrici, il più dispari dei giornalisti del “Giorno”, ma anche uno dei più originali scrittori italiani del Novecento. Le modeste proprietà nutritive dei cumenda Saltamerenda e Paneperso, estenuati nel loro sci-sci rapallino, rimandano, per contrasto, a più robusti appetiti, vellicati una trentina di anni prima, sarà stato il 1925 o 1926, nell’imberbe Fusco (aveva sì e no undici anni e a quell’età neanche ai duri più duri cresce la barba) niente meno che da Gabriele D’Annunzio. Il padre di Gian Carlo, Carlo, ufficiale di Marina, è fra i prescelti per far parte della squadra che consegnerà al Vate un cimelio ambitissimo, la prora dell’ariete torpediniere Puglia dove, nel 1920, a Spalato, era stato ucciso l’eroico comandante Tommaso Gulli. Fusco senior, che nutre per D’Annunzio una sorta di venerazione letteraria, ottiene per Giancarlino il privilegio di far parte del manipolo in spedizione alla volta del Vittoriale, perché dice, sarebbe stato un delitto perdere l’occasione per fargli vedere da vicino l’ultimo dei Grandi Italiani. E così, agghindato con un vestito alla marinara bianco, completo di berretto con la scritta “Regia Nave Dante Alighieri”, la testa colma dei versi del sonetto O giovinezza, mandata a memoria nel caso all’Imaginifico fosse venuto in mente di chiedergli di recitare qualcosa di suo, e vuota dei boccoli biondi eliminati in favore di un maschio taglio all’umberta, Fusco junior, mascotte della spedizione, raggiunge in treno, via Spezia-Genova-Milano-Brescia e poi a bordo di una grande automobile scura, la “Priorìa”, l’abitazione “vera e propria del Filibustiere del Quarnaro”. Dal momento in cui lo vede, per il Vate il piccolo Fusco è per sempre “il nostro giovanissimo nostromo biondo e bianco” e per lui avrà le più delicate attenzioni, prima durante il giro turistico nelle magnificenze del Vittoriale e quindi, preceduti dai “fidi uscocchi” del Poeta Soldato, alla fLocanda, per il desinare. Nel ricordo di Fusco quella dove i marinai liguri vengono fatti accomodare “non era una tavola da pranzo [...]. Era una specie di altare, sul quale piatti e posate occupavano il minimo dello spazio indispensabile, in mezzo a una selva di cimeli e oggetti dal misterioso significato. Schegge d’elica, statuette di bronzo e d’argento, calici ecclesiastici, brandelli di damasco, di raso e di broccato, pugnali di tutte le fogge, caschi da aviatore, una decina fra oriflamma, gagliardetti e drappelle, fiale di cristallo colorato, un nastro da mitragliatrice con tutti i proiettili...”. Un “briccabracche” da togliere il fiato per l’emozione. Ma le sorprese non sono finite: D’Annunzio, che ha voluto il piccolo nostromo accanto a sé, con una carezza gli annuncia che le sue “fedeli clarisse” stanno per servire la cena.
“Due donne dai capelli corvini, lunghi sulle spalle, che recavano ognuna un vassoio di metallo dorato (che fosse proprio oro?) colmo di pastasciutta fumante. Nonostante l’appellativo di ‘clarisse’ riferito alle monache di Santa Chiara, le due donne indossavano corte tunichette trasparentissime, sotto le quali erano completamente nude. Così che lasciavano intravedere, nettissimo, folto e tenebroso, il ‘bosco d’amore’ che faceva chiazza sotto l’addome. Era la prima volta che i miei occhi si posavano sull’angolo ferino di Venere. Talmente ferino, nelle due ancelle del Vate, che andavano servendo la pastasciutta sorridenti e disinvolte, da procurarmi non solo stupore, ma addirittura spavento. Cos’erano quelle macchie? Una malattia? Due micini neri accovacciati al calduccio? Un segno di lutto insolito? Quando Suora Pecchia (seppi in seguito che si chiamava così) arrivò ad empirmi il piatto, i miei occhi le restarono inchiodati sulla selva del pube. Mentre tutti gli occhi dei commensali erano fissi su di me.”
L’imbarazzo degli astanti, in particolare del padre del giovane nostromo, non sfugge alle sensibili antenne dell’Orbo Veggente che, per deviare ...