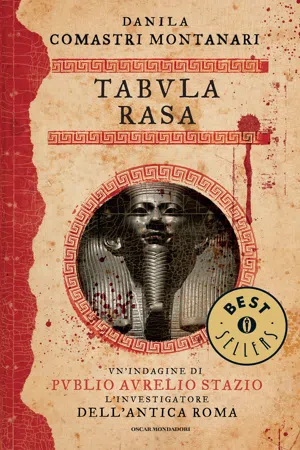![]()
Alessandria. Residenza di Publio Aurelio.
Il mattino dopo Aurelio si fiondò nel quartiere servile della sua residenza alessandrina come il sasso scagliato da un giovane fromboliere che prova entusiasta l’efficacia della sua arma nel primo giorno di arruolamento.
«Dov’è il segretario?» chiese subito. Ferie o non ferie, Castore aveva promesso di restare a disposizione. E comunque negli accordi sul periodo di riposo non era contemplato che forzasse lo scrigno dei preziosi e ne asportasse l’antichissimo rubino intagliato, identico in tutto e per tutto a quello dell’anello che Aurelio portava all’indice. Verificandone la mancanza, il patrizio aveva avvertito un forte pizzicore tra le scapole, foriero di guai senza fine: l’ultima volta che l’infido levantino gli aveva sottratto il sigillo, era stato per tentare di vendere il Circo Massimo a un ingenuo nababbo orientale...
«Trovatemi immediatamente quel farabutto, quel lestofante, quel ciurmatore!» tuonò il patrizio.
Memnone, il più giovane dei nubiani, si fece piccolo piccolo: i rapporti tra il senatore e il suo disinvolto liberto greco erano spesso tesi, e senza dubbio il dominus aveva le sue ragioni di arrabbiarsi, perché Castore poteva a volte rivelarsi irritante con le sue continue richieste di denaro o col vezzo di invitare nel suo cubicolo le ancelle della casa sul Viminale a tre alla volta, senza contare che non era stato del tutto rispettoso quando, attingendo alla cantina padronale, si era scolato tutte le preziosissime anfore imbottigliate più di cent’anni prima ai tempi del console Opimio, in quella che era stata la migliore annata da vino di tutta la storia dell’Urbe. Certo, faceva la cresta sulla spesa, ma quale servo non coltivava lo stesso vizietto? Era solo questione di proporzioni e il segretario, da uomo di qualità quale era, pensava alla grande, in aurei anziché in assi o sesterzi...
«Voglio quello sciagurato!» insistette il senatore.
Gli otto fratelli nubiani si schermirono. Non vedevano il segretario da tre giorni, in quanto trascorrevano ogni ora libera a far visita a miriadi di parenti, di molti dei quali avevano ignorato per anni l’esistenza. Nel lontano villaggio meridionale di cui era originaria la famiglia infatti, spiegò Memnone, vigeva ancora la poligamia, e l’attività preferita del loro padre comune era stata quella di stringere numerosi legami matrimoniali, tutti molto fecondi. Avevano così appreso di avere ben undici sorelle, a loro volta molto prolifiche, nonché una trentina di nipoti in tenera età: naturalmente ognuno di questi vivaci pargoletti agognava di udire notizie della capitale dalla viva voce di quegli zii che gli Dei avevano favorito a tal punto da destinarli come schiavi a un padrone di Roma buono, generoso e favolosamente ricco.
Qui Memnone si interruppe, abbassando modestamente il capo e il patrizio alzò gli occhi al cielo, ben sapendo dove sarebbe andato a parare il discorso: poteva un magnanimo nobiluomo dell’Urbe negare a quei simpatici fanciulli un segno tangibile del suo favore e della sua grandezza d’animo?
«Eccovi due aurei da distribuire al vostro parentado: nei quartieri poveri di Alessandria equivalgono a una fortuna!» stabilì, certo che tra quei trenta nipoti improvvisati ve ne fossero parecchi fasulli. «E adesso mandatemi Nefer, lei saprà senza dubbio dove cercare Castore.»
«Non è in casa, domine!» annunciò Memnone. «Un suo innamorato, tal Pandione, è passato a prelevarla in portantina per condurla a passeggio nei giardini!»
Nefer aveva uno spasimante?, pensò il patrizio sconcertato. La massaggiatrice per lui era molto più di una schiava, costituiva una presenza costante nella sua casa, un’abitudine consolidata, una certezza che non riteneva sarebbe mai stata messa in discussione. Non gli era mai passata per la testa l’idea di darle la libertà, credeva che non ne sentisse il bisogno, appagata delle ricche vesti capaci di fare invidia a molte matrone, dei ninnoli preziosi che di tanto in tanto le donava, della posizione privilegiata di cui godeva tra i domestici come ancella addetta alla persona del dominus. Ed ecco ora che la fedelissima ancella trovava un pretendente disposto a mandarla a prendere in lettiga, a onorarla come una donna libera, a farne presumibilmente la sua concubina ufficiale. Sciocchezze, alzò le spalle il senatore, si trattava solo di un capriccio. Nefer non avrebbe mai accettato di lasciare Roma e la sua grande domus sul Viminale...
«Credo di sapere dove si è diretto il segretario» intervenne a quel punto – e del tutto inopinatamente – il più grosso ma anche il più tardo dei nubiani, incurante dei calci che l’accorto fratello minore stava mollandogli negli stinchi. «L’ho sentito decantare i pregi di un locale del porto di Faro intitolato alla “Vacca Celeste”, che ha fama di ospitare meretrici particolarmente disinibite.»
«È proprio il tipo di bettola che piace a Castore! Soltanto i Numi sanno che cosa potrebbe combinare usando il mio sigillo in un posto simile!» storse la bocca Aurelio.
«Dobbiamo andare a cercarlo?» si offrì subito con l’intenzione di scongiurare il peggio il bravo Memnone, memore delle infinite volte in cui il segretario gli aveva offerto da bere con i soldi sottratti al padrone.
«Lo farò personalmente: intendo spellarlo vivo e non è un piacere che voglia delegare ad altri!» annunciò il patrizio con un grugnito mentre prendeva la porta.
Alessandria. Isola di Faro.
Aurelio imboccò il lungo molo dell’Heptastadion, evitando il centro della città, da cui provenivano grida e clamori: una processione isiaca particolarmente fervida, suppose, un corteo al tempio o una di quelle feste popolari a base di vino a cui spesso indulgevano gli alessandrini con la scusa di onorare qualche divinità greca o egizia.
Davanti a lui apparve l’isola. Il Faro si ergeva immenso sorgendo dalle acque come un gigante superbo. All’alto basamento quadrangolare erano sovrapposte una torre a otto lati, quindi una costruzione cilindrica e infine una statua colossale, che alcuni dicevano di Zeus, altri di Poseidone signore del mare, altri ancora di Helios, Dio del Sole.
L’isola consisteva in una sequenza pressoché infinita di magazzini, depositi e taverne. Trovare il locale scelto da Castore, ubicato dietro il tempio di Iside Faria, fu più facile del previsto, perché tutti lo raccomandavano come uno dei migliori postriboli della città per l’ottimo rapporto tra qualità e prezzo: le pensionanti della “Vacca Celeste” non erano proprio di primo pelo, ma avevano fama di supplire alla giovinezza perduta con un grande bagaglio di esperienza e una lussuria talmente invereconda da far risorgere persino mummie sepolte e imbalsamate da un pezzo. E oltretutto costavano il giusto.
La bettola segnalava la sua presenza con un frastuono caotico già a parecchie pertiche di distanza. Aurelio si diresse verso la fonte del baccano e finì per fermarsi davanti a un portone a due battenti, da cui emanava un forte odore di liquidi fermentati. Esitò soltanto un attimo sotto l’insegna coloratissima che mostrava la divina vacca con il Dio Ra tra le sue corna, per soffregarsi le nocche delle mani: la sua pazienza aveva un limite e stavolta il segretario non l’avrebbe passata liscia.
Spalancata la porta credette per un attimo di essere precipitato tra le creature primordiali e mostruose che popolavano gli Inferi egiziani: al centro della sala si snodava un viluppo di corpi seminudi, mentre timpani assordanti, grida inconsulte, urla, canti e strepiti accompagnavano i contorcimenti di una figura maschile alla quale erano avvinghiate una dozzina di prostitute visibilmente ubriache. Un solo dettaglio pareva del tutto incongruo alla scena: l’eleganza sofisticata del personaggio centrale attorno a cui ruotava l’orrida bolgia, che, per quel poco che si riusciva a scorgere sotto il groviglio di seni, cosce e deretani abbondantemente esposti, esibiva una finissima veste color sabbia ricamata d’oro.
Il patrizio sentì il sangue andargli alla testa nel riconoscere la tunica che si era fatta confezionare apposta per sfoggiarla in occasione del genetliaco dell’anziano Princeps Senatus, la cui giovane moglie cercava spesso conforto e comprensione tra le sue braccia.
«Castore!» tuonò, ma per quanto imperioso fosse il suo tono, quasi non si udì nel bailamme generale.
Un istante dopo Aurelio si tuffava nel cuore dell’orgia, scostava bruscamente le femmine scalpitanti e afferrava il segretario per la collottola, trascinandolo via a rischio di strozzarlo.
I tamburi tacquero all’improvviso e le voci si spensero a una a una, ultima quella di una porné piuttosto avanti negli anni che protestava risentita: «Per Ercole, come si permette di interrompere il nostro festino questo maledetto guastafeste? Che i buttafuori lo gettino immediatamente a pedate in un rigagnolo della strada!».
«Calma, Buba, le liti dei signori di Roma non sono cose che ci riguardano!» la trattenne il prudente gestore.
Intanto il patrizio scrollava Castore dalla testa ai piedi come se dovesse montare un tuorlo d’uovo, lo ribaltava a testa in giù e riprendeva a scuoterlo vigorosamente, per estrarvi con rapidità tutto ciò che si portava addosso.
Dai recessi della tunica caddero a terra gli astragali truccati, parecchie monete, un ciondolo rotto e infine il sospirato sigillo.
Quando il patrizio si inginocchiò per riappropriarsene, quasi andò a sbattere contro la testa di Buba, che, chinatasi a sua volta, stava protendendo gli artigli verso il pendente spezzato a metà.
La matura meretrice osservò il frammento, se lo rigirò tra le dita e lo fissò ancora, a bocca aperta. Raffigurava un bambinello, notò il senatore mentre metteva al sicuro il sigillo, presumibilmente Serapide o Arpocrate, o comunque si chiamasse in quel momento il figlioletto della santa madre Iside, la cui immagine doveva comparire nella parte mancante.
Silenziosamente Buba si palpò le vesti alquanto stazzonate, pescò con le dita adunche all’interno della fascia mammillare, ne trasse un ciondolo spezzato e lo accostò a quello caduto dalle vesti del segretario.
I frammenti combaciavano perfettamente.
«Per tutti i Numi!» biascicò la donna esterrefatta.
«Mamma!» mormorò Castore incredulo, prima di collassare esanime sul pavimento.
Alessandria. Tempio di Bast.
E così Castore, che si sarebbe detto nato per partenogenesi dallo scaltro Hermes protettore dei ladri, era nato anche lui da una normalissima donna, sempre che normale si potesse definire una porné celebre soprattutto per essere riuscita a soddisfare ben ottantasei clienti nell’arco di una sola giornata. Il mito che lo scaltro segretario si era abilmente costruito per ammantare di leggenda le sue origini stava dunque per essere sfatato?, si chiedeva Publio Aurelio lasciandosi alle spalle l’isola di Faro per imboccare il lungo molo dell’Heptastadion. L’inemendabile furfante, che pareva incarnare l’astuzia e la spregiudicatezza del leggendario Odisseo, si sarebbe presto trasformato in un figlio devoto e casalingo? La ruota del Fato girava senza sosta, rifletté, nulla era eterno, tutto cambiava incessantemente, persino il segretario, che era sembrato immutabile come le rocce nebbiose del monte Olimpo...
Intanto però Castore, con la scusa del commovente ricongiungimento, aveva salvato per l’ennesima volta la schiena dalla sferza: per sottoporlo alla meritatissima bastonatura il patrizio avrebbe dovuto rompere l’incanto del toccante quadretto familiare, e non se l’era sentita. Così aveva deciso di andarsene in sordina dopo il recupero del prezioso sigillo, lasciando madre e figlio, scossi per la fortunosa quanto imprevista agnizione, a superare l’emozione dello storico momento con numerose anfore di vino da addebitarsi sul suo conto.
«È vicino il tempio di Bast?» chiese a una popolana sommersa da un grappolo di mocciosi, e subito una decina di mani tese misero in chiaro che, per un ricco patrizio della potente capitale del mondo, anche una semplice informazione era suscettibile di essere monetizzata. Il più svelto dei bambini propose anche di accompagnarlo di persona nei meandri del quartiere egizio di Alessandria, ma il patrizio declinò cortesemente l’offerta, prevedendo che il monello lo avrebbe costretto a girare parecchie volte in tondo, in modo da accrescere sensibilmente il percorso e la conseguente mancia.
Il santuario infatti si trovava a pochi passi. Era un edificio circondato da un basso muretto, non troppo imponente ma perfettamente consono al vecchio stile dei templi tradizionali, col porticato sgargiante di colonne multicolori, al cui centro svettava un edificio di mattoni, coloratissimo anche quello, dove campeggiava l’immagine di una donna dalla testa felina.
Appena varcato l’ingresso, il patrizio avvertì un odore acre e pungente. Non occorreva un’inchiesta accurata per capire da dove provenisse, dato che il cortile brulicava di gatte, parecchie delle quali erano intente a marcare il territorio scaricando la vescica sulle colonne istoriate per attirare l’attenzione dei maschi.
Valicare l’ampio spiazzo prospiciente la cella del tempio fu un’impresa titanica: le bestiole, che da lontano erano apparse miti e socievoli, a un contatto più ravvicinato si rivelarono oltremodo moleste, avverse com’erano – forse per eccesso di orgoglio patriottico – alle stringhe dei calzari romani, alle falde della tunica romana e soprattutto ai romanissimi polpacci del senatore, che in breve se ne trovò miriadi abbarbicate addosso.
Quando, all’ennesimo graffio, Aurelio tentò di liberarsi almeno della più aggressiva, una miciona guercia dalle poppe pendule che doveva aver allattato legioni di cuccioli, venne aspramente redarguito da una voce arcigna.
«Un po’ di delicatezza, suvvia! Le gatte sacre a Bast vanno trattate con il massimo rispetto!» esclamò severo il guardiano e, nuotando abilmente nella marea felina, si affrettò a soccorrere non certo Aurelio, le cui gambe nude erano già solcate da un reticolo di unghiate, bensì la subdola bestia che, forte dell’autorevole sostegno, affondò con forza i denti nella caviglia del senatore, gratificando il suo difensore dello stesso sguardo di adorante riconoscenza con cui gli imputati colpevoli sono soliti premiare gli avvocati abili a farli assolvere.
«Sei tu il sacerdote?» chiese il patrizio senza nascondere la delusione: si era aspettato che a servire la Dea Gatta fosse una schiera di giovani silfidi dagli occhi immensi, le labbra carnose e il piccolo seno appuntito sommariamente avvolto in lini trasparenti, come tante ne aveva viste negli affreschi antichi. Invece si ritrovava alla presenza di un uomo anziano e scontroso, con una lunga barba bianchiccia piuttosto sporca e fattezze che non parevano per nulla egizie.
«Vattene, il tempio è ancora chiuso, nessuno ha il permesso di accedervi!» fu la scorbutica accoglienza.
«Peccato! Ero venuto per una donazione...» deplorò il senatore, certo che in Egitto le cose funzionassero come nell’Urbe e nel resto del mondo. Immediatamente infatti la boc...