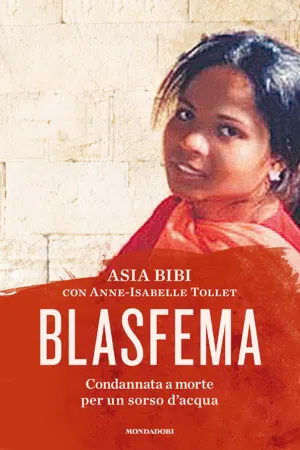![]()
Oggi non è il giorno della visita di Ashiq, ma stamani mi sento meno affannata del solito. Durante la sua ultima ronda, ieri sera, Khalil ha gridato: «Farai bene a startene tranquilla nei prossimi tre giorni, con Zenobia, altrimenti lo verrò a sapere e al mio ritorno saranno dolori!».
Khalil non mi lascia mai in pace, non riesce a non infierire, a non cercare di impaurirmi in tutti i modi. Più di una volta ci è riuscito, ma con il tempo credo di essere diventata più forte. Le sue vessazioni mi toccano molto meno che in passato. A volte mi sono persino utili. Tra me e me sorrido: Khalil detesterebbe l’idea di rendermi questo servizio, ma grazie a lui so che stamani è sabato, il giorno in cui cambia la mia guardia. Da quando mi hanno messa in carcere ho avuto ben pochi momenti di respiro e ben poche occasioni di provare le gioie più semplici. Così sono felice di potermi sbarazzare per tre giorni di quel caprone di Khalil. Delle sei guardie che mi sono assegnate, la maggior parte sono indifferenti o gentili, come Zenobia, l’unica donna. Khalil invece fa di tutto per rendermi la vita ancora più penosa, come se non lo fosse già abbastanza.
Oggi, dunque, è il turno di servizio di Zenobia. Sarà lei a sorvegliarmi per tutto il fine settimana. La mia cella non ha finestre e sono ormai tre mesi che non vedo il sole. Dopo l’assassinio del governatore mi hanno cambiato posto e vivo in totale isolamento nell’ala sinistra del penitenziario. Per fortuna c’è Zenobia, che porta un po’ di calore e un po’ di luce alla mia esistenza sotterranea.
Da quando sono in isolamento, non esco mai dalla cella e nessuno è autorizzato a entrare per pulirla. Perciò devo provvedere da sola. Ma come? La prigione non mi dà nessun prodotto per la pulizia. Nella piccola cella, che misurerà tre metri per due, proprio accanto al letto c’è quella che Khalil, per deridermi, chiama la «stanza da bagno». In realtà consiste in un tubo dell’acqua che sporge dal muro e un buco nel terreno. Ma il buco non è molto profondo e non va a finire da nessuna parte, e io non ho niente per coprire i miei escrementi. Nessun essere umano può vivere in queste condizioni, nemmeno una contadina come me. L’odore e la vista sono insopportabili. Ogni giorno cerco dentro di me la forza di resistere, mi batto per conservare ancora un po’ di dignità. In questo Zenobia mi è di grande aiuto. Quando ha l’incarico di sorvegliarmi, mi dà dei sacchetti di plastica e una piccola cazzuola, con cui posso rimuovere tutta quella sporcizia. Se non ci fosse Zenobia, vivrei in un letamaio.
Nel carcere femminile non ci sono uniformi. Devo arrangiarmi con i vestiti che ho, lavandoli da me. Ma nella mia minuscola cella senza finestre né ventilatore non è facile farli asciugare. Il solo punto in cui posso appenderli è il letto, che è anche il solo posto in cui posso sedermi, se non voglio insozzarmi sedendomi per terra tra la polvere. Durante il giorno, dopo avere ben strizzato la mia veste, la stendo sulla branda di corde, lasciando libero un angolino dove potermi sedere. Ma la notte sono costretta a dormirci sopra, non avendo altri posti in cui appenderla. E siccome nella mia cella fa freddo e c’è umido, mi ritrovo quasi sempre con una salwar kamiz bagnata che finisce di asciugarmisi addosso. Non è affatto piacevole e l’inverno scorso ho avuto freddo tutto il tempo. Adesso va meglio. Siamo all’inizio di marzo e la temperatura è più mite.
Io, Asia Bibi, sono diventata un’appestata e chiunque mi dà il suo aiuto o il suo sostegno è considerato a sua volta un bestemmiatore. Così mi ha detto Khalil. Nella mia nuova cella sono sorvegliata da una videocamera. L’ha imposta al direttore della prigione il ministro per le Minoranze, Shahbaz Bhatti. Prego ogni giorno per quest’uomo, che qualche mese fa ha avuto il coraggio e la bontà di visitarmi, che, come promesso, veglia sulla mia famiglia e si cura persino della mia incolumità in prigione.
Quando sono arrivata in questa cella ancora più angusta della precedente, il 7 gennaio, continuavo a guardare quel piccolo oggetto attaccato a un angolo del soffitto, senza capire a che cosa servisse. Ricordo che qualche giorno più tardi avevo approfittato del turno di guardia di Zenobia per domandarglielo.
«È una videocamera di sorveglianza» mi aveva risposto con la sua esile voce. «Grazie a quella, qui sei più al sicuro.»
La sua risposta non mi aveva chiarito molto le idee.
«Non capisco. Lo guardo spesso quell’oggetto, ma non si muove mai. Come fa a proteggermi? Sembra piuttosto un’arma.»
«È una videocamera che ti riprende in continuazione» mi aveva spiegato Zenobia sorridendo «C’è un cavo collegato a un piccolo schermo che si trova nella sala delle guardie e che mostra tutto quello che succede nella tua cella.»
«Ma allora mi vedono anche quando mi lavo o quando faccio…»
Anche se non avevo voluto terminare la frase, Zenobia aveva capito.
«Sì, con quella videocamera non hai più intimità. Ma se qualcuno vuole ucciderti, non può farlo, perché tutti lo vedrebbero e saprebbero chi è.»
«Ora ho capito. Non mi piace l’idea di essere osservata, ma se è il prezzo da pagare per restare viva, va bene.»
Più tardi il mio avvocato mi ha spiegato che molti detenuti accusati di blasfemia non fanno in tempo ad arrivare in giudizio, perché vengono uccisi nella loro cella prima ancora di potersi presentare al processo.
Adesso mi ci sono abituata e non guardo più la videocamera. Mi capita solo di chiedermi, a volte, se funzioni e se le guardie passino tutto il tempo a osservarmi. Da quando sono rinchiusa qua dentro, soffro terribilmente di non poter conversare e comunicare… Io che, a sentire Ashiq, ero una vera chiacchierina, non parlo più con nessuno da un’eternità. Qui ho imparato che per sopravvivere non basta resistere fisicamente. Non c’è dubbio: parlare, avere dei contatti umani, anche occasionali, impedisce di sprofondare nella follia. Non ci avevo mai pensato. Ma ho scoperto che gli aspetti più comuni della vita in libertà diventano importantissimi nell’avvilente quotidianità del carcere. Avevo sottovalutato tutte le piccole cose che davano un ritmo alle mie giornate, come andare a comprare la farina nella drogheria del villaggio per preparare alla mia famiglia del buon chapati. La mia vita d’un tempo mi manca. Sono così triste che mi sia stata tolta… Mi accorgo che una delle cose più difficili da sopportare nella mia prigionia è non avere nient’altro da fare che girare in tondo nella cella. Prima di essere messa in isolamento avevo diritto all’ora d’aria, mattino e pomeriggio. Ma adesso che – anche questo per la mia sicurezza – non esco più di cella, non vedo più nessuno della prigione, tranne le guardie, e l’occhio sporgente di Khalil. Durante l’ora d’aria non avevo contatti stretti con le altre detenute, ma il semplice fatto di parlare un po’, di vedere altre facce, di sentire le loro storie, mi permetteva di rinfrescare i pensieri, di non avere sotto gli occhi sempre e solo le pareti grigie e sudicie della mia fossa.
Spesso mi chiedo come stiano le mie vecchie vicine di cella. A essere chiuse qua dentro siamo un centinaio scarso di donne, la maggior parte accusate di adulterio. In realtà molte sono state violentate: si tratta quindi di vittime, che però sono considerate colpevoli. Durante l’ora d’aria non eravamo mai più di venti, sicuramente perché il cortile della prigione non è molto grande. Ricordo la giovane Yasmine, che aveva soltanto ventidue anni. Un giorno se ne stava sola a piangere in un angolino, allora io l’avvicinai.
«Cosa c’è che non va? Che ti succede?»
«Sono stata violentata perché mio cognato mi ha accusata di avere una relazione con uno di un’altra tribù. Quando la notizia si è sparsa, mio padre si è rifiutato di consegnarmi e mi ha aiutata a scappare, ma il capotribù mi ha trovata. Mi ha sequestrata e violentata per un anno intero. Quando mi ha liberata, ho partorito un bambino, figlio suo. Poi sono stata messa in prigione.»
«E che ne è stato del bambino?»
«Non lo so. Me l’hanno tolto appena l’ho dato alla luce. Non so nemmeno se era maschio o femmina.»
Una donna anziana che era stata ad ascoltare seduta su un muricciolo disse a Yasmine: «Il tuo bambino è stato certamente ucciso, perché è un figlio della colpa, senza un padre legittimo».
«E mi hanno condannata a molti anni di prigione» aggiunse Yasmine «perché quel bambino era una prova di zina, di adulterio, così ha detto il tribunale.»
Nel mio villaggio avevo sentito terribili storie di vendetta e di stupri, perciò capivo bene la sofferenza della piccola Yasmine.
«Sai se chi ti ha violentato è stato condannato anche lui?»
Al posto di Yasmine rispose decisa la vecchia dagli occhi azzurri e dalla pelle grinzosa: «Nel nostro paese i violentatori non vengono mai toccati: sono protetti dalla legge».
L’anziana sembrava saperla lunga e io le chiesi spiegazioni.
«Era il 1979. Voi non potete ricordarvi della dittatura di Zia ul-Haq, siete troppo giovani. Fu lui, questo generale, a emanare le “ordinanze Hudud”, nuove leggi che trasformavano in criminali tutte le donne che avevano avuto relazioni fuori dal matrimonio. L’adulterio diventava un reato punibile con il carcere o la lapidazione. Sei anni fa questa legge è stata ammorbidita: le donne non vengono più uccise a sassate, ma imprigionate per anni e anni, come te, Yasmine.»
Una donna con il viso coperto da un burqa nero si avvicinò a noi: «Io ho sporto denuncia dopo essere stata brutalmente violentata da due uomini che mi erano entrati in camera mentre dormivo. Mi hanno usata per un regolamento di conti fra due proprietari terrieri che si contendevano la stessa terra».
«È vero» disse la donna dagli occhi azzurri, che sapeva un mucchio di cose. «Nella nostra cultura, soprattutto qui in Punjab, si servono spesso di noi donne per sistemare le dispute tra confinanti o le lotte fra tribù. Quando non ci violentano, ci bruciano con l’acido.»
Mi accorsi che le guardie ci ascoltavano. Non sembravano apprezzare la nostra conversazione e ci lanciavano occhiate minacciose. D’impeto la donna in burqa ci disse di essere stata condannata a cinque anni per non aver potuto produrre almeno quattro testimoni dello stupro, come richiede la legge attuale.
«Ma di fatto è impossibile» esclamò la vecchia dagli occhi azzurri «perché i testimoni, quando ci sono, vengono minacciati di morte dalla famiglia, dal clan o dalla tribù dell’accusato.»
Nelofar, che non ha ancora vent’anni, sta marcendo qui dentro in attesa di giudizio perché è rimasta incinta dopo essere stata violentata da suo zio. Ha partorito in carcere, ma nessuno sa che fine ha fatto il bambino. Probabilmente è stato ucciso subito dopo la nascita. L’infanticidio è una pratica corrente. Quando avevo dodici anni, mia madre mi prese sulle ginocchia e mi spiegò che certa gente uccide le neonate femmine, perché non portano soldi e quando devono sposarsi sono un costo per la famiglia, che deve pagare una dote alla famiglia del marito. Rimasi inorridita.
«Ma come vedi, Asia,» aggiunse mia madre «noi ti abbiamo tenuta.»
Ascoltando le storie di quelle detenute capivo di non essere la sola a subire. Qui, fin dai primi giorni, tutte sapevano che ero una cristiana accusata di avere pronunciato una bestemmia. Certe musulmane mi guardavano un po’ di traverso, ma mi lasciavano in pace. Nel piccolo cortile dell’ora d’aria non potevano farmi del male, con le guardie che sorvegliavano. Il più delle volte mi accontentavo di ascoltare, senza prendere parte più di tanto alle conversazioni. La mia ultima esperienza con un gruppo di donne musulmane mi aveva portato direttamente in carcere, forse per sempre, salvo essere ammazzata prima. Dio solo sa quali altre accuse potrebbero piovermi addosso…
Che cosa devono – che cosa possono – rispondere i cristiani, quando un musulmano domanda loro se credono in Allah e nel profeta Maometto? Io sono stata educata nella fede in Cristo, nella Vergine Maria e nella Santa Trinità. Rispetto l’islam e il credo dei musulmani, ma che cosa posso rispondere in una circostanza del genere? Se dico che non credo in Allah ma in Dio e in Gesù Cristo, vengo considerata una bestemmiatrice. Se dico che ci credo, divento una traditrice, come san Pietro quando rinnegò Gesù per tre volte. Sono interrogativi che non mi ero mai posta, prima d’allora…
È da gennaio che non vedo le donne dell’ora d’aria. Chissà se la piccola Nelofar è stata processata, se è ancora fra queste mura o ha riottenuto la libertà. Non sono più nel loro corridoio, non siamo più vicine di cella. Sono totalmente tagliata fuori non solo dal mondo, ma anche dalla vita di questa prigione. Nel mio buco senza aperture sul cielo, non vedo né sento ciò che accade là fuori.
Ashiq non mi racconta tutto, per proteggermi, per darmi la forza di continuare a credere che un giorno uscirò di qui. Zenobia, però, mi riferisce gli sviluppi legati alla mia storia, che dopo la condanna a morte sembra diventata un affare di Stato. È lei, per esempio, che mi ha parlato delle numerose manifestazioni che si sono svolte a Lahore, Karachi e Islamabad. È spaventoso pensare che migliaia di persone sono scese in strada per gridare apertamente che devo morire, io, una povera donna insignificante. Senza volerlo sono diventata il simbolo della legge sulla blasfemia. Le dimostrazioni contro di me sono un’accanita difesa di questa legge, che dopo l’assassinio del governatore sembra diventata intoccabile. Secondo Zenobia, dietro le manifestazioni c’è il Jamaat-e-Islami, il più vecchio partito politico islamico del Pakistan, nato con il nostro paese, dopo la divisione del 1947. Io, che so ben poche cose, conosco questo partito religioso perché è nato dalle mie parti, in Punjab. Un giorno tre aitanti giovani del Jamaat-e-Islami si sono spinti fino al mio villaggio per cercare nuovi adepti e rafforzare così il loro movimento. Ashiq li aveva incontrati alla fornace. Per paura li aveva ascoltati pazientemente, soprattutto senza dire loro di essere cristiano. Per fortuna i suoi compagni di lavoro musulmani avevano mantenuto il segreto. La sera stessa, rientrato tardi a casa, mi aveva raccontato ogni cosa. Il loro messaggio era stato chiaro. Avevano spiegato che il Jamaat-e-Islami si batteva affinché il governo applicasse alla lettera la sharia, la legge coranica. Ai quindici presenti, gli uomini del Jamaat-e-Islami avevano dichiarato di essere contro l’Occidente, contro le società basate sul denaro, e di voler limitare le libertà di tutti per diventare musulmani migliori. Stando a Zenobia, uomini favorevoli a queste idee si sarebbero radunati, in 50.000 a Karachi e in 40.000 a Lahore, per brandire un’immagine di me con la corda al collo e gridare a gran voce il loro attaccamento a questa legge, che prevede la pena di morte per chi insulta l’islam. Ashiq non mi aveva riferito che dopo la mia condanna a morte, nel novembre scorso, erano state organizzate manifestazioni così massicce. Ma Zenobia mi dice sempre la verità, anche quando ascoltarla è duro e fa male. Conosco la grande benevolenza che Zenobia ha nei miei confronti. Lei sta dalla mia parte e prova compassione per me.
Anche se quel che accade fuori è preoccupante, esserne al corrente non mi demoralizza e mi dà invece la forza di resistere, di non lasciarmi morire.
È ancora presto e anche se non ho più punti di riferimento, so che non sono ancora le 7 del mattino, perché a quell’ora la guardia di turno mi porta l’acqua con cui mi preparo il tè. Oltre a fare il bucato, devo prepararmi da mangiare da me, per evitare che qualcuno mi avveleni. Mi portano gli alimenti crudi e io li cucino, nella mia unica gavetta.
All’idea di incontrare Zenobia sono davvero contenta. Sono impaziente di poter finalmente guardare qualcuno negli occhi senza che questo venga interpretato come un’insolenza o una provocazione. Finalmente avrò il volto rilassato, le guance distese, e potrò provare a sorridere, se ne sono ancora capace. A chi non conosce le mie condizioni di vita in questa maledetta prigione sembrerà poco, eppure è sufficiente a portare un po’ di luce nella mia giornata. Mentre aspetto Zenobia, che ormai dovrebbe arrivare, provo a pronunciare qualche parola, per vedere se la voce mi funziona ancora. Martedì scorso Ashiq non è venuto e così sono più di dieci giorni che non la uso. Da quando sono qui in isolamento l’ho usata talmente poco che mi chiedo se un giorno o l’altro non mi abbandonerà. Ho anche perso molto peso. La salute non va affatto bene, i muscoli non rispondono più come una volta, mi sento meno presente e mi domando se sarò mai in grado di riprendere le attività di un tempo, soprattutto le raccolte, che sono pesanti per la schiena. Mi sembra di avere cent’anni e ho l’impressione che, se uscirò, non potrò più vivere come prima. Per scaldarmi e controllare se la voce mi funziona ancora, recito a voce alta la mia preghiera del mattino, una di quelle della mia nonna adorata:
Padre, grazie di averci protetti questa notte. Grazie per questa nuova giornata e per la salute che ci dai. Signore, resta accanto a noi durante questo giorno, nel tempo del lavoro, dei pasti e dei giochi. Colma del tuo amore noi e il nostro prossimo. Amen.
Sono confortata nel constatare che la voce non è cambiata, funziona ancora. Sì, la riconosco, è a posto, mi permetterà di parlare un pochino con Zenobia.
Eccola, sento che arriva! Riconosco i suoi passi, gli unici passi delicati che mi sia dato di ascoltare.
A...