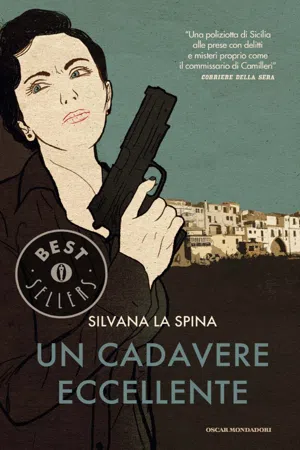![]()
![]()
Per la verità, quando il commissario Maria Laura Gangemi si era accorta che in quella zona il cellulare non prendeva, era ormai troppo tardi. Lei e sua cugina erano già arrivate al paese.
Era stata Violetta a portarcela. Violetta anzi aveva tanto insistito che alla fine aveva vinto.
“Per san Giuseppe andiamo dalla zia Matilde. Massimo non c’è, e tu non vorrai lasciarmi andare sola da quelle parti, vero? Non dico che sono zone selvatiche, ma certo siamo in piena campagna.”
Aveva aggiunto poi, mentre erano in macchina: “In ogni caso si mangia benissimo: zocculuna, sfingiuna e paste di mandorla. Vedrai, torneremo ingrassate di due chili. Zia Matilde sai – io la chiamo zia, ma in realtà è una cugina di mio padre – ai suoi tempi era bellissima.”
Maria Laura aveva cambiato di marcia e aveva ripreso la salita.
“Dicono che una sua antenata ebbe persino un affaire con D’Annunzio e un figlio da lui. Gabriellino, mi pare. Una storia famosa, su cui quel porco di D’annunzio scrisse anche un romanzo. Non mi ricordo il titolo, naturalmente. E poi chi vuoi che oggi legga D’Annunzio!”
Se è per questo tu non leggi neppure gli altri, aveva pensato maligna Maria Laura. Però non lo aveva detto. Sapeva che Violetta oltre che civetta era anche permalosissima.
“Ma se vuoi sapere altro, vedrai che a casa sua qualcuno lo troviamo” disse allegra la cugina interrompendo i suoi pensieri.
“Quale altro?” aveva chiesto Maria Laura che veramente non capiva. “Che stai dicendo?”
“Parlavo della zia Matilde” aveva insistito Violetta. “In quella casa e in quel paese ne sono successe di cose. E qualcuno che le sappia e le racconti lo troviamo, vedrai...”
“Per carità!” aveva riso il commissario che finalmente aveva capito il senso delle parole della cugina. Mi manca di incontrare il solito intellettuale di paese, aveva pensato. Magari un vecchio professore di latino e greco, che non vuole scomparire dal mondo senza lasciare traccia oltre alla lapide al Camposanto.
Ma vuol dire che era destino. Perché poi l’intellettuale l’avevano trovato.
Il professor Carlo Sanesi.
Né brutto, né vecchio. Sembrava invece un Pupo di ceramica, gli mancavano solo i baffetti e sarebbe parso Orlando sputato. Con in più quello strano tic dello studioso timido, che gli faceva togliere gli occhiali dalla montatura di tartaruga quando si eccitava con i suoi racconti di storie locali. E inforcarli subito dopo, quando si calmava.
A Maria Laura era stato presentato come uno storico di valore. Venuto esplicitamente da Pavia a fare ricerche per un libro che stava scrivendo sugli antichi culti della penisola.
E dal momento della presentazione non aveva smesso. Da quel momento aveva continuato a illustrarle le usanze del paese, l’atmosfera dei paesaggi. Aveva parlato infatti dei miti arcaici del luogo. Eredità della Magna Grecia, aveva specificato. Culti orfici che ormai sconfinavano nelle magherie. Lì, lì, e anche laggiù, indicava col dito. Vede quelle colline che stanno oltre paese? Bene, signora mia, da quelle parti si praticano ancora i riti di Demetra, che chiamano la Signora.
Anche adesso, mentre erano affacciati al balcone a petto d’oca sulla gigantesca piazza della Matrice, quello non faceva altro che parlarne.
Ma si era forse chiesto se a lei interessavano quei discorsi?
Alla fine non resistette.
«Ma insomma» esplose Maria Laura. «Crede davvero che solo perché siamo in Sicilia esistano ancora queste cose, signor... insomma, professore? Ma come fa a crederci?»
«Per via della dea dipinta nei sotterranei della cripta» rispose lui.
«Che cripta?»
«Quella della Matrice. L’affresco sta sopra una tomba dov’è seppellita quella che chiamano la “piccola santa”, che però la Chiesa non ha mai voluto santificare.»
«Che santa?»
Di cosa sta parlando, professore?
«Femmine folli» disse lui.
«Che cosa?»
«Accadde durante l’invasione araba. La prima, voglio dire. Un gruppo di donne si nascose là sotto e prese delle sostanze allucinogene o forse si ubriacò. Per la paura, immagino. Lei sa cosa facevano gli Arabi a queste donne quando le prendevano? Qui, proprio in questi posti?»
Maria Laura cominciò a scalpitare. Insomma.
«Fu allora che accadde la storia della bambina.»
«Quale bambina, scusi?»
Lo studioso si fermò, fece una lunga pausa come se quello che stava per raccontare fosse qualcosa di veramente difficile.
«Vede. Quelle donne là erano delle esaltate. Così decisero che una delle loro bambine dovesse essere sacrificata al condottiero arabo, che allora era il famoso Asad al-Furāt, una specie di santone tunisino, e ne scelsero una. Piccola, forse otto o dieci anni. La rivestirono di vesti colorate, secondo l’uso bizantino, la coprirono di fiori, la cosparsero di profumi e gliela mandarono.»
«Oddio! E che successe?»
«Fu martirizzata. Per questo ancora a volte la notte piange. Dicono che gli strilli della bambina si sentano ancora oggi per la campagna quando c’è la luna piena.» Si tolse gli occhiali e la guardò con lo sguardo nudo. «La sua tomba è laggiù, nelle catacombe della Matrice, e col tempo la gente del posto l’ha considerata la sua piccola santa, ma la Chiesa non ha mai voluto saperne di questa storia.»
«E lei... lei vuole scrivere un libro su queste storie» mormorò Maria Laura, amareggiata. Anche perché all’improvviso le parve di vederla. La scena. L’aveva anzi dentro le pupille. Arabi. Tanti. Un popolo di uomini affamati e infoiati. Poi la bambina che urlava. Il capo arabo che improvvisamente si chinava su di lei mentre le donne da qualche parte cantavano. E il canto delle donne si mescolava alle urla degli invasori. Una scena così primitiva, così selvaggia...
No.
Basta.
Si afferrò alla ringhiera e cercò di ritornare in sé.
L’uomo non si accorse di nulla. Doveva essere tutto preso dai preparativi della processione davanti al sagrato della Matrice.
«Sì» continuò imperterrito. «Un libro. Che intitolerò Femmine folli.»
Maria Laura lo guardò in faccia in malo modo.
«Perché?» disse dura.
«Perché tutto qui intorno...» lo studioso fece un gesto verso le donne vestite a festa, i ragazzini col saio bianco, e gli uomini nei loro abiti migliori «tutto qui intorno è come allora, quando una bambina venne sacrificata all’invasore come Proserpina al dio Ade.»
«Ma che dice! Questa è la festa per san Giuseppe» esclamò smarrita lei.
«Già! San Giuseppe,» ammise serio «che da queste parti è anche il protettore delle messi. Mentre un tempo le messi erano sacre a Demetra. Non pensa che la dea per questo si sia in un certo senso sentita tradita?»
Lo guardò ferma. Che voleva dire quell’uomo? Che la dea si era vendicata? Che per timore della sua vendetta la gente continuasse a mantenerne il culto?
In ogni caso l’uomo aveva qualcosa di luciferino. Il sorriso forse, o quel luccichio negli occhi. Senza contare che quelle erano solo storie sanguinolente e arcaiche. Che potevano avere interesse solo per un uomo come lui. Fece dietrofront e stava per andarsene senza dire neppure un “Mi scusi”, quando lui le disse rammaricato:
«Mi dispiace di averla turbata. Credevo le interessasse. Ho saputo che è un commissario di polizia.»
Non voltarti, si ordinò rabbiosa Maria Laura. Non voltarti assolutamente, se non vuoi che ti legga in faccia lo smarrimento.
![]()
In quel momento il notaio don Tanino Lanza alzò gli occhi all’orologio del municipio.
Quasi le undici, pensò. Era ancora presto per andare al ricevimento della baronessa?
Ma era sicuro poi di volerci andare dopo quello che era successo?
Nel cielo notò lo scorrere agitato degli uccelli. Si rincorrevano infatti scomposti, anche se subito dopo tornavano a riunirsi.
Sarà per via dei botti, pensò.
Ma inaspettatamente gli tornò alla memoria un verso. Stormi di uccelli neri nel vespero migrar. Cos’era? Di certo una di quelle poesie imparate a memoria alla scuola elementare.
Pascoli forse. O magari Carducci. In fondo erano sempre loro due che parlavano di uccelli o di campagna.
Il vespero però era ancora lontano, anzi era ancora piena mattinata, ma ricordava che gli uccelli neri nella poesia venivano paragonati ai cattivi pensieri.
Uccelli neri e cattivi pensieri.
Strinse la bocca come se volesse allontanare un gusto amaro e chiamò un vecchio cameriere del Circolo:
«Sarino, mi porti un bicchiere d’acqua calda che così allungo il caffè?»
Quello, seduto anche lui in un angolo sotto il tendone rigato del bar, si alzò con indolenza:
«Vuole che gliene porti n’autro, notaru?»
«No, no, lascia perdere. Preferisco prenderlo allungato ché altrimenti mi fa acido allo stomaco.»
«Un mio zio lo pigliava accussì ma lo stesso dovettero operarlo di ulcera.»
Il notaio fece una smorfia a quella notizia. Ma poi ricordò che lo zio di Sarino, quello zio, era un piccolo e stupido delinquente del dopoguerra. Di quelli che allora, nelle campagne, pullulavano come sorci. Altro che ulcera, pensò sogghignando tra sé, quello era morto a colpi di lupara.
Però anche lui doveva stare attento con tutto quel caffè. E specialmente con certi pensieri. I pensieri bruciano lo stomaco più di un veleno – non si dice forse che lo stomaco è il secondo cervello dell’uomo?
Improvvisamente una voce dall’alto calò su di lui.
«Non va alla processione, notaio?»
Il notaio si fece scudo con la mano e osservò l’uomo enorme che gli stava accanto.
Gerlando Villari a quel punto, senza nemmeno essere invitato, si sedette sulla sedia accanto a lui.
«Non ci tengo a san Giuseppe» rispose finalmente il notaio immusonito. «Era solo il padre putativo del Padreterno. Ed è vecchio. Mi ricorda mio nonno che, per quanto stagionato, ancora si ostinava ad andare in giro per il paese a caccia di femmine. Magari soltanto per il piacere degli occhi, diceva...» Poi, ricordando chi aveva davanti, mormorò: «Oh, mi scusi. Dimenticavo che lei è un credente convinto».
«Come tanti in questo paese» osservò l’altro.
Tanti no, pensò il notaio. Tanti vanno in chiesa, ma quella è un’altra cosa. Lo fanno per farsi vedere, perché il parroco possa dire al senatore: questo c’era e questo anche, potete considerarli nostri amici.
La religione in fondo è così. Ed è così ...