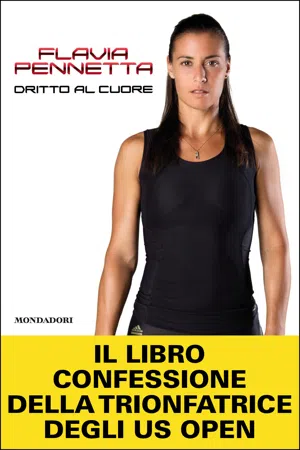Flavia Pennetta, born to run in Brindisi nel 1982, anno in cui Martina Navrátilová e Chris Evert-Lloyd vincono due slam a testa.
Mia madre ha ventisette anni e io sono la sua seconda figlia. È così giovane che suo padre si rifiuta di farsi chiamare “nonno”, dice che non è pronto, così per me lui è “babbo”.
Bellissima, ha sposato l’uomo che ama e, naturalmente, è un talento del tennis, gioca in serie C.
In casa mia solo il gatto non gioca a tennis. Mio padre, ex seconda categoria, presiede il Circolo della città; mia sorella, Giorgia, è una promessa assillata dai miei genitori; la zia, la sorella di mamma, è Elvy Intiglietta, della quale si ricordano due vittorie strepitose: una contro Maria Fiume, l’altra che le valse i tricolori Under 18. Oggi insegna, guarda caso, tennis.
Prima che faccia in tempo a rendermene conto, mio padre mi ha già messo una racchetta in mano: la sua. Ho cinque anni e frequento già il Circolo. Faccio il tifo per la mamma e per Giorgia, sono una specie di mascotte.
L’anno dopo sono con tutta la famiglia a Roma per gli Internazionali. Abbiamo comprato i biglietti da un bagarino, piove e siamo tutti ghiacciati sotto gli ombrelloni, dai quali mia madre scatta fulminea appena vede passare qualche giocatore interessante: si lancia e chiede l’autografo. Non è possibile: mia madre per me è una campionessa, mio padre un idolo, mia sorella un mostro sacro, mia zia una leggenda. Sono stanca e infreddolita e non mi sembra giusto che noi dobbiamo stare lì a congelarci.
«Un giorno verremo come protagonisti» dico.
Senza la mia famiglia sarei tutta un’altra cosa.
Siamo tanti e rumorosi e mangioni: fino a non troppo tempo fa, a Natale, ci siamo ritrovati tutti nella taverna dei miei, una trentina di persone almeno, con mamme e nonne e zie mescolate che cucinavano quantità impressionanti di cibo, mentre la pasta la si faceva sul momento. Qualcuno si vestiva da Babbo Natale e noi bambini tremavamo di meraviglia e credevamo che la vita fosse una magia in grado di sorprenderci ogni giorno.
Il mio Sud è caldo e accogliente e mi regala la libertà sin da piccolissima. Di pomeriggio scappo fuori e mi lancio in ogni genere di avventura con Alberto, il figlio dei vicini. Il cortile è il nostro regno: giochiamo a palla, a basket, a pallavolo, andiamo in skate, ci arrampichiamo sugli alberi, ci spiaccichiamo a terra e ci sbucciamo le ginocchia, ci rialziamo senza piangere granché e ricominciamo. Sono un maschiaccio e me ne vanto: più piccola di Alberto di un anno e un palmo, gareggio con lui alla pari in tutti gli sport. Insieme stracciamo senza nessuna pietà Luca, un altro bambino del quartiere, buono e timido e terrorizzato quando sua madre gli dice amorevole: «Vai Luca, esci a giocare con Flavia e Alberto!».
Il quartiere è vicino al mare, fuori dal centro e dalla confusione. È una specie di Wisteria Lane, con la differenza che al posto delle ville di gran lusso ci sono poche casette tutte simili, a tre piani.
Ci si possono fare cose che, altrove, non sarebbero permesse, come il grande falò il giorno dell’Epifania: si brucia l’albero di Natale e, con lui, gli spiriti dell’anno vecchio, dando il benvenuto a quello nuovo. Oggi credo che gli alberi siano di plastica.
Ci siamo trasferiti lì quando avevo una settimana, fresca di ospedale. Per combinazione la sera stessa è saltata la luce, i miei sono andati a chiedere delle candele ai vicini, i genitori di Alberto. Era il suo compleanno, stava spegnendo la prima candelina.
Cresco in una comunità di bambini che con la scuola ha poco a che fare: c’è Alberto, ci sono Fiorella e Greta, le mie cugine. Fiorella assomiglia a me: ama lo sport, ama correre, non ha paura di niente. Greta è più timida, meno avventata. In compenso è furba: quando ne fa una, la nonna mi dà automaticamente la colpa e lei tace. Io le prendo dalla nonna, Greta le prende da me: non fa una piega.
Siamo bambini casinisti in una famiglia che d’inverno si mette in colonna e occupa un’intera corsia d’autostrada dalla Puglia all’Austria per andare tutti insieme a sciare. Altrove si direbbe “unita”.
Da parte di mamma siamo pochi: zia Elvy e due figlie, la nonna e “babbo”. È da parte di papà che i Pennetta s’allargano a dismisura: Oronzo, detto Ronzino, è il primo di otto tra fratelli e sorelle. La leggenda vuole che le donne Pennetta siano più forti degli uomini, ma che loro siano dei personaggi. Tutti e quattro i figli maschi sono la copia esatta di mio nonno, scarsi di capelli e ricchi di spirito. Il nonno, amatissimo da tutta Brindisi, aveva un’impresa di rifornimenti per le navi, Pennetta Petroli.
La nonna è morta di tristezza un anno prima che nascessi. Una delle sue figlie se n’era andata a soli diciassette anni. Si chiamava Fiorella, mia cugina porta il suo nome. Era rimasta incinta e aveva paura. Non disse niente a nessuno e andò da una mammana. Tornò a casa che stava male, la febbre non passava, nessuno in casa capiva, nessuno in casa sapeva. Fecero tutto quello che potevano, poi la portarono all’ospedale. Emorragia interna. Mio padre stava tornando in macchina da un torneo con la mia mamma e sentì per radio un annuncio: cercavano sangue di un certo gruppo sanguigno per Fiorella Pennetta. Dissero il nome perché il nonno era stimatissimo, e pensavano che così sarebbe accorsa più gente. Cosa che in effetti avvenne. Ma era troppo tardi.
Morta d’amore, o forse di paura, a diciassette anni. La nonna non se l’è mai perdonato.
Il nonno resistette qualche altro anno e se ne andò prima che io ne compissi dieci. Mi credevano troppo piccola per il funerale, così che era morto me lo disse la mia mamma, sulle scale di casa, e indicando il cielo mi spiegò che il nonno mi guardava da lassù.
Mi arrabbiai tantissimo perché qualcuno mi stava rubando il tempo da passare con lui. Niente più pomeriggi in giardino a piantare pomodori e a strappare le erbacce, a imparare le “cose da maschi”.
Nessuno si aspettava che nascessi femmina. Per la forma della pancia. Ne erano così convinti del contrario che l’ecografia nemmeno la fecero. Il ginecologo lo dava per certo, mio padre pure, mio nonno era entusiasta: finalmente avrebbe avuto un ragazzo non impressionabile da portare con sé nelle battute di caccia, uno a cui insegnare tutto quello che sapeva degli animali, dei boschi e della vita.
Il 25 febbraio 1982, fuori dalla sala parto, mio padre cammina avanti e indietro.
Spunta il ginecologo, suo amico da una vita, oggi è il presidente dello stesso Circolo tennis che presiedeva mio padre: «Oronzo, è femmina». Allargando le braccia, come a dire: “Mi sono sbagliato, perdonami…”.
E lui a imprecare: porca di qua, ne ero certo di là…
Nel tempo libero, cioè poco, seguo mia sorella come un’ombra. Giorgia, ben sei anni più di me, che a quell’età sono una distanza siderale, propenderebbe per il sorellicidio, ma in fondo vuole bene a questo botolo che smania per raccoglierle le palle e la tratta come una dea.
Non solo voglio fare le stesse cose che fa lei: io la ammiro e la amo talmente tanto che voglio proprio essere lei. Insisto per avere l’apparecchio, quello fisso, terribile: me lo mettono e non faccio che sorridere perché finalmente ho i denti come Giorgia. A quattordici anni lei riceve una Vespa, bianca, nuova fiammante, stupenda. Io ho solo nove anni ma la voglio, la voglio disperatamente e comincio a rognare. La ricevo anch’io a quattordici: è blu, Giorgia è a Parma, all’università. Ha smesso di giocare a tennis ed è una sorellona grande alla ricerca della sua dimensione.
Probabilmente è per diventare come lei che comincio a giocare a tennis. Poi diventa una passione vera. Una cosa mia.
Passo interi pomeriggi dietro casa: io, la pallina, la racchetta e il muro. Aspetto che mio padre torni la sera per spostare i divani e fare due tiri con lui. Mia madre prima minaccia: «Se mi rompete qualcosa…», poi sta a guardare mentre papà sospira e mi fa l’occhiolino.
L’amore per il tennis supera quello per tutti gli altri sport. Così Ronzino comincia a portarmi al Circolo più spesso. Conosco lì il mio primissimo, romanticissimo amore: il figlio del maestro di tennis. Abbiamo i capelli tagliati identici, a scodella, se non palleggiamo ci teniamo per mano.
I miei sorridono e stanno attenti a non comportarsi come con Giorgia, che ha lasciato. Caratterialmente siamo molto differenti: lei è più chiusa, più meditativa, più fragile di fronte allo stress che comporta uno sport a livello agonistico. Piangeva e andava in crisi nera per ogni risultato non eccellente, o quando doveva sfidare un’amica. In campo è cattivissima, ma preferisce perdere che rischiare di compromettere un’amicizia. E credo non sopportasse la rigidità dei nostri genitori sugli allenamenti, gli orari, i maestri, la gestione del tempo libero, l’alimentazione… cose così. Ha fatto bene a lasciare e a riprendere quando è stata pronta. La sua dimensione l’ha trovata più avanti e altrove, è campionessa di beach tennis e coordinatrice regionale.
Io sono diversa: obbedisco poco, mi ribello molto. Mi ribello per modo di dire, Agassi non chiamerebbe “ribellione” lo stare dietro casa a sbattere la pallina contro il muro per delle ore invece di andare in campo ad allenarsi, io sì.
La calma intorno a me, al mio talento che cresce, in parte è stata un regalo di Giorgia, in parte me la sono conquistata con questo caratterino, in parte è dovuta al fatto che da bambina sono una sega.
Divento di interesse nazionale intorno ai tredici anni, dopo aver perso tutto il possibile nei campionati Under 12. Ad altre ragazzine è andata molto diversamente. Ricordo Emily Stellato: una star! Osannata come prossima campionessa dall’Italia intera, parte per Bradenton. Destinazione: l’Academy di Nick Bollettieri, “scuola” per modo di dire dove si allenano talenti tennistici. Lì capisce che il mondo è parecchio più grande di come se l’è immaginato, che in Florida non aspettavano lei e che, in buona sostanza, è una delle tante. Scende dal piedistallo e torna a casa. A quattordici anni scopre di non essere chissà chi e non sa più chi è.
Ci penso spesso: se fossi stata più brava allora forse avrei perso il senso delle cose, forse mi sarei trovata a non sapere più chi ero. Depredata della mia identità di “vincente”, avrei dovuto costruirmene una nuova. Non facile.
Decisamente meglio essere una bambina normale, con degli amici normali, che va in una scuola normale e di pomeriggio fa le cose normali. Con la differenza che ogni domenica papà mi porta a Bari dal maestro Dell’Edera. È stato un professionista, oggi allena promesse come responsabile regionale del settore tecnico: raccoglie ragazzini da tutta la Puglia. La mattina alle sette e un quarto siamo già fuori per il risveglio muscolare, poi colazione bilanciata e via in campo. È piuttosto severo, ma la sua inflessibilità su cibo, orari da dedicare al riposo e al gioco è utile. Le regole sono fondamentali, e assaggiare quelle con cui si avrà a che fare se si sceglie il tennis è di grande aiuto.
Io non ascolto sempre, però.
Non ascolto il maestro Dell’Edera quando si tratta di non baciare in pullman il mio primo fidanzatino, un tennista di Barletta conosciuto giusto ai suoi raduni. Non si cresce solo tennisticamente, quindi per me e Michele ogni coppa o torneo fuori porta è un’occasione irripetibile. Dell’Edera ci guarda dallo specchietto e tuona: «Basta! Dovete smetterla voi due, è pazzesco!». Noi lo guardiamo di sottecchi e ricominciamo a darci i baci.
Non ascolto nessuno quando arriva la prima tuta della Nazionale: l’attesa è l’entusiasmo più puro, la totale soddisfazione, un folle desiderio di farmi vedere. Io invece no, non ne voglio sapere e frustro ogni aspettativa ripiegandola e mettendola in un cassetto. Mi mette ansia, assolutamente non voglio sfoggiarla al Circolo. So che posso giocare per Flavia, non sono certa di poter giocare per la Nazionale. Il tennis è ancora un gioco quando si è in Nazionale, o è qualche cosa d’altro? Prima di capire cosa ci posso fare scappo a gambe levate. Nascondo la tuta e nascondo me stessa da tutte le responsabilità che rappresenta.
Ho quattordici anni quando mi chiedono per la prima volta di andare a Roma al Centro federale. Mia mamma mi guarda e mi chiede: «Tu come la vedi?». So già che lei pensa: “Non se ne parla neanche”, ma non c’è problema: lo sto pensando anch’io. Anzi, io per l’esattezza penso: “Io da qua non mi muovo proprio. Punto”.
Bugia. L’anno dopo sono all’Acqua Acetosa.
Mio padre consuma vari treni di gomme di una Croma bordeaux sulla A14 (Bari-Roma), per venire a trovare me. Poi prosegue sulla A1 verso Giorgia, che studia Economia a Parma. La mamma si è trovata da sola in una casa enorme, l’unica salvezza per mio padre è portarla a trovarci, altrimenti non farebbe altro che occuparsi di lui.
Insieme a me ci sono Francesca Schiavone, Roberta Vinci, Maria Elena Camerin. Siamo allenate da un terzetto di allenatori, uno dei quali è anche preparatore fisico.
I maschi dormono da un’altra parte ma di giorno stiamo sempre insieme. Divento inseparabile da Federico Luzzi, Potito Starace e Florian Allgauer: i miei nuovi compagni di zingarate.
Al mattino alle otto siamo in classe, studiamo qualche ora e poi ci alleniamo, ci alleniamo, ci alleniamo. Gli allenamenti non finiscono mai e, soprattutto, non si interrompono mai, nemmeno d’estate.
La scuola nel giro di due anni si trasforma in un tormento. Il primo anno frequento il liceo scientifico a Brindisi, il secondo sono a Roma e seguo lezioni da privatista. Passo un luglio d’inferno insieme ad Antonella Serra Zanetti tra tornei, allenamenti e studio: siamo le uniche due dell’intero Centro federale a dover dare gli esami per venire ammesse all’anno successivo. Mentre palleggiamo ripetiamo le lezioni. La realtà è che abbiamo perso rapidissimamente l’abitudine allo studio e abbiamo la testa da un’altra parte. Il tennis richiede concentrazione, come lo studio, ma una concentrazione diversa. A sedici anni so mantenere i nervi saldi durante una partita, per lunga che sia, ma non so più rimanere presente mentre preparo per un pomeriggio l’interrogazione di storia.
Così, dal terzo anno di scientifico, al quale mi ammettono, passo a ragioneria: apriti cielo. Francese, non so una parola. Ragioneria, cos’è?
Me la cavo per i due anni successivi, mentre la maturità è una vera resa dei conti. È una lotta titanica tra il mondo dello sport e le sue regole e quello della scuola: a diciannove anni viaggio spessissimo, partecipo a tornei di alto livello, sono molto più affaticata e ho meno tempo da trascorrere sui libri. I professori sono disperati e comprensivi.
Mi salvo dopo una performance straziante condivisa con la Camerin, nel frattempo diventata semplicemente “la Came”, e Roberta “Robertina” Vinci. Prima di produrci in raffinate disquisizioni all’orale nonché nelle tre prove scritte, passiamo varie settimane ad alternare agli allenamenti sedute con manualetti Bignami di tutte le materie, sulla base di un programma serratissimo che prevede la suddivisione degli argomenti. Leggi: ciascuno studia qualcosa e poi lo ripete agli altri, nella vana speranza che sentendolo dire a voce alta e sforzandoci di stare attente qualcosa ci rimanga attaccato. La lettura individuale, infatti, ha su di noi un tragico effetto soporifero al quale non riusciamo a resistere: separate nel...