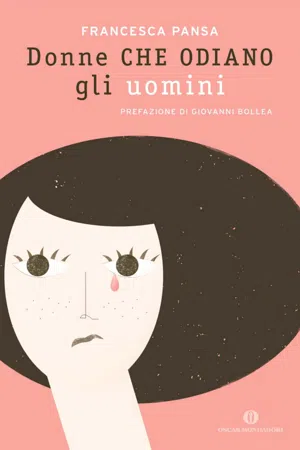![]()
AVRAI ANCHE OGGI LA TUA VIOLENZA
Giuditta
Franca
Victoria
Tania
Eleonora
![]()
In Italia, dice l’Istat, sono più di sette milioni le vittime di violenza fisica e psicologica, spesso combinate; si tratta soprattutto di donne, e circa settecentosettantasettemila di loro hanno subito un’azione di stalking.
Io faccio parte di questi due milioni e passa, ho subito molestie quotidiane, fatte di telefonate, messaggi, bigliettini lasciati sul parabrezza della mia macchina, pedinamenti a ogni ora del giorno e della notte, appostamenti sul luogo di lavoro e nei pressi della mia abitazione. La mia vita era diventata un inferno, avevo perduto la serenità, la gioia di andare a mangiare un gelato o fare una semplice passeggiata con le mie amiche. Sono stata privata della mia quiete e della mia autonomia.
Troppe donne sono state uccise in questi ultimi mesi. Come facciamo a cambiare questa orribile tendenza? La legge contro lo stalking è stato un inizio, ma chi ci protegge davvero? Io per poco non morivo, ma ce l’ho fatta, posso raccontare la mia storia, eppure ho sempre paura che quel mostro che mi ha distrutto la vita ricompaia e mi faccia ancora del male, e, soprattutto, ho ancora paura per mia figlia.
Tutto è iniziato dopo il mio divorzio. Debbo subito fare una considerazione: ho raccolto drammi su drammi. Mi sono sempre chiesta, perché proprio io ho dovuto attraversare momenti così difficili? La risposta non ce l’ho. È un problema di destino, di fatalità? Oppure sono io che in qualche maniera interpreto quel destino, quella fatalità che inesorabilmente diventano il macigno che ingombra la mia vita?
Il mio matrimonio andò subito a rotoli; lui era immaturo, infantile. Lo avevo conosciuto nella sezione del Pci dove mi ero iscritta. Lui era socialista e questo stupidamente mi sembrò un buon biglietto di presentazione, tanto più perché apparteneva alla corrente di sinistra, quella più vicina alle mie idee. Stupida che sono stata, i maschi sono tutti uguali, tutti prevaricatori e hai voglia a dire che gli uomini e le donne debbono avere uguali diritti: a casa mia io lavoravo fuori e dentro, secondo la più collaudata tradizione nostrana...
Quando rimasi incinta, cominciarono i dolori: lui era come l’argento vivo, sembrava non rendersi conto di nulla, voleva sempre uscire, divertirsi, ballare, passare freneticamente da un film a una riunione di partito a una rimpatriata tra vecchi amici del liceo; io portavo avanti una gravidanza difficile, dovevo riposare, non potevo assolutamente assecondarlo. Mio fratello, un altro maschio terrificante, decise di concedersi un viaggio in Polonia (oggi si andrebbe in Brasile), annoverabile come «turismo sessuale». Mio fratello mi deluse terribilmente, non avrebbe mai dovuto invitare Giovanni. Ma si sa, la famiglia non è mai dalla parte delle donne. Sbagliai, lasciai che mio marito andasse con lui. Oggi che ho sessant’anni non mi fiderei più. Il mio rispetto per i maschi è zero, ma allora ero innamorata e generosa. Finsi di non capire, accettai quella sua ennesima dimostrazione di leggerezza e immaturità.
Quando tornarono, mi portarono una polacca in casa. A fare che? Con chi dei due andava? Io, che frequentavo i gruppi femministi, non me la presi con lei, come spesso si fa: quando si è traditi la colpa non è mai del marito, ma di «lei». Le spiegai che i nostri maschi fanno solo cavolate e le diedi i soldi per il viaggio di ritorno. Mi fece pena quella povera ragazza illusa da due italiani fedifraghi e idioti.
Il matrimonio fallì subito dopo la nascita della mia bambina. Lui soldi ne mandò sempre pochi, insulti parecchi, coriandoli di insulti che mi piovevano in ogni occasione. Ero stata aggressiva, incapace di capire, paleofemminista, mi ero lasciata influenzare dallo «spirito del tempo» che sfasciava i matrimoni e lasciava dietro di sé solo cenere e rovine?
Intanto io, sempre incarnando lo spirito del tempo, continuavo a fare la mia vita di capofamiglia, con tutti gli impegni, i doveri e le incombenze, come sanno le donne, sposate o divorziate. Tutto grava su di noi, sempre. Questo vuol dire che siamo più forti e coraggiose. Mio marito mi aveva tradito da subito e io l’avevo lasciato. Ero rimasta con una figlia piccola e tanta amarezza.
Volevo rimanere single, così come si cominciava a dire in quel periodo in cui i single crescevano a vista d’occhio o, se volete, a macchia d’olio. Finché non ho incontrato Manfredi, un ingegnere un po’ (moltissimo) strano, ma questo non mi allarmò più di tanto. Anch’io ero diventata piena di paure e un po’ aggressiva. Mi sentivo profondamente sola e la strategia antisolitudine più sicura è sempre quella di avere oggetti d’amore che fingano di riempire la nostra vita. E poi ho pensato: anch’io non sono perfetta, forse possiamo aiutarci.
Veniva da una buona famiglia, suo padre era il proprietario di un’azienda informatica, una delle molte che erano sorte a Roma in quegli anni, tanto da far pensare a una «Silicon Valley» in miniatura, lui era progettista in questa azienda e questo un po’ mi tranquillizzò.
Cominciammo a uscire. Lui si mostrò subito geloso di mia figlia e del mio passato. Mi allontanò dalla mia bambina. La mia famiglia cominciò a preoccuparsi e mi consigliò più volte di lasciar perdere, perché era un mezzo pazzo. Mia madre, con cui ero tornata ad abitare (non ce la facevo a pagare tutto da sola), diceva che era un pazzo intero e non lo voleva in casa.
La sera lui insisteva a rimanere, anche contro la mia volontà. Ogni volta era una storia, io lo cacciavo e lui tornava. Qualche volta ho dovuto far intervenire i carabinieri. Mia madre non si sentiva più sicura in casa sua e lui mi propose di seguirlo, se volevo vivermi questo amore che lei osteggiava. E fu allora che mi scavai la fossa da sola. Cominciammo a girovagare da una casa all’altra. La cosa peggiore fu che con lui cominciai a bere. Intanto mia madre mi aveva tolto la bambina, nel senso che la teneva lontano da me e questo mi faceva sentire terribilmente in colpa, come del resto mi sento tuttora.
Dopo molti mesi mi accorsi che quella di Manfredi non era stranezza. Era psicopatia vera e propria. Aveva l’abitudine violenta di accendere fuochi, mettendo a rischio la vita degli altri e la mia. La sua storia era finita sui giornali mesi prima, e lui continuava a fare simili gesti sconsiderati. Decisi di lasciarlo, e lui cominciò a perseguitarmi. Prima mi inseguiva dappertutto, con minacce e parolacce, poi fece di peggio. Mandava i vigili del fuoco ogni giorno nel mio ufficio: con una telefonata anonima chiedeva il loro intervento. Ovviamente il mio ufficio non correva nessun rischio di incendio, lui voleva mettermi in cattiva luce e farmi licenziare. Fui costretta a parlarne con i miei superiori e a denunciarlo. La questura lo convocò e tutto finì lì. Non si presta mai abbastanza attenzione all’incolumità delle donne e dei bambini. Credo che la cosa lo lasciò indifferente, anzi poi fu lui a denunciarmi. Di che? Ancora ora me lo chiedo. Intanto continuò a perseguitarmi con telefonate e appostamenti di ogni tipo. Fu un periodo davvero terribile per me: vivevo sotto un incubo, non riuscivo a liberarmi, mia figlia era andata a vivere definitivamente da mia madre. Mi sentivo spossata, indifesa. Dove avevo sbagliato? E perché quell’uomo malato si attaccava a me come alla carta moschicida, con ogni sorta di provocazione e meschinità?
Da qualche mese le sue azioni di disturbo si sono di molto attenuate, solo qualche improperio al telefono di tanto in tanto, giusto per mantenersi in esercizio. Si può dire che sta cominciando a lasciarmi in pace. Chissà, ora il suo obiettivo è un altro, c’è un’altra vittima dall’altra parte della città sulla quale ha gettato la sua rete asfissiante.
Io ho ancora paura che la sua ossessione possa tornare. Proprio l’altro ieri ho letto sul giornale di un misterioso incendio di stoppie dalle parti di quella che fu la «Silicon Valley» romana...
![]()
Quando si è uomini mediocri l’unico modo per fare carriera è quello di indulgere al servilismo o di attentare alla dignità di quelli che ti stanno vicino. Cogliere il più indefinibile dei loro momenti di defaillance, i loro errori più ingenui, e amplificarli, ingigantirli. Lui conosceva perfettamente l’arte del trovare pagliuzze nell’occhio degli altri. E questa la integrava grottescamente con la tattica della delazione, del riferire ai potenti, ai più forti le pecche dei suoi pari in fragilità e sottomissione.
Tutta la sua carriera l’ha fatta così, facendo lo spione ai capi e additando le mancanze altrui: quello non è venuto a lavorare, quell’altro perde tempo a chiacchierare, quell’altro parla male di lei, Signor Direttore.
È un uomo pieno di rabbia e di crudeltà. Dietro il suo viso rotondo, spento e compatto come un globo di polistirolo, si nasconde una mente mostruosa, piena di invidia e di rancore. I fantasmi che l’assalgono spesso sembrano vivere al posto suo. Avvitano i nervi, li torcono e ne viene fuori un accesso di ira che fa tremare chi gli sta vicino e fa sbiancare i volti dei suoi sottoposti.
Ho visto tanta gente temerlo. Anche i più famosi, i più preparati, i migliori temevano quel mostro arrivato lì solo perché utile alla causa di altri uomini potenti con i quali continuava a essere servile, riverente, viscido.
Anche durante una telefonata strepitante di urla e di improperi volgari, grotteschi, incredibili a dirsi, era capace di interrompersi immediatamente, di spegnere tutto d’un tratto la macchina indifferente dell’ira e sospirare subito a bassa voce e con grande fretta: «Devo andare, devo andare, c’è il Direttore».
Alcune volte ero andata a trovarlo nella sede centrale. Ricordo che un giorno appena la porta dell’ascensore si aprì avvertii un certo tumulto nell’anticamera che dava sulla sua stanza e su quella della sua segretaria.
Sentii un boato. Un rumore sordo e compatto intervallò le urla lanciate a un funzionario di un ministero. «Dovete fare quello che diciamo noi... No, non ci siamo capiti» e poi un rumore di oggetti. Sembrava che avesse preso le suppellettili della sua scrivania e le avesse scaraventate a terra. La conversazione continuava. Il ritmo era sincopato come se neppure lui capisse davvero quello che diceva.
Poi sentii un altro tonfo, stavolta come di ferraglie, culminante in uno sfracasso totale che accennava a un lievissimo rimbalzo. Era certamente un computer.
Ma come, dissi tra me e me, rompe un computer per un semplice scatto di rabbia? Ma questo è proprio matto.
Ma come è possibile che sia arrivato così in alto? Che abbia in mano le sorti di così tanti progetti e di così tante vite?
All’inizio non mi era sembrato così svitato. Anzi mi sembrò affabile e gentile. Io ero una ragazza studiosa, che si era laureata brillantemente e coltivava il suo piccolo sogno nel cassetto. Lavorare a un programma televisivo. Nell’ombra, dietro le quinte. Non mi importava assolutamente diventare famosa, condurre, apparire. Decisi di iscrivermi a un master in telecomunicazioni. Alla fine delle lezioni era previsto uno stage. Avevo studiato tanto e con profitto. Gli insegnanti erano entusiasti di me. Mi avevano più volte segnalato ai responsabili dell’azienda. Ma come al solito – è noioso ripeterlo ma è vero – fu un vero choc scoprire che senza un aiutino non avrei potuto neppure sperare nel più umile e semplice dei lavori.
Vivevo un momento di totale melanconia vicino alla resa.
Alcuni colleghi interni al master mi fecero sapere di una presentazione in una libreria romana vicino alla Camera dei Deputati. Non sapevo ancora che lui ne frequentava molte. Aveva il pallino di diventare uno scrittore. Gli ero seduta vicino durante la presentazione. Cominciò a discutere con me del valore di quel volume e del suo autore. Me ne parlò pieno di stizza confidandosi come se fossi stata una sua amica di vecchia data. Il suo era in realtà un monologo, un monologo con se stesso, fatto per compiacere se stesso e gettare fango sugli altri. Ma io a quel tempo non ero ancora così smaliziata e allora fui attirata più dalla confidenza e da quell’aria di uomo navigato che sapeva molte cose.
Mi chiese chi fossi. E una volta appreso il mio percorso gli si illuminarono gli occhi. Si propose di aiutarmi, nella sua azienda. Sua? Capito? Proprio così. Come se fosse un suo feudo e non una azienda con il dovere di valorizzare le professionalità di tanti italiani capaci.
Non mi disse che era sposato, lo scoprii io. Ci vedevamo all’ora di pranzo in mensa. Così non doveva nemmeno spendere un euro per invitarmi. Mi offrì di fare la figurante con diritto di parola. Mi dovevo alzare prestissimo. Era ancora notte quando la sveglia suonava e io ancora intorpidita dal sonno mi scaldavo una tazza di latte prima di intraprendere il mio lungo viaggio dalla Ostiense. Una volta arrivata in studio mi truccavo per bene. La programmista veniva da me per indicarmi le cinque parole che dovevo mettere una dietro l’altra per guadagnarmi i miei 40 euro a puntata.
Mi annoiavo moltissimo. Praticamente dovevo applaudire e sorridere. E non erano mancate le volte che la telecamera mi aveva sorpresa mezza assonata con le palpebre socchiuse. Mentre suonava la sigla mi arrivò una sua telefonata: Come ti sei permessa! Ma cosa ti credi di essere una star? Guarda che c’è la fila per prendere il tuo posto! Ho una lista di segnalazioni che mi arrivano da ogni parte per quel ruolo. E tu ti consenti perfino di dormire in trasmissione. Ci hanno visti insieme, guarda che non puoi consertitelo, l’azienda è una cosa seria, non stai lavorando a TeleMarket. E non sei nessuno, sei solo una laureata in cerca di lavoro.
Mi disse di raggiungerlo in sede. Uscii dall’ascensore tremando e quando entrai nel suo studio lui mi guardava serio in silenzio. Venne a chiudere la porta.
Fu a quel punto che mi misi a ridere, ma dentro di me. Che bisogno c’era di chiudere la porta se poi urlava così ad alta voce e si agitava in modo talmente schizzato che chiunque, ma proprio chiunque, poteva udirne i deliri, le arrabbiature, i colpi che dava.
Sembrava come un animale in trappola che cercasse di liberarsi in tutti i modi dalla presa divincolandosi con tutti i suoi arti. Digrignando i denti. Scuotendo il capo. Roteando le braccia. Dando colpi impazziti e a vuoto con la coda, sì, sembrava possedere una coda come quella di un coccodrillo mentre era in quello stato di follia mostruosa.
Mentre ero sovrappensiero e me lo figuravo in quella foggia animalesca, lui si raddolcì. Mi disse che ero la sua topa, così mi chiamava, in modo anonimo e senza suscitare in me nemmeno un briciolo di entusiasmo. Non sapeva usare parole più romantiche. Quello che voleva era solo sfogare la sua morbosità sessuale su di me. In verità quell’uomo affabile e sicuro di sé che avevo visto in una libreria romana e che aveva velleità di scrittore era un uomo ignorante, viscido, megalomane e frustrato. In più era uno sporcaccione e un grande, machiavellico bugiardo.
Ricordo quando scoprii che era sposato e da molti anni. Gli feci una scenata e lui cominciò a urlarmi che ero pazza.
Alla fine cedette e ammise che sì, aveva una moglie, ma che la detestava con tutto se stesso e sognava di eliminarla con tutta la sua famiglia.
Faceva la vittima, diceva che lei era una donna molto aggressiva, non molto intelligente, noiosa, e che non se la scopava da anni.
Per me fu un colpo: capii perché mi erano vietate le uscite serali. Mi domandavo perché resistevo, perché non riuscivo ad abbandonarlo al suo destino. La risposta era semplice e disarmante: speravo di restare nel giro della televisione e trovare altre strade, altri agganci.
Cominciai a trattarlo per quello che si meritava. Lo sfruttavo. Finché potevo. Era talmente mostruoso e anaffettivo che sapevo di non avere in lui tantissimo ascendente, e che la mia presa poteva vanificarsi all’improvviso e in qualsiasi momento. Per farsi perdonare la menzogna sulla moglie, mi fece avere un lavoro. Mi ritrovai con un contratto di consulente a un programma pomeridiano pagato 80 euro a puntata. Nemmeno i soldi per pagare le esosissime tasse imposte a chi doveva aprirsi una partita Iva. Dall’altra pare lui si manteneva saldo nella sua posizione di potere, abituato a obbedire ai capi, a essere arrogante con i deboli.
La moglie mi faceva pena, poveretta, con quel marito! E mi facevo compassione io stessa, obbligata ai suoi orari e alle sue scenate. Era il maschio più maschilista che conoscessi e anche il più squallido. Aveva invidia per la mia giovinezza e una spiccata tendenza al sadismo. Era felice solo quando poteva sottomettermi e farmi male, fisicamente.
Un giorno venne negli studi e in redazione. Io avevo un copione da consegnare. Mentre mi aggiravo per i larghissimi corridoi che portano ai camerini dei conduttori, lo vidi maltrattare in modo disumano gli autori del programma: «Siete delle merde, lo avete capito? Voi non valete nulla nei confronti di queste donne. Voi siete solo al loro servizio e dovete fare quello che vi viene detto. Se non la rispettate sospendo il programma, avete capito?».
Erano persone adulte, veri professionisti. E si erano visti lanciare contro una invettiva orrenda e mortificante solo perché una soubrette si era andata a lamentare con lui per le continue angherie che doveva subire. Un vero mobbing a detta sua che le impediva di crescere e di avere una presenza vera e costante in tutta la trasmissione.
La sera gli chiesi conto di quella scenata. Gli dissi timidamente che non era strategico per la s...