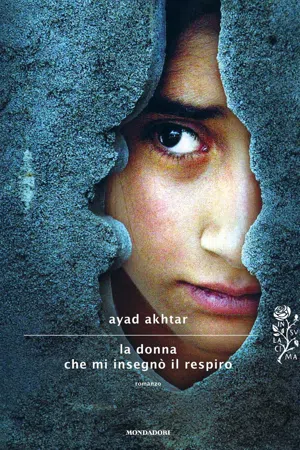![]()
![]()
Fu un inverno disperato e silenzioso quello che seguì la mia scoperta di Mina allo specchio del bagno. Lei mantenne un atteggiamento gelido per settimane, per mesi; la stanchezza dopo le lunghe giornate di lavoro le forniva la scusa per evitare il nostro studio coranico. Il tempo che ci accadeva ancora di passare insieme non era più come prima, turbato com’era da un disagio di cui entrambi conoscevamo fin troppo bene l’origine. Rimpiangevo l’accaduto. Pregavo Dio di poter cancellare dalle nostre menti il ricordo di quella notte. E le preghiere non furono l’unica forma di pensiero magico alla quale ricorsi. Dopo aver letto in una delle riviste di Mina un articolo nel quale si sosteneva che ognuno di noi si fabbrica con i pensieri la propria vita – soprattutto in base a ciò che scegliamo di ricordare – cercai di modificare il ricordo di quella notte. Me ne restavo nel letto a immaginare tutto da capo: i rumori nel corridoio che avevano attirato la mia attenzione, però questa volta non mi alzavo a controllare, e quando talvolta immaginavo di alzarmi finivo per trovare Mina in pigiama, intenta a lavarsi i denti, che mi guardava sorridendo dallo specchio. Secondo l’articolo, se fossi riuscito a immaginare una fine diversa della scena forse avrei dimenticato l’accaduto.
Ma non funzionò. L’immagine delle sue forme perfette non se ne andava mai dalla mia mente e si insinuava nella coscienza come fa il fumo di un incendio che non vuole saperne di spegnersi.
Allora provai un’altra strategia. Se vedere le sue parti intime era così sbagliato, ipotizzai, avrei smesso di guardare anche le mie. Una conclusione basata su un sillogismo a cui arrivai senza sforzo e che mi diede uno strano sollievo:
1. Vedere la sua nudità era sbagliato.
2. Dunque la nudità era sbagliata.
3. Ne conseguiva che la mia nudità era sbagliata.
Adesso in bagno stavo attento a non abbassare lo sguardo mentre espletavo le mie funzioni corporali. Imparai a svolgere le abluzioni rituali senza dare nemmeno un’occhiata. E persino sotto la doccia facevo sempre in modo di non guardare mai quel che avevo tra le gambe.
Raddoppiai gli sforzi coranici e fu allora che cominciai seriamente a impegnarmi per diventare un hafiz. Mi sembrava l’unico modo certo per riconquistare l’amore e l’attenzione di Mina. E non mi sbagliavo. La diligenza con cui memorizzavo i versetti finì per vincere la sua resistenza, ed entro primavera – sette sure e un centinaio di versi più tardi – le nostre lezioni ripresero con regolarità. Tornò a chiamarmi kurban. Mi sembrava che avesse finalmente dimenticato i fatti di quella notte di dicembre. Io però ricordavo. Ora sapevo che potevo perdere il suo amore. Ed ero pronto a fare qualsiasi cosa perché non si ripetesse mai più.
A primavera inoltrata, trascorso poco più di un anno da quando Mina e Imran erano venuti a vivere con noi, un giovedì sera eravamo tutti seduti intorno al tavolo della cucina. Papà, mamma e Mina bevevano il tè leggendo il quotidiano della sera e scambiandosene le pagine. Imran e io coloravamo le figure con una sfilza di pastelli rotti. A un certo punto la mamma alzò gli occhi dal giornale.
«Dicono che ci sarà il sole nel weekend, e che la temperatura arriverà a ventiquattro gradi» annunciò con entusiasmo. «La prima giornata di clima estivo. Perfetta per un barbecue, dicono.»
«È così che dicono?» borbottò papà alzando di qualche centimetro le pagine economiche del giornale per nascondervisi dietro.
Mamma si rivolse a Mina. «Potremmo preparare shaami kabab e zenzero marinato per il pollo. Potremmo fare un sacco di roba. E invitare tantissima gente! Per celebrare l’arrivo della nuova stagione... Che cosa ne diresti, Naveed? Hmm? Facciamo sabato?»
La domanda rimase sospesa nel silenzio.
Papà abbassò il giornale quanto bastava per guardare al di sopra della pagina. Aveva un’espressione vaga. «Sei tu che devi preparare il cibo. Io mi limito a metterlo sulla griglia. Se vuoi organizzare un grande barbecue, accomodati pure.»
«Però devi invitare qualcuno anche tu.»
«D’accordo» disse lui riprendendo a leggere.
Mamma non era convinta. «Naveed, guardami quando ti parlo.»
«Che c’è, Muneer?» chiese lui infastidito. «Che cos’è che vuoi da me, eh? Perché non puoi berti il tè in pace e goderti la vita, una volta tanto?»
«Non farmi la paternale.»
«Non ti sto facendo la paternale.»
«Ti ho fatto una domanda. Voglio che inviti qualcuno anche tu.»
«Ho detto che l’avrei fatto.»
«A chi pensavi?»
«Inviterò Nathan.» Nathan Wolfsohn era il collega ricercatore con cui papà lavorava all’University Medical Center, e in molti modi anche il suo migliore amico.
«Bene. E poi?»
«Chi altri vuoi che inviti?»
«I Naqvi, i Khan, i Buledi... e perché non i Chatha?»
Parlava delle famiglie pachistane sparse per tutta la Grande Milwaukee, persone che non vedevamo quasi mai perché mio padre le detestava. Le chiamava pecore, sosteneva che si riunissero come animali in un branco per evitare di ammettere il fatto di non essere più in Pakistan. Trovava particolarmente irritanti le loro continue lamentazioni sull’empietà della vita americana. Non riusciva a capire che cosa ci facessero ancora qui, se giudicavano tutto così malvagio.
«I Chatha?» chiese incredulo.
«Perché no?»
«Perché no?»
«Sì. Perché no, Naveed?»
Lo punzecchiava, sapendo benissimo che lui disprezzava Ghaleb Chatha, farmacista e imprenditore originario del Pakistan, proprietario di una catena di farmacie in espansione che portava il suo nome e, grazie alla sua immensa ricchezza, indiscusso fulcro della comunità musulmana locale. Dietro le insistenze di mamma, qualche anno prima avevamo frequentato i Chatha, andando a cena da loro in occasione di alcune feste religiose, invitandoli una volta da noi, ma non ne era nata alcuna amicizia. Papà non sopportava la religiosità di Chatha, comunicata non solo attraverso il suo aspetto: zucchetto, barba islamica squadrata, un soprabito alla Nehru all’altezza del ginocchio che non si toglieva mai, ma anche tramite la sua conversazione. A Chatha piaceva parlare di quello che Dio avrebbe fatto agli americani miscredenti il Giorno del Giudizio: «Allah li rigirerà in questo modo» scherzava, girando il palmo della mano sopra e sotto come se fosse una polpetta nel tegame. «Li friggerà esattamente come uno dei pesci delle loro fritture del venerdì in chiesa!» E se il disprezzo di Chatha per i miscredenti non fosse bastato a mal disporre mio padre nei suoi confronti, c’era anche il fatto che Najat, la moglie, una donna laureata, indossava il burqa intero in pubblico, completo della stoffa traforata che le schermava il volto.
«Lo so che non ti piace» disse la mamma facendo marcia indietro davanti all’occhiata furibonda di papà. «Però sei tu che non fai che ripetere quant’è importante la diplomazia, se si vuole ottenere il successo... Cosa ne dici di seguire il tuo consiglio e fare uno sforzo? E poi puoi dire quello che vuoi di lui, ma Najat rimane una bellissima persona.»
«Bellissima? Come fai a saperlo? L’hai mai vista in faccia?»
«Certo che l’ho vista.»
«Sei una delle poche fortunate» ribatté lui. «Che barbarie» borbottò fra sé tornando a leggere.
«Chi è Chatha?» chiese Mina.
«Il farmacista di cui ti ho parlato» rispose la mamma. «Quello con il cugino divorziato, ricordi?»
Mina non sembrava ricordare.
«Quello che aveva una moglie che è scappata con un americano...»
«Oh» fece Mina annuendo.
«Un ipocrita, ecco cos’è» disse papà.
«Qualsiasi cosa sia o non sia, Chatha è il cuore della comunità» disse lei categorica. «Non mi stupisce che non abbiamo più amici della nostra terra. Non facciamo nessuno sforzo.»
«Tu puoi fare quello che ti pare. Chiamali. Non hai bisogno di me.»
Mamma gettò un’occhiata a Mina e poi a me. Sembrava sorpresa e compiaciuta: papà cedeva inaspettatamente terreno. Dopo una pausa riattaccò in tono dolce e suadente: «Ma se chiami tu, Naveed... penseranno che stiamo muovendo cielo e terra. “Come, il dottor Shah ci invita a un barbecue da loro? Non possiamo perdercelo!”».
«Improbabile, Muneer. A quella gente non piaccio. E non gli piaci neanche tu, fra l’altro...»
«Magari non gli piaci, però ti ammirano. Tutti ti ammirano. Persino Chatha. Sei il più brillante di tutti e lo sanno.» Era strano sentirla adulare mio padre così, comunque sapeva quello che stava facendo, perché infatti lui si ammorbidì visibilmente.
«D’accordo» cedette infine. «Li chiamerò.»
Lei si rivolse radiosa a Mina. «Anche tu. Fai venire qualche amica del salone.» Si riferiva al salone di bellezza dove ora Mina lavorava quattro giorni alla settimana, e dove aveva già guadagnato abbastanza per comprarsi una berlina Dodge di seconda mano.
«Inviterò Adrienne.»
«È quella grassa?»
«Bhaj» la ammonì Mina. «È una brava persona. Dice solo cose gentili su di te.»
Mamma sorrise con un’aria spensierata, sottintendendo che se avesse saputo che Adrienne parlava bene di lei non avrebbe detto quello che aveva detto, pur continuando a pensarlo. «Be’, invita anche qualche altra amica... non solo Adrienne.» Si rivolse di nuovo a papà. «E tu non dimenticare di dirlo a Nathan.»
Lui bofonchiò qualcosa.
«Mi hai sentito, Naveed?»
«Come potrei non sentirti?» rispose lui con voce monotona. «Ti ho già detto che lo inviterò.»
«Allora lo farai?»
«Se me ne ricorderò.»
«È un’anima tanto gentile e intelligente! Perché non esercita la sua buona influenza su di te, Naveed?»
«Muneer...» fece lui con voce ferma.
«Vado, vado» rispose lei in tono conciliante, mentre si alzava dal tavolo e lanciava un’occhiata all’orologio sopra il fornello.
«Sono le sette e mezzo» mormorò fra sé e sé. «Non è ancora troppo tardi per fare qualche telefonata.»
E si mise in moto.
Quello che mi ha sempre colpito di Nathan Wolfsohn era che non sembrava così basso di statura come era in effetti. Un metro e sessantacinque o poco più, con le spalle strette e la piccola testa coperta di riccioli biondo-rossicci, accanto a papà – alto e dalle larghe spalle, una delle qualità che l’avevano attirata di lui, diceva sempre mia madre – avrebbe dovuto sembrare un nano e invece non era così. Benedetto da un calore e una espansività che si intuivano subito dall’allegro bagliore nei suoi occhi, Nathan era un uomo dalla mentalità molto aperta, dotato di un’intangibile generosità che secondo me lo faceva sembrare più grande di quel che era.
A soli ventotto anni Nathan era una specie di enfant prodige della medicina, specialista di una nuova tecnologia nota come Mri. Era stata di mio padre l’idea di coinvolgerlo in una ricerca sull’utilizzo della risonanza magnetica con i cervelli dei pazienti in cura con farmaci antidepressivi, e nel giro di pochi anni il loro lavoro li aveva catapultati nelle prime file della ricerca in campo neurologico. A papà piaceva dire che erano due “pionieri”, definizione che tuttavia Nathan non gradiva. Ricordo che in una serata in una pizzeria del centro, poco lontana dal loro laborat...