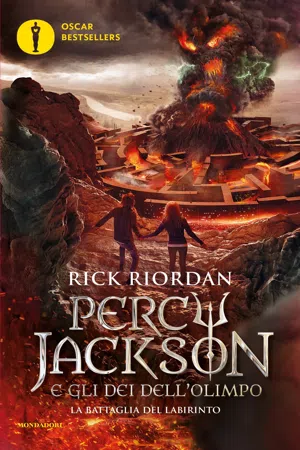L’ultima cosa che desideravo per le vacanze estive era far saltare in aria l’ennesima scuola. E invece eccomi lì, un lunedì mattina dei primi di giugno, seduto nella macchina di mia madre davanti alla Goode High School, sulla Ottantunesima Est.
La Goode era un grosso edificio di pietra bruna affacciato sull’East River, con un sacco di BMW e di Lincoln parcheggiate davanti. Guardando l’elaborato arco di pietra dell’ingresso, mi chiesi quanto ci avrei messo a farmi buttare fuori anche da lì.
«Rilassati.» Mamma non sembrava rilassata. «È solo una visita di orientamento. E ricorda, caro: è la scuola di Paul. Cerca di non… hai capito.»
«Distruggerla?»
«Sì.»
Paul Stockfis, il fidanzato di mia madre, era fuori ad accogliere i futuri studenti che salivano le scale. Con i capelli brizzolati, la camicia, i jeans e la giacca di pelle mi ricordava un attore della tv, ma era soltanto un professore di inglese. Era riuscito a convincere la Goode High School ad ammettermi al primo anno, trascurando il fatto che mi avessero espulso da ogni singola scuola che avessi mai frequentato. Io avevo provato a dissuaderlo, ma lui non aveva sentito ragioni.
Guardai mamma. «Non gli hai detto la verità su di me, vero?»
Lei tamburellò con le dita sul volante, un po’ nervosa. Si era messa in tiro per un colloquio di lavoro e indossava il suo migliore completo blu e le scarpe con i tacchi alti.
«Ho pensato che fosse meglio aspettare» ammise.
«Così non lo spaventiamo.»
«Sono sicura che l’orientamento andrà bene, Percy. È solo una mattinata.»
«Fantastico» borbottai. «Posso farmi espellere prima ancora di cominciare l’anno.»
«Pensa positivo. Domani parti per il campo! E nel pomeriggio hai il tuo appuntamento…»
«Non è un appuntamento!» protestai. «È solo Annabeth, mamma. Ma figurati…»
«Viene qui dal campo apposta per te.»
«Be’, sì.»
«Andate al cinema.»
«Sì.»
«Voi due soli.»
«Mamma!»
Alzò le mani in segno di resa, ma vidi benissimo che si stava sforzando di non sorridere. «Sarà meglio che entri, caro. Ci vediamo stasera.»
Stavo per scendere dalla macchina, quando lanciai uno sguardo verso l’ingresso. Paul Stockfis stava dando il benvenuto a una ragazza con i capelli rossi e crespi, una maglietta bordeaux e un paio di jeans strappati pieni di disegni fatti col pennarello. Quando si voltò, intravidi il suo viso e mi si drizzarono i peli sulle braccia.
«Percy?» mi chiese mamma. «Qualcosa non va?»
«N-niente» balbettai. «Ci sarà un ingresso laterale?»
«In fondo alla strada a destra. Perché?»
«A dopo.»
Lei fece per parlare, ma io scesi dalla macchina e corsi via, sperando che la ragazza con i capelli rossi non mi vedesse.
Che ci faceva lì? Una sfortuna del genere era troppo anche per me.
Ah, giusto. Stavo per scoprire che alla mia sfortuna non c’erano limiti.
L’idea di entrare di soppiatto non funzionò granché. Due cheerleader con le uniformi bianche e viola picchettavano l’ingresso laterale, tendendo imboscate alle matricole.
«Ciao!» Mi sorrisero e io pensai che quella era la prima e l’ultima volta che una cheerleader era tanto espansiva nei miei confronti. Una era bionda, con gli occhi azzurro ghiaccio. L’altra era un’afroamericana con i capelli ricci e scuri come quelli di Medusa (e, credetemi, so di cosa parlo). Entrambe avevano il nome ricamato in corsivo sull’uniforme ma, con la dislessia che mi ritrovo, mi sembravano più degli spaghetti che delle parole.
«Benvenuto alla Goode» esclamò la bionda. «Ti piacerà tantissimo.»
Ma mentre mi squadrava dalla testa ai piedi, la sua espressione diceva più qualcosa tipo: “Bleah! Ma chi è questo sfigato?”.
L’altra ragazza mi si avvicinò, mettendomi in imbarazzo. Studiai il ricamo sulla sua uniforme e decifrai KELLI. Profumava di rose e di qualcos’altro, qualcosa che conoscevo dalle lezioni di equitazione al campo: era l’odore dei cavalli appena lavati. Strano, per una cheerleader. Forse aveva un cavallo o roba del genere. Comunque, mi si era piazzata davvero vicino ed ebbi la sensazione che stesse per buttarmi giù dalle scale. «Come ti chiami, branzino?»
«Come?»
«Come ti chiami, primino?»
«Ehm, Percy.»
Le ragazze si scambiarono uno sguardo.
«Oh, Percy Jackson» disse la bionda. «Ti aspettavamo.»
Oh-oh. Un brivido mi percorse la schiena. Stavano bloccando l’ingresso e sorridevano in modo non troppo amichevole. D’istinto, avvicinai lentamente la mano alla tasca, dove custodivo la mia micidiale penna a sfera, Vortice.
Poi dall’interno dell’edificio giunse un’altra voce: «Percy?». Era Paul Stockfis, da qualche parte nel corridoio. Non ero mai stato così felice di sentirlo.
Le ragazze si fecero indietro. Ero talmente ansioso di superarle che andai a sbattere inavvertitamente con il ginocchio sulla coscia di Kelli.
Clang.
Un suono metallico, cupo, salì dalla sua gamba, come se avessi colpito un palo.
«Ahi» brontolò lei. «Sta’ attento, branzino.»
Abbassai lo sguardo, ma la gamba di Kelli mi sembrò normalissima. Ero troppo spaventato per fare domande. Mi precipitai in corridoio, con le cheerleader che mi ridevano dietro.
«Eccoti qua» esclamò Paul. «Benvenuto alla Goode!»
«Ehi, Paul… ehm, signor Stockfis.» Mi lanciai un’occhiata alle spalle, ma quelle strane ragazze erano scomparse.
«Percy, sembra che tu abbia appena visto un fantasma.»
«Già, ehm…»
Paul mi diede una pacca sulla schiena. «Ascolta, so che sei nervoso, ma non ti preoccupare. Abbiamo un sacco di ragazzi dislessici e iperattivi, qui. Gli insegnanti sanno come aiutarti.»
Mi veniva quasi da ridere. Magari la dislessia e l’iperattività fossero state le mie maggiori preoccupazioni! Cioè, sapevo che Paul stava cercando di aiutarmi, ma se gli avessi rivelato la verità sul mio conto, le possibilità erano due: o mi avrebbe preso per pazzo, o sarebbe scappato a gambe levate. Quelle cheerleader, per esempio… mi davano una brutta sensazione.
Poi guardai in fondo al corridoio e ricordai di avere anche un altro problema. La ragazza con i capelli rossi che avevo visto sulle scale stava attraversando l’atrio.
“Non mi notare” pregai.
Mi notò. E sgranò gli occhi.
«Dove si tiene l’orientamento?» chiesi a Paul.
«In palestra. Da quella parte. Però…»
«Ciao.»
«Percy!» chiamò lui, ma io stavo già correndo.
Pensai di averla seminata.
Un gruppetto di ragazzi si stava dirigendo in palestra e ben presto mi confusi in mezzo agli altri trecento quattordicenni stipati sulle gradinate. La banda suonava l’inno della scuola, ma era talmente stonata che somigliava a un coro di gatti chiusi in un sacco e pestati con una mazza da baseball di metallo. Dei ragazzi più grandi, probabilmente membri del consiglio studentesco, si pavoneggiavano in prima fila con l’uniforme scolastica e l’aria da: “Ehi, siamo i migliori”. Gli insegnanti circolavano elargendo sorrisi e strette di mano. Le pareti della palestra erano tappezzate di striscioni bianchi e viola con su scritto: BENVENUTE, FUTURE MATRICOLE. LA GOODE È GARANZIA DI QUALITÀ. SIAMO TUTTI UNA FAMIGLIA, e un mucchio di slogan sdolcinati che mi diedero la nausea.
Neanche le altre matricole sembravano molto contente di essere lì. Partecipare a una giornata di orientamento a giugno, quando la scuola non comincia prima di settembre, non è il massimo. Ma alla Goode “ci prepariamo presto all’eccellenza!”, o almeno così diceva il pieghevole pubblicitario.
La banda smise di suonare. Un tizio con un vestito gessato si avvicinò al microfono e iniziò a parlare, ma in palestra c’era l’eco e non si capiva nulla. Tanto valeva che si mettesse a fare i gargarismi.
Qualcuno mi afferrò per una spalla. «Che ci fai qui?»
Era lei: il mio incubo dai capelli rossi.
«Rachel Elizabeth Dare» dissi.
Lei rimase sbigottita, come se non riuscisse a credere che avessi il coraggio di ricordarmi il suo nome. «E tu sei Percy non so cosa. Non ho capito il tuo cognome quando hai cercato di uccidermi, a dicembre.»
«Senti, io non… non… e tu che ci fai qui?»
«Quello che fai tu, immagino. La visita di orientamento.»
«Abiti a New York?»
«Perché, pensavi che abitassi sulla diga di Hoover?»
Non ci avevo mai riflettuto. Tutte le volte che pensavo a lei (e non sto dicendo che pensavo a lei, ma solo che ogni tanto mi passava ...