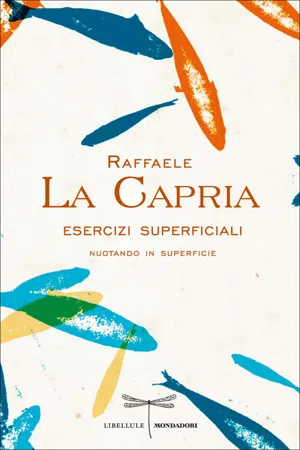![]()
![]()
Quale popolo ama parlar male di sé, autodenigrandosi appassionatamente, più del popolo italiano? E in quale popolo il sentimento della patria è meno orgogliosamente esibito fino al punto di mostrare una certa riluttanza a cantare l’inno nazionale nelle pubbliche manifestazioni (per esempio in una partita internazionale di calcio)? E non abbiamo spesso letto sui giornali dichiarazioni come “mi vergogno di essere italiano” fatte con supponenza e quasi con vanto? L’Italia è un paese che non si ama, e ci sono buone ragioni storiche (recenti e recentissime) per non amarsi. Meglio però sarebbe darsi da fare per migliorare con le opere e i comportamenti il sentimento verso il proprio paese e il suo buon nome, perché dopotutto ci conviene. Nell’Europa delle patrie chi non ha una patria diventa vittima delle patrie altrui, e queste sono ben determinate a difendere non solo l’onore, ma insieme anche i loro interessi economici e commerciali, come purtroppo si è visto.
Detto questo, quale paese è stato più genialmente “creativo” nel denigrarsi? Quale paese ha più genialmente capovolto il senso di questa autodenigrazione trasformandola in un’allegra benché impietosa, teatrale forma d’arte? E quale ironica e profonda cognizione di sé, radicata nell’anima popolare, ha prodotto tre archetipi, tre suoi rappresentanti, tre personaggi più veri di Arlecchino, Pinocchio e Pulcinella? Provenienti dal Nord, dal Centro e dal Sud del paese essi sono nati dalla prodigiosa fantasia del nostro popolo. Con quei tre è come se l’Italia si fosse guardata allo specchio non ignorando i propri vizi e difetti, e senza troppo moralizzarci sopra come è sua abitudine inveterata, ma obbedendo anche lei al motto: “Sii profondamente superficiale”.
Ma torniamo ai nostri tre campioni, agli italianissimi Arlecchino, Pinocchio e Pulcinella, il primo e l’ultimo maschere della commedia dell’arte, e a Pinocchio che non è una maschera ma è altrettanto rappresentativo.
Arlecchino con la sua veste dai molti colori (che sono in realtà toppe e rammendi) è simbolo della rappezzata Italia delle molte diversità, l’Italia delle cento città e dei mille paesini, dei numerosi dialetti e delle tante culture, l’Italia delle infinite opinioni contrastanti, l’Italia divisa e sempre impegnata in un feroce disaccordo con se stessa. E però, da un altro punto di vista, non è unico e meravigliosamente appariscente il vestito di Arlecchino? E non è unica e di colori splendida la lingua italiana, unica e unificante ancor prima di ogni unità politica? Non è unica e meravigliosamente multicolore la Natura, l’Arte e la Lingua del paese e la vivacità dei suoi abitanti? È vero, Arlecchino con le sue piroette nasconde l’astuzia e il finto ossequio verso l’eterno padrone, lo deride continuamente, e anche in questo rivela la natura servile degli oppressi dalla storia, una storia di cui è inconsapevole.
“Ahi serva Italia, di dolore ostello!” Fu la storia a renderla divisa e serva, e il vestito di Arlecchino viene da lì. Una storia secolare coi suoi cicli e le sue leggi del contrappasso, padrona ieri, serva oggi. Ma quando arrivarono i barbari l’Italia, come la “Grecia capta”, li vinse con la Commedia divina, col Canzoniere dell’Amore, con la Scienza Nuova di Vico e Galileo. Ed è su questo maestoso fondale che si muovono le maschere dell’eterna commedia all’italiana, e i nostri Arlecchino, Pinocchio e Pulcinella. L’Italia vinse i barbari con questa musica:
Voi che ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nudriva il core
in sul mio primo giovanile errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i sono.
L’Italia li vinse con la Bellezza. Cosa c’è di più bello di questa santa lingua unificante?
Arlecchino, a modo suo, fa parte di questa Bellezza. Col suo vestito, le sue piroette e la fame atavica che lo rende servile, egli danza la danza della vita. E Pinocchio, con tutti i suoi vizi ingenuamente scoperti e così visibili, pur non essendo una maschera ha lo stesso estro e la stessa danzante levità, perché è infantile, è intraprendente e pieno di desideri naturalissimi e non disdicevoli, come gli rimprovera il Grillo parlante. Il Gatto e la Volpe ci fanno capire quanto sia grande la sua ingenuità e quanto lui sia indifeso. Il suo naso è lungo, e appunto si vede, tutti si accorgono quando si allunga che Pinocchio sta dicendo una bugia, tranne lui. E però, povero Pinocchio, le prende sempre! Tutti si approfittano della sua sventatezza. E quando infine ammazza il Grillo parlante e mette a tacere il conformistico moralismo delle buone cause (e della superiore coscienza) a pensarci bene non ha torto, perché la sua è una rivolta contro un moralismo che nel nostro paese spesso è strumentale ed oppressivo. E infine Pulcinella, che viene dal profondo Sud, dagli inferi, che combatte col diavolo, con la Morte (e la uccide!!!), sempre perseguitato dalla fame divorante e guidato dall’istinto di conservazione, Pulcinella che dà mazzate e le prende di santa ragione, a tutto sopravvive perché lui è un “eroe di sopportazione”. E mentre Arlecchino può fingersi una lauta cena con pezzi di carta disposti come pietanze, Pulcinella è più impulsivo e non si permette queste raffinatezze, ha una natura ferina, e quando gli capita afferra con le mani gli spaghetti e si ingozza. Sa che non sono molte per lui queste occasioni.
Arlecchino, Pinocchio e Pulcinella sono l’Italia del popolo che si rappresenta, si denigra e si riscatta con la felicità che trasmette questo trio. Un’Italia del passato ma che oggi si può riconoscere dovunque. Tre personaggi ma anche “maschere”, che non si identificano cioè in tutto quello che dicono e che fanno perché recitano se stesse, perché hanno teatralizzato le loro debolezze e il loro slancio vitale. Uno sdoppiamento che solo le grandi civiltà si possono permettere.
Parlar male di sé, come facciamo noi italiani, può dunque avere molteplici e complicati risvolti, e può anche essere inteso come una terapia di chi sa di essere malato, ovvero anomalo, ma sa anche che alla fine ce la farà. E questo ci dicono Arlecchino, Pinocchio e Pulcinella.
![]()
“Ogni volta che riesco a comporre una frase ben concepita, ben calibrata e precisa in ogni sua parte, una frase salda e tranquilla nella bella lingua che abito, e che è la mia patria, mi sembra di rifare l’unità d’Italia e insieme di rendere omaggio al sublime lascito dei patrii numi.”
Non so sottrarmi al fascino che esercita su di me la lingua italiana, anche perché so quanto è difficile praticarla, ed è certo anche per questo amore della lingua che non capisco chi dice, come molte volte ho sentito: “Mi vergogno di essere italiano”.
Quando lo sento dire, alla mia disapprovazione si aggiunge un senso di ribellione. Ti vergogni? Ti vergogni di Leonardo, ti vergogni di Michelangelo? Di Caravaggio? Ti vergogni di Dante e di Petrarca, dell’Ariosto e di Leopardi? Di Galileo, di Vico, di Machiavelli? E quando senti la musica di Vivaldi, di Rossini, il brano di un’opera di Puccini, o Il coro dei Lombardi di Verdi, questa musica non ti dice niente? Non senti che essere italiano fa parte di tutto questo?
Dici che la mia è solo retorica e che tu ti vergogni del malcostume e di come funziona male la nostra democrazia? Allora te lo ripeto, datti da fare per migliorarla. Ma non dire che ti vergogni di essere italiano, perché così non la migliori, e sicuramente la peggiori. Essere italiano non riguarda solo la democrazia, il Risorgimento, e tutte le anomalie che puoi legittimamente criticare, ma è qualcosa che vale di più, qualcosa che supera le storture della nostra storia e le trascende.
Tu insisti nel dire che la mia è retorica. È retorica per te la lista dei Grandi che potrei allungare ben oltre quella che ho fatto? Non rappresenta l’Italia? L’Italia tutta, da nord a sud? E non esprime qualcosa di superiore, che si fonde in una comune idea di Bellezza che è solo nostra, di una Bellezza Italiana, diversa da ogni altra? Che abbiamo distribuito a piene mani in Europa e nel mondo? E quando te ne vai in giro per il nostro paese, al Nord come al Sud, non ti commuovono i luoghi e i paesaggi, le chiese e i monumenti? E quando entri in una delle cento città che sono in se stesse un’Opera d’Arte, o sono uniche, come Venezia, cosa provi? E le bellissime piazze che scopri arrivando da una stretta stradina e che ti si aprono all’improvviso in tutta la loro magnifica scenografia? Ti è mai capitato di trovare nella chiesa di un paesino un capolavoro eccelso, ricordato in ogni storia dell’arte? E le vestigia, le solenni rovine di Pompei, Paestum, il Foro, le testimonianze del passato che spuntano da ogni parte, non ti dicono nulla?
Lo Stato che non funziona e la nazione sempre divisa sono la conseguenza di una storia infelice, lo so, ma parallela a quest’altra che sto rivendicando, che anch’essa ha lasciato segni nelle cose e negli animi. I Grandi che ho nominato, quelli che hanno fatto l’Italia com’è, innalzando cupole e chiese, inventando l’opera buffa e il melodramma, si sono manifestati e rivelati al mondo quando, distratti dall’Italia del proprio tempo, si sono rifugiati nel sogno della propria Opera. Essi sapevano bene che l’Italia era una “nave sanza nocchiere in gran tempesta”, ma col tempo quello che crearono si rifletté sul paese tutto, gli ha dato un’anima, e Verdi per me vuol dire Italia.
Nel tempo delle guerre fratricide, quando Firenze era in lotta con Arezzo e Pisa con Siena, e dovunque i vicini combattevano il vicino, quando a ondate successive gli eserciti di Carlo VIII, di Luigi XII, di Francesco I portavano morte e desolazione in ogni luogo e i lanzichenecchi profanavano le chiese di Roma, loro, i Grandi Maestri, lavoravano solitari, e si direbbe appunto “distratti”, e davano così al nostro devastato paese la dignità che aveva perduto. E mentre il sangue scorreva fuori nelle strade – io immagino – Piero in San Francesco dipingeva la battaglia di Cosroe eternandola nella calma luce imparziale che lui stava scoprendo; e a Roma Michelangelo, disteso sul dorso, dipingeva un Adamo uscito dal suo pennello come dal dito di Dio.
Anche in anni non lontani, dopo la guerra e dopo le bombe, dalle rovine ancora fumanti nacque come per miracolo un nuovo modo di fare il cinema con Ladri di biciclette, Roma città aperta, Umberto D. e Rossellini, De Sica e i registi del neorealismo, svelarono al mondo qual era la vera Italia.
Questa è la storia d’Italia che io mi racconto... Tu dirai che è retorica. Ma l’Italia, per me, è un sentimento. Per me dire Italia, essere italiano, vuol dire tutto questo.
![]()
Molti modi di presentarsi ha la Bellezza e molti volti, ma il volto che l’Italia le ha dato è unico, e si distingue da tutti gli altri volti che la Bellezza assume altrove.
A volte quel volto lo riconosciamo, altre volte è più nascosto, è un sentimento che d’improvviso ci si rivela e diventa parte della nostra identità. Pensavo a tutto questo dopo aver letto un libriccino con la copertina rosa shocking di appena ventisei pagine, edito da Nottetempo. Il prezioso libriccino che contiene due poesie di Patrizia Cavalli si intitola La Patria, come la prima delle due poesie. Ed è questa che mi ha rivelato umilmente, e in modo per me finora inedito, poeticamente inedito, quel sentimento nascosto cui alludevo sopra, che fa parte di me, e che chiamo Patria.
Per parlarne non c’è altra possibilità che la citazione. Solo così tutto quello che ho detto finora sembrerà evidente, e anche inutile, perché tutto quello che si dice intorno all’ineffabile non può scalfirne la misteriosa ineffabilità.
Una volta letto l’inizio della poesia “Capita a volte”, dopo non si può non consentire: “Sì, è capitato anche a me, e solo ora so bene cos’era”.
Capita a volte
che hai un mezzo pomeriggio in una delle tante
belle città italiane di provincia.
Vai dove devi andare, non hai voglia
di fare la turista, e anzi scegli
stradine laterali, senza gente;
camminando t’imbatti in uno slargo
con una chiesa, di quelle un po’ neglette,
spesso chiuse; sei già in ritardo, ma guardi
la facciata che sonnecchia, e subito
i tuoi passi si allentano, si disfano,
si fanno trasognati finché non resti
immobile a chiederti cos’è
quel denso concentrato di esistenza
sorpresa dentro un tempo che ti assorbe
in una proporzione originaria.
Più che bellezza: è un’appartenenza
elementare, semplice, già data.
Ah, non toccate niente, non sciupate!
C’è la mia patria in quelle pietre addormentata.
Non è bello? Non è bellissimo? Non è detto in modo splendido ed essenziale?
Basterebbero pochi versi come questi a celebrare degnamente il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Ma questa perfezione non basta a Patrizia, le occorre anche l’aria, la stagione,
maggio, i primi giorni
quando aprile gli si è appena sciolto
dentro – giorni santi, stupefatti,
trasparente cielo fino di batista
che i nostri sensi accolgono adoranti,
incapaci di invocare un’altra luce
se non questa.
Lo slargo, la chiesetta, la patria in quelle pietre addormentata, maggio e i giorni santi, stupefatti... Tutto questo lascia anche noi stupefatti. Ci voleva così poco per toccare i nostri sensi? Quali sensi? Quali sensi dobbiamo mettere in moto?
gli altri, i clandestini, imprecisabili
per numero e per specie, e per i quali
tutti, io provo un grandissimo rispetto,
come dovrebbe ognuno.
Come dovrebbe ognuno che legge questi versi di Patrizia Cavalli.
![]()
Tra me e le canzoni napoletane i rapporti non sono stati sempre facili. Troppe volte mi ero lasciato andare, avevo confuso con quelle canzoni i miei sentimenti, e a volte avevo pensato che li suggerissero, che addirittura li sostituissero. Troppe volte le avevo considerate come una prigione sentimentale da cui dovevo liberarmi...
Io sono della generazione di Murolo, che oltre a cantarle le canzoni “le diceva”, faceva sentire l’armonia delle parole, la musicalità del verso, la poesia. Dietro quelle canzoni c’era non solo la voce dello chansonnier ma anche la voce del poeta, la voce di Di Giacomo, di Bovio, di Russo, di Nicolardi. Era una voce intima, mai troppo spiegata. E diceva a una farfalla (una “palomma”) che di notte si avvicina troppo alla fiamma di una candela: “Sta’ attenta sventatella, quella fiamma non è una rosa o un gelsomino, e se troppo t’avvicini ti brucerai le ali. Lo sai che anch’io sono stato abbagliato dalla fiamma e per allontanartene mi sono bruciato la mano?”. E tutto questo nel meraviglioso dialetto napoletano di Di Giacomo era irresistibile. Così com’era irresistibile quella “ferita d’ammore” che “nun se sana”, che non si può guarire mai, e che in ogni canzone si faceva sentire. Ecco, a queste canzoni e ai sentimenti che suscitavano, io fin dalla prima giovinezza mi abbandonavo. Non c’era niente che ne turbava l’armonia, anche quando dolente ne era il contenuto. Erano canzoni che si accordavano bene col paesaggio, col mare e con la bella giornata; tutto tornava, e i colori erano quelli di una gouache, dolci e azzurrini. Era quella l’immagine dominante, e per molto tempo quell’immagine è stata consolatoria, e chi partiva per terre assai luntane la riempiva di nostalgia: “Santa Lucia / luntan’ a te / quanta malincunia...”. Quell’immagine girava per il mondo e “o sole mio” lo illuminava. Quell’immagine era più forte della realtà, era la realtà, era Napoli.
E poi... Giorni fa sono andato in un cinema a vedere il film Passione di John Turturro, e le cose sono cambiate. Sono andato, e ho visto, ho sentito, che Napoli era un’altra, un’altra la sua canzone. Lo spirito con cui a Napoli si cantava era cambiato, non era più quello intimo e delicato della “palomma” notturna, e neppure quello consolatorio dell’armonia e della nostalgia, ma era pura sconsolata energia. Il film di Turturro non era proprio un film, non aveva una storia, una trama, dei personaggi, o meglio i personaggi c’erano ed erano il popolino napoletano e la trama erano le canzoni napoletane, una serie di vecchie canzoni a me ben note e qui nel film inquadrate in poche immagini. Ma perché questa volta, sentendo quelle canzoni una dopo l’altra in una versione musicale e con un ritmo incalzante che mi appariva del tutto nuovo, un’onda di commozione si alzava dentro di me e mi sommergeva e a stento dovevo trattenere le lacrime? Cos’era successo? Perché tutto questo? Io non so dirlo bene, ma è come se quelle canzoni avessero smosso e strappato qualcosa a lungo depositato in fondo a me stesso, e questo qualcosa per via di quelle canzoni saliva man mano in superficie e mi prendeva alla gola. Era per come quelle canzoni erano cantate? O perché chi le cantava, con un vigore ora disperato ora allegro che superava perfino il bellissimo travolgente accompagnamento musicale, non era il solito cantante sentimentale ma, almeno così pareva, tutt’intero il popolo napoletano che insorgeva con violenza a dire chi veramente era e come andavano interpretate le sue canzoni?
Dai suoi bassi, dai suoi miserabili abituri, dalla sua vita precaria, si levava un canto che aveva qualcosa di antico e di barbarico, si levava come una feroce e ilare sfida all’avverso destino, come un’indomita e passionale volontà di dichiararsi davanti al mondo per quello che veramente si era. Un coro di voci saliva dalla città lacerata, ma non era un’invocazione e neppure una protesta: era soltanto l’anima, la grande anima della città che si apriva e tutta si disvelava. Com’era profondo e ancestrale il ritmo scandito dei tamburi, come rassomigliava a un idolo primordiale Beppe Barra quando cantava “chill ’o fatto è niro niro”, com’era straziante il sax solitario di James Senese, e com’era bella e provocante la puttana della Montecorvino che avanzava cantando nel vicolo rasente i muri, e quella sfrontata e spavalda di Angela Luce, e come erano bravi, tutti, proprio tutti i cantanti, presi da una stessa frenesia! Ecco, non saprei dire come, tutto questo si coagulava in un sentimento unico che colmava il mio cuore di un’immensa pietà, di una sconfinata simpatia, di un malcelato orgoglio. Tutto questo, lo sentivo, faceva parte di me, era nascosto in una parte di me che non conoscevo o, come si dice, nel mio inconscio. Ed era maturato lentamente, trasformandosi.
Solo in quel momento mi sono accorto che in tutti questi anni la Napoli di Murolo, quella intima, che accompagnava i miei sentimenti e si accordava con la bella giornata e il paesaggio armonioso, con la poesia dei versi di Di Giacomo, non c’era più. Era scomparsa, strappata via da un’altra Napoli più scarmigliata e terri...