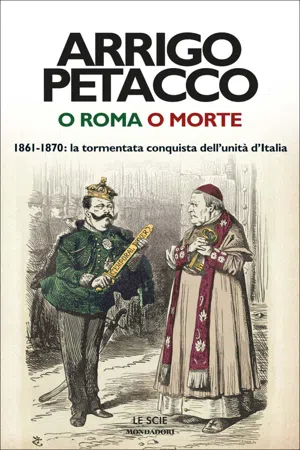![]()
Garibaldi spaventa l’Europa
Nella primavera del 1862, Giuseppe Garibaldi era «un orso ancora incerto su quale preda divorare», come l’aveva definito l’anno prima Cavour nel loro ultimo scontro parlamentare. Tradito nelle sue speranze di continuare la guerra per liberare Roma e Venezia, aveva assistito deluso al forzoso scioglimento del suo Esercito meridionale e al «tradimento» di molti suoi valenti ufficiali che avevano accettato di entrare a far parte del Regio Esercito con lo stesso trattamento offerto agli ex ufficiali borbonici. Fra questi figuravano Nino Bixio, Giacomo Medici, Enrico Cosenz e Stefano Turr, tutti promossi generali.
Garibaldi era però risoluto a non interrompere il suo lavoro. Pensava incessantemente all’«Italia una», che simboleggiava negli affollati comizi agitando il pugno chiuso con l’indice levato, e non nascondeva l’intenzione di non lasciare passare un’altra estate senza agire. I giornali italiani e stranieri avanzavano le più disparate ipotesi sui suoi progetti bellicosi, mentre i governi europei chiedevano allarmati ai propri ambasciatori a Torino dove l’Eroe dei due Mondi avrebbe colpito la prossima volta.
D’altronde, non si esagera nel dire che, in quel momento, tutti gli occhi erano puntati sullo scoglio di Caprera dove, fra l’altro, le vedette piemontesi registravano un viavai di personaggi importanti o misteriosi. Come d’altronde non esagerava l’ambasciatore americano Marsh nel segnalare al presidente Lincoln che «il signor Garibaldi è, in sé e per sé, una delle più grandi potenze del mondo». Tutte le cancellerie seguivano allarmate i suoi movimenti e prendevano sul serio le sue minacce che spesso superavano la misura. Il ministro degli Esteri francese Édouard Thouvenel ammetteva con franchezza che Garibaldi era l’incubo di Napoleone III. Il papa benediceva in ogni occasione la guarnigione francese cui era affidato dal 1849 il compito di difendere Roma dalle camicie rosse. Il governo Rattazzi era subissato da allarmanti note diplomatiche. Il Gran Visir dell’Impero ottomano si raccomandava di impedire un temuto sbarco di Garibaldi nel Montenegro. Il governo di Vienna sospettava che Garibaldi e il suo amico ungherese Luigi Kossuth stessero preparando una sommossa simultanea in Ungheria e in Dalmazia. Il governo spagnolo temeva uno sbarco garibaldino in Catalogna per accendervi la rivoluzione. Mentre il premier britannico Palmerston e, per suo conto, anche Vittorio Emanuele progettavano entrambi di spedire il Generale in Grecia per rovesciare re Ottone di Baviera, protetto dalla Russia, e collocare al suo posto un Savoia.
In questo bailamme di ipotesi e di falsi allarmi, Garibaldi, consapevole della sua popolarità che lo rendeva intoccabile, non celava il suo disprezzo per i politicanti di Torino e la sua avversione per il papa, sottolineando la volontà di continuare la sua lotta per il raggiungimento dell’unità nazionale, cui mancavano ancora Roma e Venezia. Girava infatti per l’Italia lanciando proclami incendiari che galvanizzavano le folle, ma facevano inorridire i benpensanti di Torino. Nessuno osava fermarlo.
Nel marzo del 1862, a Genova, la Sinistra, ispirata da Mazzini, convocò il primo congresso politico di stampo moderno per unificare in un solo partito tutte le organizzazioni radicali. Non era una cosa facile considerando la litigiosità dei vari esponenti: soltanto Garibaldi, che della Sinistra era il più alto patrono, poteva riuscire nell’intento. Ma questi, quando seppe che Mazzini aveva già messo i suoi uomini al vertice dell’organizzazione, rifiutò di assumere la presidenza del congresso. Tuttavia, pressato da Francesco Crispi e da Antonio Mordini, che si erano recati a implorarlo a Caprera, aveva accettato di partecipare ai lavori. Fu appunto in quell’occasione che egli pronunciò un discorso col quale inaugurò anche un nuovo metodo di oratoria. Da attore ormai consumato, rivolse direttamente alla platea domande retoriche che ottenevano, oltre gli scontati applausi, anche le risposte previste. Grande entusiasmo suscitò, per esempio, la sua metafora sul «fascio». Richiamandosi al passato, invitò tutti i delegati, liberali, repubblicani, democratici o rivoluzionari che fossero a unirsi in un unico «fascio» come quello dei littori di Roma. Ossia un fascio di verghe che, singolarmente, potevano essere spezzate, ma unite insieme sarebbero risultate invulnerabili. Questa metafora di facile comprensione sarà adottata, come è noto, da Mussolini il quale, in confessata imitazione di Garibaldi, adotterà anche la camicia (nera invece che rossa) e il saluto romano. Inoltre sceglierà il titolo di «Duce» ricordando che i garibaldini lo usavano riferendosi al loro condottiero.
Malgrado il successo personale di Garibaldi, il «fascio» non venne però costituito. Vi si opposero decisamente i mazziniani convinti che il Generale avrebbe finito per fare il gioco di Vittorio Emanuele come era accaduto dopo la spedizione dei Mille. Mazzini, d’altronde, si ostinava a illudersi e a sperare in una rivoluzione di popolo, non «inquinata» dal sostegno delle baionette piemontesi. Anzi, sosteneva che Vittorio Emanuele e Rattazzi stessero incoraggiando Garibaldi ad attaccare l’Austria o lo Stato pontificio per poi vergognosamente tradirlo all’ultimo momento.
Come altre teorie mazziniane, anche questa non era vera del tutto. Garibaldi si era effettivamente incontrato in segreto con il re e con Rattazzi, ma pare che si fosse semplicemente impegnato a non guidare nessuna spedizione contro uno Stato straniero senza il loro consenso. Su questo «consenso» si discuterà molto dopo l’insuccesso dell’Aspromonte.
Comunque, non ci sono dubbi che Garibaldi, dotato di un senso pratico del quale Mazzini difettava, era consapevole che solo con l’appoggio del Piemonte sarebbe stato possibile realizzare l’unità d’Italia e restava pertanto fedele al motto «Italia e Vittorio Emanuele» che aveva provocato la sua frattura col movimento repubblicano.
D’altra parte, Garibaldi non nascondeva di avere un debole per Vittorio Emanuele. Lo riteneva un «bravo ragazzo» circondato da cattivi consiglieri. Anche a Genova infatti, in chiusura dei lavori del congresso, al grido di «Viva Mazzini!» che si era levato da alcuni settori dell’aula, aveva risposto: «Viva l’Italia e Vittorio Emanuele!» sollevando un certo imbarazzo. D’altra parte, memore del clima del 1860, era convinto che il re avrebbe comunque tollerato un nuovo colpo di mano a imitazione di quello dei Mille. Anzi era certo che l’avrebbe addirittura aiutato se il colpo avesse avuto speranze di riuscire.
Ancora oggi comunque non è chiaro che cosa spinse Garibaldi a progettare la nuova impresa che sarebbe miseramente naufragata in Aspromonte. Come scrive Montanelli, forse non lo sapeva neppure lui. Forse aveva soltanto fretta di battere il ferro finché era caldo, e caldo lo era di certo. Fatto sta che, rientrato a Caprera il 25 maggio 1862, il giorno dopo si imbarcò per Palermo con il figlio primogenito Menotti (l’aveva chiamato così in onore di Ciro, il patriota modenese finito sulla forca) e con una ventina di fedelissimi, senza rivelare a nessuno quale fosse la meta e che cosa avesse in mente. «Andiamo verso l’ignoto» aveva risposto a chi gli chiedeva dove li stesse portando. Giuseppe Guerzoni, suo fedele seguace e attento biografo, ha scritto: «Nessuno apprese mai dal suo labbro dove si andasse e perché si andasse». Pare comunque che Garibaldi sia andato a Palermo, dove non era più stato dal 1860, su suggerimento di Vittorio Emanuele affinché placasse con la sua influenza il movimento separatista che si stava nuovamente sviluppando nell’isola.
A Palermo Garibaldi ricevette accoglienze trionfali e lui, galvanizzato dall’entusiasmo che lo circondava, si lasciò scappare alcune affermazioni incendiarie che la folla applaudì freneticamente, ma che imbarazzarono il governatore dell’isola, l’ex garibaldino Giorgio Pallavicino Trivulzio, ora funzionario del governo.
Ma si era appena agli inizi. Girando per l’isola tra folle plaudenti, Garibaldi non si stancava di levare in alto il dito indice e di arringare la folla affinché fosse pronta a battersi per l’unificazione nazionale. Anche nelle cerimonie ufficiali non nascondeva del tutto i suoi intendimenti. Per esempio, ricevendo una delegazione di universitari, il cui capo gli aveva detto che l’Italia era ormai un paese di ventidue milioni di italiani tutti uniti nella lealtà a Vittorio Emanuele, lo aveva corretto precisando che gli italiani non erano ventidue milioni, ma venticinque e che tutti sarebbero stati presto uniti nella stessa patria. Dove abitassero quei tre milioni di assenti non era difficile immaginarlo. Ma a Marsala fu ancora più chiaro. Dopo avere salutato la città da cui era partita la sua marcia liberatrice, Garibaldi rivelò apertamente che Roma era il prossimo obiettivo e pronunciò il giuramento «O Roma o morte!», cogliendo al volo il grido lanciato da uno dei tanti ascoltatori che lo acclamavano nell’interno di una chiesa. Questo motto diventerà la parola d’ordine dei suoi seguaci per gli anni successivi. Il dado era tratto.
La minaccia lanciata da Marsala mise in fibrillazione tutte le cancellerie europee, ma soprattutto Parigi dove Napoleone III, pur essendo desideroso di liberarsi della patata bollente romana, sperava di trovare una soluzione pacifica con il papa e con Vittorio Emanuele. I soldati francesi, comandati dal generale Oudinot, erano venuti a Roma nel 1849, quando Napoleone era ancora presidente della Repubblica, per abbattere l’effimera Repubblica romana fondata da Giuseppe Mazzini, Carlo Armellini, Aurelio Saffi e difesa dal generale Garibaldi. Dopo di allora i francesi non se ne erano più andati. Pio IX ne aveva accettato volentieri la protezione, ma ora cominciava a temere, con ragione, che Napoleone, diventato nel frattempo imperatore dei francesi, fosse propenso a consentire al Regno d’Italia di conquistare la sua storica capitale. A rassicurare il papa c’erano tuttavia i cattolici francesi, di cui l’imperatore temeva la reazione nel caso di un suo cedimento, ma soprattutto la stessa imperatrice Eugenia, cattolica fervente, la quale all’annuncio del giuramento garibaldino aveva freddamente commentato: «Morte sì, Roma mai!».
Da parte sua, Vittorio Emanuele, preoccupato dall’allarme che l’aperta minaccia di Garibaldi aveva provocato (si auspicava addirittura la creazione di un «esercito crociato» intereuropeo per liquidare Garibaldi e la sua banda), il 3 agosto dichiarò con un proclama «che a lui e solo a lui toccava di decidere quando fare il primo passo per liberare il restante territorio italiano», sottolineando che non avrebbe mai permesso ad alcuna persona «per quanto eminente» di sfidare la legge.
Garibaldi era dunque avvertito, ma lui sembrò non prestarvi ascolto. Già dal 16 luglio, malgrado il prefetto di Palermo avesse ammonito i cittadini che non si sarebbero tollerati «arruolamenti per una spedizione misteriosa», aveva raccolto nel bosco della Ficuzza i primi volontari affluiti nell’isola da ogni parte d’Italia. Anche il nome di «Legione romana» da lui scelto per questi volontari fugava gli ultimi dubbi sulle sue intenzioni. A fine luglio erano più di tremila e Garibaldi, quando glielo dissero, si era fregato le mani commentando: «Non ne ebbi tanti a Marsala nel Sessanta». Non avevano però risposto al suo appello i migliori uomini della vecchia guardia come Nino Bixio, Giacomo Medici, Enrico Cosenz e Giuseppe Sirtori, ormai integrati nel Regio Esercito, i quali non solo si erano detti contrari all’impresa, ma avevano anche tentato di dissuaderlo.
Il 28 luglio Palermo si pavesò di tricolori per salutare i volontari che sfilarono sulla via principale in camicia rossa per poi raggiungere il luogo di raduno. Appartenevano a tutte le classi sociali, molti erano i ragazzi di quattordici o quindici anni e moltissimi i veterani della spedizione dei Mille che avevano raggiunto il vecchio Generale sicuri di partecipare a un’altra gloriosa impresa che prometteva di essere facile quanto la precedente. I partenti furono applauditi da un’impressionante manifestazione di popolo: pareva andassero a una festa, non alla guerra.
Era così iniziata una sorta di commedia degli inganni. Ma chi ingannava chi? Mentre i garibaldini si mettevano in marcia per Catania, considerata il trampolino di lancio verso il continente, il governo aveva cominciato a mostrare la propria contrarietà. Il prefetto Pallavicino, considerato troppo amico di Garibaldi, era stato sostituito dal generale Efisio Cugia, nominato commissario regio con pieni poteri. Una squadra navale, comandata dall’ammiraglio Giovanni Battista Albini, aveva sbarcato nell’isola alcuni battaglioni di bersaglieri per rinforzare i presidi preesistenti. «Il Giornale Officiale di Sicilia» pubblicava minacciosi proclami contro l’iniziativa… Ma nel contempo Garibaldi arringava tranquillamente i suoi volontari annunciando che «noi, uniti al nostro prode esercito, realizzeremo alfine la patria unificazione…».
La sicurezza mostrata da Garibaldi aveva finito per convincere tutti che fra lui e il re esistesse un accordo segreto come era accaduto due anni prima. Si diceva che, come nel 1860, il governo avrebbe dimostrato solo a parole di avversare la spedizione, ma che, sotto sotto, l’avrebbe appoggiata. Forse era anche vero, chissà. In proposito non esistono prove, tuttavia sappiamo che in seguito il governo pagherà ogni debito contratto da Garibaldi e dai suoi per la spedizione in Aspromonte. E allora?
Prima di partire, Garibaldi aveva suddiviso il suo piccolo esercito in varie brigate affidandole ai suoi più fedeli collaboratori, fra i quali il figlio Menotti, Giuseppe Missori, Giovanni Nicotera, Giuseppe Bentivegna e Carlo Trasselli, ai quali non erano stati assegnati dei gradi, ma solo funzioni di comando. I volontari non ricevevano il soldo per mancanza di fondi, cosicché, per sfamarli durante la marcia, era stato creato un comitato di guerra, affidato a Missori e a Nicotera, con l’incarico di raccogliere quattrini nelle esattorie comunali.
La lunga colonna avanzava sotto il sole rovente attraverso il riarso cuore dell’isola, e dovunque era accolta festosamente. La spedizione non solo aveva assunto l’aspetto di una marcia trionfale, ma era aumentata anche di numero. Oltre ai tanti militari e ufficiali del Regio Esercito che avevano disertato per unirsi al Generale, si erano man mano uniti anche gruppi di pastori e di contadini, raggiunti nei loro villaggi dalla fama miracolistica di Garibaldi. Costoro indossavano stracci, pelli di pecora, calzavano gli «zampitti», portavano una bisaccia su una spalla e un vecchio archibugio o un forcone sull’altra e gridavano a casaccio «Viva Garibbaddu!», «Viva la Talia!», ma anche «Terra e libbirtà». Accogliendoli paternamente, Garibaldi aveva osservato con Missori che quelle nuove reclute si aspettavano certamente «qualcosa di più dell’unità d’Italia».
Si erano uniti nella marcia anche molti patrioti borghesi e aristocratici, vecchi cospiratori delle precedenti rivoluzioni antiborboniche, alcuni dei quali si erano portati appresso delle squadre di famigli e di contadini che loro stessi avevano provveduto ad armare e a equipaggiare. Due anni di malgoverno «piemontese», come scrive Sandro Attanasio, avevano spento i loro entusiasmi, ma il ritorno di Garibaldi li aveva rinvigoriti e ora marciavano sempre più convinti che «si nun si guasta nun si cunza (se non si rompe non si aggiusta)».
La marcia verso Catania continuò suddivisa in tre colonne, quella di destra affidata a Bentivegna, quella di sinistra a Trasselli e quella di centro allo stesso Garibaldi. Nel frattempo, da Torino giungevano raffiche di confusi telegrammi alle autorità locali affinché fermassero in qualche modo Garibaldi. Ma non si specificava come. Di conseguenza, le autorità locali non sapevano a che santo votarsi tante erano le contraddizioni. A Santo Stefano di Bivona, oggi Santo Stefano Quisquina, si registrò, per esempio, il primo scontro a fuoco con i carabinieri della locale stazione che avevano cercato di arrestare un disertore da essi riconosciuto nelle file garibaldine. Ne era sortito un conflitto che aveva lasciato sul terreno qualche morto e alcuni feriti. Ma a Barrafranca il Generale aveva potuto visitare tranquillamente la stazione dei Reali Carabinieri omaggiato dal comandante.
La sera dopo, 12 agosto, la colonna entrò a Caltanissetta accolta da un popolo osannante. Le truppe regie, per prudenza, avevano lasciato il giorno prima la città, ma il prefetto Domenico Marco aveva offerto ugualmente un pranzo ufficiale che si era concluso con una serie di brindisi dedicati a Vittorio Emanuele, a Garibaldi, a Roma capitale e così via. Alcuni giorni dopo, però, il prefetto Marco fu tacitamente esonerato dal servizio e richiamato a Torino. I notabili di Caltanissetta, galvanizzati dall’euforia del momento, offrirono a Garibaldi ottocento uomini armati e vestiti a spese della municipalità. Altri uomini armati si aggiunsero in seguito alla colonna: erano i picciotti di Giovanni Corrao, che la storia «politicamente corretta» eroicizzerà per le loro gesta. In realtà si trattava di una banda di predoni dediti soprattutto al saccheggio. Alcuni ufficiali se ne lamentarono con il Generale, ma questi non batté ciglio. «Mi basta che si battano» disse.
A Caltanissetta Garibaldi ricevette anche una visita misteriosa che allarmò i servizi segreti che seguivano le sue mosse. Si trattava del console americano di Palermo, accompagnato da due alti ufficiali della Marina degli Stati Uniti. «Gli stranieri» riferiva il questore Giovanni Rebaudengo «hanno palesato che intendevano soltanto conoscerlo ed ossequiarlo, ma l’incontro aveva evidentemente altri motivi politici che non ci è dato di conoscere.» Evidentemente, il presidente Lincoln non aveva ancora rinunciato al progetto di arruolare Garibaldi nelle sue file.
Mentre si svolgevano questi avvenimenti, le truppe di Catania erano state schierate nella vicina Adernò con l’ordine di sbarrare ai volontari la strada per la città. Il generale Mella, comandante della guarnigione, aveva però informato il generale Cugia che «incontrando i garibaldini intimerò loro di sciogliersi, ma non attaccherò». Regnava ancora l’incertezza su come affrontare la situazione. A sciogliersi, comunque, erano state le truppe regie dalle cui file molti continuavano a disertare per unirsi al Generale.
A Regalbuto, la Legione romana fu raggiunta da una delegazione di deputati della Sinistra (Mordini, Cadolini, Fabrizi e Calvino) cui il generale Cugia aveva rilasciato un salvacondotto in cambio della promessa che avrebbero chiesto a Garibaldi di rinunciare all’impresa. Fatica sprecata: il Generale accolse i parlamentari con grande cortesia, ma restò fermo nei suoi propositi e alcuni di loro, i più estremisti, se ne compiacquero. A chi gli raccomandava di non versare sangue fraterno rispose categoricamente che avrebbe compiuto ogni sforzo per evitare un conflitto con la truppa, «ma non si sarebbe mai lasciato togliere la sciabola dal fianco». Due di questi deputati, Mordini e Fabrizi, rientrarono pochi giorni dopo a Napoli dove, con loro sorpresa, trovarono i carabinieri ad attenderli. Il generale Alfonso La Marmora, nominato nel frattempo commissario straordinario dell’ex reame, aveva ordinato di arrestarli e le sue intenzioni non erano certo amichevoli, visto che aveva inviato un telegramma a Rattazzi chiedendogli: «Ho arrestato due deputati. Che faccio? Li fucilo?». «Li rimetta in libertà e si scusi» gli aveva risposto il primo ministro. Mordini e Fabrizi se la caveranno con quaranta giorni nel carcere di Castel dell’Ovo, ma l’episodio è significativo per indicare che la situazione stava mutando al peggio.
A Torino infatti l’atmosfera era cambiata. Se fino a quel momento, volenti o nolenti, il re e Rattazzi avevano tollerato l’iniziativa garibaldina, ora dovevano comunque prendere una decisione. Nella maggioranza parlamentare l’escalation antigaribaldina era diventata sempre più consistente. I ministri Agostino Depretis, Quintino Sella, Carlo Pellion di Persano, Carlo Matteucci, Giacomo Durando e altri si erano rivolti direttamente al re affinché fermasse l’inconsulta iniziativa del generale Garibaldi il quale, «posti in dimenticanza i doveri del cittadino, ha alzato in Sicilia la bandiera della ribellione lanciando il grido di “O Roma o morte” contro il Vostro glorioso alleato».
Il «glorioso alleato» era ovviamente Napoleone III, il vero vincitore della seconda guerra d’indipendenza contro l’Austria cui Vittorio Emanuele era debitore per avere ricevuto in «dono» la Lombardia pur con la dolorosa perdita di Nizza e della Savoia. Nei suoi discorsi, spesso sconclusionati, Garibaldi era infatti solito ricoprire di invettive l’imperatore dei francesi non solo per la sua volontà di non cedere Roma, ma anche per essersi impossessat...