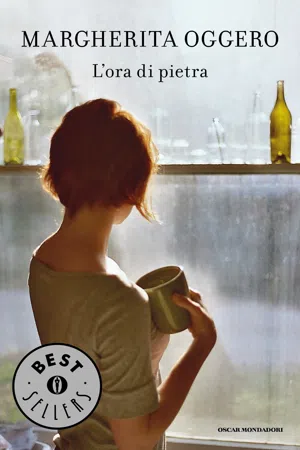![]()
Margherita Oggero
L’ORA DI PIETRA
Romanzo
![]()
Per Alberto,
che mi manca tanto.
![]()
La questione è: che cosa fa ciascuno
di noi delle carte che ha ricevuto?
AMOS OZ, Una storia d’amore e di tenebra
![]()
La zia scaduta non è buona e neppure cattiva, più che tutto è scontenta e qualche volta arrabbiata.
Io non so come sono, so soltanto che vorrei non essere io ma un’altra persona e avere un’altra vita. Oppure non averla avuta, perché prima, cioè prima di nascere, non si sta male, non si sta e basta. Quando mi metto a pensare a queste cose mi viene la gola stretta e voglia di piangere, però non piango perché non serve, mi metto invece seduta dietro alla finestra che dà sulla via e guardo giù. Intanto il tempo passa.
La via è abbastanza larga, e dal terzo piano riesco a vedere più di mezza strada e il marciapiede di fronte. Vedo anche, si capisce, le facciate di quattro case, con le finestre e i balconi. I balconi hanno le ringhiere mangiate dalla ruggine e sono pieni di piante in vaso. Piante finte, con i rami un po’ rotti e coperte di polvere grassa, comprate dai cinesi, tutte uguali con le foglie venate di rosso, larghe e lunghe. Stanno contro alle ringhiere a fare siepe, ma di sera vengono spostate, tutta una foresta di piante che si muovono, così i padroni con le parabole satellitari nascoste dietro i vasi possono prendere i programmi tv dei loro Paesi. Sì, perché in questa strada di periferia ci vivono quasi solo immigrati, soprattutto dall’Africa, neri e arabi, oltre alla zia scaduta, che immigrata lo è pure lei, anche se da più vicino e, con lei, io.
La parabola lei non ce l’ha, dice che ce l’aveva una volta, ma era di seconda o terza mano e la tele si vedeva un po’ sì e un po’ no, così l’ha buttata nel cassonetto insieme con le piante dei cinesi.
Il fatto è che, per prendere bene i programmi dal satellite, l’antenna andrebbe messa tutta all’esterno, ma è vietato e i vigili se la vedono danno la multa e la fanno togliere. Dalla parte del cortile non serve metterla, perché lì il segnale non arriva, sul tetto invece sì, ma il padrone di casa non vuole e poi bisognerebbe anche chiamare un antennista che costa tanto. A me della tele non mi importa granché, ma se anche mi importasse sarebbe lo stesso, perché alla sera la zia i programmi li sceglie lei e di giorno, quando va a lavorare, si porta dietro il telecomando così, dice, non guardo delle schifezze che poi mi rovinano la testa.
Dice così, ma io so che è per non spendere troppo nella bolletta della luce, infatti in casa le lampadine nel soggiorno-angolo cottura sono svitate una sì e una no e nello sgabuzzino dove dormo io c’è solo un piccolo neon che fa una luce ghiacciata da frigo. Nella sua stanza invece c’è una lampada sul comodino da notte e quella ha una lampadina forte, ma non la accende mai perché, non tirando giù tutta la tapparella, la luce della strada le basta per svestirsi. Dopo, come mette la testa sul cuscino, si addormenta subito perché il notaio la manda di qua e di là tutto il giorno a fare la coda negli uffici e alla sera è stanca da morire, dice.
Stanca è stanca, ma il sonno le viene subito perché prende le gocce. Forse non è tanto buona e anche un po’ bugiarda. E il telecomando forse se lo prende per dispetto, per vendicarsi del fatto che mi hanno portata qui.
![]()
Melina era alta, pallida, con gli occhi neri che le mangiavano la faccia. Bella assai. Era la figlia di un’ingannevole menopausa precoce, nata quattordici anni dopo Salvatore e diciotto dopo Antonio, quando Assunta e Saverio avevano cominciato a fare l’amore senza precauzioni. E anche senza paura di farsi sentire dai figli, che nelle sere dei fine settimana andavano al cine o a giocare a calcetto o a spasso con gli amici, e loro si godevano il sapore di una rinnovata ventata di giovinezza e libertà.
«Save’, t’aggia di’ na cosa.»
«E dimmela.»
«Sono incinta.»
«No! E com’è sta cosa?»
«Non lo so. La dottoressa aveva detto che potevo stare sicura, che se avevo dei disturbi era per via della mancanza di certi ormoni... diceva che erano i disturbi delle donne, vampate vertigini nausea...»
«E tu li avevi?»
«Neanche uno. Stavo bene, anzi sto bene, benissimo, come quando ero incinta di Antonio e Salvatore, che le nausee non sapevo neppure cos’erano.»
«E allora, come sai che...»
«Le gonne che tirano in vita, la cerniera dei jeans che non sale. E non sto mica mangiando più di prima.»
«Be’, un po’ sì. L’altra domenica col gattò di patate ti stavi strafogando.»
«Comunque mi venne il dubbio e andai da zia Concetta, la mammana.»
«E lei ti disse che sei incinta?»
«Sì, ma non ero sicura, perché zia Concetta è vecchia vecchia e magari si era sbagliata. Così andai alla mutua, feci l’esame del sangue e, insomma, sono proprio incinta.»
«Da quanto?»
«Undici, dodici settimane. E mo che facciamo?»
«E che vuoi fare? Ce lo teniamo, sto bambino o bambina.»
«Ma sei contento?»
«Non lo so, forse sì, soprattutto se è femmina, dato che i maschi li abbiamo già.»
«Sai una cosa, Saverio? Io sono contenta assai. Vuol dire che sono ancora giovane. E di avere un pupetto o pupetta in braccio ne ho ancora voglia.»
Era stata una femmina: Carmelina, detta Melina. Antonio perplesso e un po’ seccato, per via dei compagni che lo pigliavano in giro e non lesinavano battute piuttosto grevi sui suoi; Salvatore invece intenerito da quella bambina tutta occhi e capelli neri, una pupetta da giocarci per ore, da farle il solletico, da gattonarci insieme per terra. E lei, a sua volta, stravedeva per Tore e lo accoglieva con gridolini di gioia quando tornava da scuola, gli trotterellava dietro per casa, e più avanti si faceva portare a passeggio, a piedi o sul seggiolino della bici. Una famiglia serena.
«Sai, Save’» diceva qualche volta Assunta, segnandosi in fretta con la croce, «noi siamo proprio fortunati. A noi nessuno ci dà noia, teniamo un buon lavoro, dei figli belli, la casa ce l’abbiamo, non ci manca niente.»
«Fortunati sì, perché non possono spremerci né farci obblighi. Ma se tu non ti prendevi il diploma da maestra e io non entravo in ferrovia, eravamo esposti come tutti. E Antonio, dopo l’università, qui il lavoro è difficile che lo trovi, e pure per Tore, finito l’istituto, sarà dura.»
«Eh Save’, che ti sei bevuto il caffè amaro? Ti sei scordato Melina, per lei non ce l’hai l’oroscopo nero?»
«Lei è ancora piccola, staremo a vedere.»
Antonio aveva schivato il servizio militare grazie a un lievissimo soffio al cuore, ma soprattutto grazie alla sopravvalutazione dello stesso da parte del medico della commissione militare.
Non c’era stato nessun intervento del boss Raffaele, era stata una semplice questione di ping-pong. Sì, perché all’oratorio del paese dove Saverio abitava prima di sposarsi, lui e il futuro medico militare erano i campioncini di tennis da tavolo e giocavano in coppia – vincendo sempre – nei tornei amatoriali. Al figlio di un antico compagno di adolescenza un favore non si nega, anche se non richiesto, anzi soprattutto se non richiesto, che così chi lo fa si sente proprio generoso e altruista. E lo si replica pure col figlio minore, quand’è il suo turno, perché la gratitudine dei genitori era stata commovente e nella rimpatriata, in un ristorante dell’entroterra, c’era scappata anche una partita di ping-pong, anzi tre, e la bella se l’era aggiudicata il medico, perché Saverio sa stare al mondo.
Finita l’università, Facoltà di Chimica, Antonio aveva vinto una borsa di studio in Belgio e subito dopo aveva avuto, sempre in Belgio, una proposta di lavoro in una fabbrica di vernici.
«Te lo prendi, sto posto? All’estero, lontano, da solo...» aveva chiesto sua madre.
«E come no? Qui dove lo trovo un lavoro come quello?»
«Ma nelle vernici c’è pericolo...» aveva tentato di dissuaderlo lei.
«Anche sui treni c’è pericolo. Ci mettono le bombe, o deragliano, eppure papà sui treni ci lavora.»
«Non è la stessa cosa...» aveva protestato debolmente lei, sapendo in partenza di essere sconfitta.
Ad Antonio il paese da una certa età in poi era andato stretto, amici veri non ne aveva, e le sole ragazze con cui c’erano state delle storie erano compagne di università, a Napoli. Storie, però, senza impegni e senza rimpianti. E dopo Napoli, dopo Bruxelles, il paese era una prigione senza sbarre ma anche senza sbocchi.
Il cine chiuso, i bar neri di fumo e di mosche, la discoteca piena di balordi e sgallettate, le risse per uno sguardo di troppo, le moto che scorrazzavano all’impazzata anche nei vicoli, le case mai finite cogli spunzoni di ferro che si arrugginivano anno dopo anno e, su tutto, il fiato del boss. Un fiato pesante che ammorbava paese e abitanti, anche quelli, pochi, che non ne erano direttamente toccati.
Certo, a pochi chilometri c’era la marina, con una spiaggia di sabbia grossa e nera, chiusa da due scogli, e c’era un clima mite per buona parte dell’anno, e c’era il sole – chisto è ’o paese d’ ’o sole – e c’erano mamma papà Tore e Melina. Ma nonostante tutto preferiva la pioggia e il freddo di Bruxelles, con le strade pulite, senza cumuli di spazzatura e cassonetti rovesciati o incendiati, con gli abitanti contegnosi, le leggi quasi sempre rispettate, con gli automobilisti che cedono il passo ai pedoni sulle strisce.
E pazienza per la solitudine.
![]()
Sto dietro alla finestra chiusa con le tendine tirate e vedo tutto. Gli altri, dalle case di fronte e dalla strada, non mi possono vedere, e io devo restare invisibile. Guardo giù e penso cose. Tutti quelli che hanno la malasorte pensano molto.
Qui, nascosta dalle tendine di nylon in finto pizzo, mi invento anche delle storie su chi passa, chi entra nel bar con i giochi, chi va dalle parrucchiere cinesi, chi nell’ufficio del sindacato, chi al girarrosto. Nell’ora di pietra però non si vede nessuno. L’ora di pietra non dura un’ora, ma solo un momento, qualche volta un minuto, qualche volta anche tre o quattro. A me piace tanto e la chiamo così perché tutto resta fermo come impietrito. Non passa gente, non passano macchine, è come se il mondo si fermasse senza fare il rumore della frenata.
Mi sembra che dopo possa succedere di tutto, un terremoto, un’esplosione, come se quella fosse una pausa in attesa di qualcosa di grosso, come quando si tiene il fiato prima di gridare o di piangere, o come quando si resta così spaventati che ci si dimentica persino di respirare. Solo che dopo non succede mai niente di diverso, le macchine tornano a passare, i ragazzi a entrare e uscire dal bar, le clienti a venirsene o andarsene dalle parrucchiere cinesi che fanno l’orario continuato, invece il sindacato e il girarrosto hanno già chiuso con la serranda giù e lì non ci va nessuno.
Dal sindacato, alla mattina sul tardi, c’è un viavai di vecchietti, verso sera invece di gente più giovane. La zia scaduta ha detto che dovrebbe andarci pure lei a farsi le sue ragioni, perché il notaio la paga poco per le ore che fa, solo che prima deve cercarsi un altro posto, dato che quello è capace di licenziarla con una scusa o con l’altra, e lei senza lavoro non può stare, perché suo marito, che non è più suo marito ma lei lo chiama così, non le passa tanto di alimenti, mentre le spese corrono perché in città la vita è tanto cara.
Solo che un altro lavoro non lo cerca mai.
Dalle parrucchiere cinesi ci vanno uomini e donne, perché il taglio e la piega costano poco. Quando sono venuta al Nord anch’io sono andata dalle cinesi, ma non da queste, da quelle di un quartiere lontano da casa, e mi hanno fatto un taglio da maschio che quasi non mi riconoscevo.
![]()
Antonio tornava a casa per le feste di fine anno e una decina di giorni in agosto. Assunta lo soffocava di attenzioni e di domande e lui, nonostante l’affetto, non vedeva l’ora di ripartire. Col fratello la confidenza non s’era interrotta, era la stessa di quando erano ragazzi e prima di addormentarsi si scambiavano opinioni e segreti.
«Perché non hai voluto fare l’università?» chiese una volta a Tore mentre erano da soli.
«Eh... di dottori in casa ne basta uno.»
«Ma ti piace il lavoro che fai?»
«È quello che volevo. Da perito meccanico ho ...