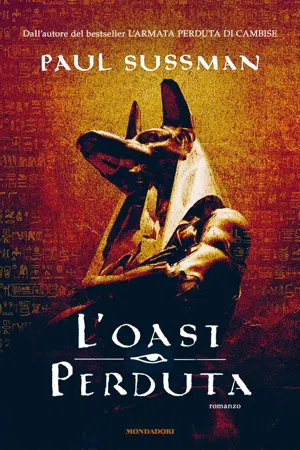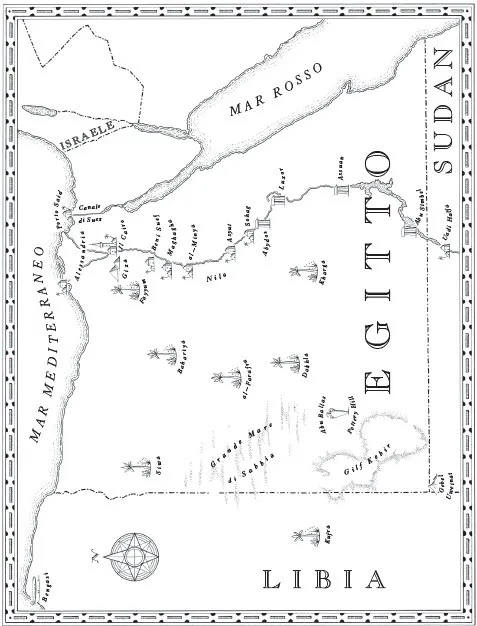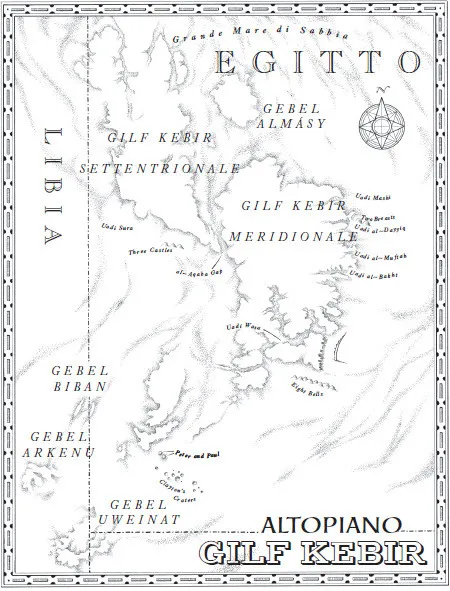![]()
Paul Sussman
L’OASI PERDUTA
Traduzione di Enrico Scoziero
![]()
![]()
![]()
![]()
2153 a.C. Egitto, Deserto occidentale
Avevano portato nelle remote distese desolate del deshret anche un beccaio; e per tagliare loro la gola lui non usò un coltello da cerimonia, ma uno per macellare il bestiame.
Col barbaro arnese di gialla selce spaccata a martellate, affilato come un rasoio e lungo un braccio, il beccaio passò da sacerdote a sacerdote e premette con perizia la lama nel morbido incavo fra collo e clavicola. Gli occhi vitrei per l’infuso di shepen e shedeh bevuto per attenuare il dolore, il cranio rasato luccicante di goccioline d’acqua sacra, ogni uomo rivolse preghiere ad Atum-Ra, lo implorò di condurlo con sicurezza ad attraversare la Sala delle Due Verità fino ai Sacri Campi di Iaru. Allora il beccaio piegò loro la testa all’indietro verso il cielo dell’alba e con un solo, deciso fendente tagliò il collo da orecchio a orecchio.
«Possa lui camminare nei magnifici sentieri, possa lui attraversare il firmamento celeste!» intonarono i restanti sacerdoti. «Possa lui mangiare ogni giorno a fianco di Osiride!»
Il beccaio, braccia e petto schizzati di sangue, adagiava a terra ciascun sacerdote prima di passare al successivo e ripetere il rituale, allungando man mano la fila di cadaveri mentre eseguiva il lavoro, con il volto inespressivo e con brutale efficienza.
Dalla cresta di una duna vicina, Imti-Khentika, Gran Sacerdote di Iunu, Primo Profeta di Atum-Ra, Massimo Veggente, guardava quel coreografico macello. Provava dispiacere, naturalmente, per la morte di tutti quegli uomini che ormai considerava fratelli. Anche soddisfazione, però, perché avevano compiuto la loro missione e perché ciascuno sapeva fin dall’inizio che si sarebbe dovuta concludere in quel modo, affinché non si diffondesse nemmeno un bisbiglio su ciò che avevano fatto.
Alle sue spalle, a oriente, percepì il primo tepore del sole, Atum-Ra nel suo aspetto di Khepri, che portava al mondo luce e vita. Si girò nella sua direzione, gettò indietro il cappuccio di pelle di leopardo, spalancò le braccia e recitò: «Oh, Atum, che venisti in essere sulla montagna della creazione, con un bagliore come l’uccello Benu nel tempio della Benben a Iunu!».
Alzò la mano, a dita allargate come per afferrare lo stretto bordo color cremisi che faceva capolino sulle sabbie all’orizzonte. Poi si girò di nuovo e guardò nella direzione opposta, a occidente, l’erta muraglia di dirupi che correva da nord a sud, lontana cento khet, come un vasto sipario steso sul margine del mondo.
Da qualche parte alla base di quei dirupi, nella fitta rete di ombre che la luce dell’alba doveva ancora penetrare, c’era l’Entrata Divina: re-en wesir, la Bocca di Osiride. Era invisibile, da dove lui si trovava. E lo sarebbe stata anche a un osservatore posto proprio davanti a essa, perché lui, Imti, aveva proferito gli incantesimi di chiusura e di occultamento e nessuno, a parte chi sapeva come guardare, si sarebbe accorto della sua presenza. In quel modo il luogo dei loro antenati, wehat er-djeru ta, l’Oasi alla Fine del Mondo, aveva protetto i propri segreti per un’interminabile sequela di anni e la sua esistenza era nota solo ad alcuni prescelti. Non per niente era anche chiamata wehat seshtat, l’Oasi Segreta. Là il loro carico sarebbe stato al sicuro. Nessuno l’avrebbe trovato. Avrebbe riposato in pace fino all’arrivo di giorni più stabili.
Imti scrutò i dirupi e annuì in segno di approvazione; poi riportò lo sguardo sulla storta guglia di pietra che erompeva dalle dune a circa otto khet dalla parete del precipizio. Anche da quella distanza era una particolarità notevole, che dominava il panorama circostante: una torre ricurva di pietra nera, piegata verso l’esterno e verso l’alto a un’altezza di quasi venti meh-nswt, simile a una grande falce che tagliasse il deserto o, più precisamente, all’arto anteriore di un gigantesco scarabeo che sbucasse dalla sabbia.
Quanti viaggiatori, si chiese Imti, avevano oltrepassato quella solitaria sentinella senza capirne il significato? Pochi o forse nessuno, pensò, rispondendosi da solo, perché quelle erano terre vuote, terre morte, il reame di Set, dove nessuno che tenesse in conto la vita si sarebbe mai sognato d’avventurarsi. Solo chi conosceva i luoghi dimenticati si sarebbe spinto così lontano nel nulla rovente. Soltanto qui il loro carico sarebbe stato davvero al sicuro, irraggiungibile da quelli che avrebbero fatto un cattivo uso dei suoi terribili poteri. Sì, pensò Imti, malgrado gli orrori del loro viaggio, la decisione di portarlo a occidente era stata quella giusta. Decisamente quella giusta.
Ormai da quattro lune un consiglio segreto dei più potenti del paese aveva preso la decisione: la regina Neith, il principe Merenre, il tjaty Userkef, il generale Rehu e lui, Imti-Khentika, il Massimo Veggente.
Solo il nisu stesso, Signore delle Due Terre Nefer-ka-re Pepi, non era stato presente né informato della decisione del consiglio. Un tempo Pepi era stato un potente sovrano, al pari di Khasekhemwy e di Zoser e di Cheope. Ora, nel novantatreesimo anno di regno, tre volte la durata di una normale vita umana, il suo potere e la sua autorità erano in declino. In tutto il paese i nomarchi avevano formato eserciti privati e scatenato guerre l’uno contro l’altro. A nord e a sud i Nove Archi attaccavano di continuo le frontiere. Per tre volte negli ultimi quattro anni, l’inondazione non era avvenuta e i raccolti erano stati scarsi.
Il kemet si stava disintegrando e ci si aspettava solo che la situazione peggiorasse. Pepi poteva anche essere figlio di Ra, ma ora, in tempo di crisi, altri dovevano prendere il comando e fare al suo posto le grandi scelte di stato. E così il loro consiglio aveva parlato: per la sua stessa salvaguardia e per la salvezza di tutti gli uomini, la iner-en sedjet doveva essere allontanata da Iunu, dov’era custodita, e riportata al di là dei campi di sabbia nel luogo sicuro dell’Oasi Segreta, da cui in origine proveniva.
E a lui, Imti-Khentika, Gran Sacerdote di Iunu, era toccata la responsabilità di guidare la spedizione.
«Portatela al di là del serpeggiante corso d’acqua navigabile, traghettatela nel lato orientale del cielo!»
Un rinnovato crescendo di salmodia salì dal basso, mentre un’altra gola veniva tagliata e un altro corpo deposto sul terreno. Adesso i cadaveri erano quindici, la metà di loro.
«Oh, Ra, lascialo venire a te!» gridò Imti, unendosi al coro. «Guidalo sulle strade sacre, fa’ che viva per sempre!»
Guardò il beccaio passare all’uomo successivo e nell’aria echeggiò l’umido sibilo di trachee recise. Poi, mentre il coltello tagliava di nuovo, Imti rivolse lo sguardo lontano sul deserto, ricordando gli incubi del viaggio appena intrapreso.
Erano partiti in ottanta, all’inizio della stagione peret, quando il caldo era meno violento. Con il carico avvolto in strati di lino protettivo e assicurato a una slitta di legno, avevano viaggiato verso sud, prima in barca fino a Zawty, poi via terra fino all’oasi di Kenem. Là avevano riposato per una settimana e poi si erano imbarcati per l’ultima e più terribile tappa della loro missione: cinquanta iteru nelle roventi distese desolate prive di piste del deshret fino ai grandi dirupi e all’Oasi Segreta.
Quell’ultima tappa aveva richiesto sette lunghe settimane, il peggio che Imti avesse mai conosciuto, al di là delle più terribili fantasie. Prima di aver percorso metà della strada, i buoi da soma erano morti tutti; avevano dovuto portare loro stessi il carico, venti alla volta aggiogati insieme come bestie, le spalle rigate di sangue per l’attrito delle funi legate alla slitta, i piedi ustionati dalle sabbie incandescenti. Ogni giorno il cammino si era fatto più lento, ostacolato da dune alte come montagne, da accecanti tempeste di sabbia e soprattutto dal caldo che, persino nella stagione più fresca, li aveva prosciugati dall’alba al crepuscolo come se l’aria stessa fosse in fiamme.
Sete, malattie e spossatezza avevano inesorabilmente ridotto il loro numero; e quando l’acqua era terminata senza che si scorgesse segno della meta, lui aveva temuto che la missione fosse destinata al fallimento. Tuttavia, avevano continuato ad avanzare, silenziosi, indomiti, ciascuno perduto nel proprio personale mondo di tormento, finché nel quarantesimo giorno dalla partenza da Kenem gli dèi avevano ricompensato la loro perseveranza con la scena per la quale avevano costantemente pregato: una caliginosa banda di rosso all’orizzonte occidentale che segnava la linea dei grandi dirupi e la fine del viaggio.
Da allora avevano impiegato altri tre giorni per raggiungere la Bocca di Osiride, attraversarla ed entrare nella gola piena d’alberi dell’oasi. A quel punto solo trenta di loro erano ancora in piedi. Avevano consegnato il carico al tempio nel cuore dell’oasi, si erano bagnati alle fonti sacre e poi, stamattina di buon’ora, recitati gli incantesimi di chiusura e di occultamento, poste le Due Maledizioni, erano tornati nel deserto e il beccaio aveva iniziato a tagliare gole.
Un rumoroso acciottolio strappò Imti alle sue fantasticherie. Il beccaio, un muto, stava battendo contro una pietra il manico del coltello per richiamare la sua attenzione.
Ventotto cadaveri giacevano sulla sabbia lì accanto, quindi rimanevano in vita solo loro due. Era la fine.
«Dua-i-nak netjer seni-i» disse Imti, scendendo la duna. Posò la mano sulla spalla inzuppata di sangue del beccaio. «Grazie, fratello mio.»
Una pausa e poi: «Vuoi bere il shepen?».
Il beccaio scosse la testa, gli porse il coltello e si batté sul collo due dita per indicare dove Imti avrebbe dovuto tagliare; poi si girò e si inginocchiò davanti a lui. Imti non aveva immaginato che il coltello fosse così pesante e difficile da maneggiare: fece appello a tutta la sua forza per portarlo alla gola del beccaio e passarlo sulla carne. Incise più profondamente che poté e un’esplosione di sangue gorgogliante descrisse un arco verso l’esterno sulla sabbia.
«Oh, Ra, aprigli le porte del firmamento» ansimò, deponendo al suolo il cadavere. «Che venga a te e viva per sempre.»
Dispose le braccia del beccaio lungo i fianchi, gli baciò la fronte e tornò in cima alla duna, affondando nella sabbia fin quasi alle ginocchia, sempre stringendo in mano il coltello.
Il sole era sorto quasi completamente, solo il margine inferiore pareva ancora appiattito sulla linea dell’orizzonte; anche a quell’ora mattutina, il calore faceva fremere e vibrare l’aria. Imti guardò il sole a occhi socchiusi, come per calcolare il tempo necessario perché si levasse completamente, quindi si rivolse a occidente, verso la distante guglia di pietra e la massa scura di dirupi più in là. Trascorse un minuto, due, tre. All’improvviso alzò le braccia al cielo e gridò:
«O Khepri, o Khepri,
Atum-Ra all’alba,
il tuo occhio tutto vede!
Proteggi la iner-en sedjet,
custodiscila nel tuo seno!
Siano i malvagi schiacciati nelle fauci di Sobek
e inghiottiti nel ventre del serpente Apep,
per lasciarla riposare in pace e silenzio,
oltre re-en wesir, nella wehat seshtat!»
Si girò di nuovo verso il sole, si tirò sulla testa il cappuccio di pelle di leopardo e, con sommo sforzo, si passò il coltello sul polso, incidendo fino all’osso.
Era un uomo anziano, di più di sessant’anni, e perse rapidamente le forze, gli si velarono gli occhi, la mente gli si annebbiò con un confuso corteo d’immagini. Vide la ragazza dagli occhi verdi nel villaggio della sua giovinezza (oh, quanto l’aveva amata!), la vecchia sedia di vimini sulla Torre di Seshat a Iunu, dove soleva sedersi di notte a osservare il movimento delle stelle, la tomba che si era preparato nella Necropoli dei Veggenti e che non avrebbe mai custodito il suo corpo; almeno, però, aveva lasciato scritta la sua storia, in modo che il suo nome sopravvivesse per l’eternità.
Le immagini turbinarono, s’intrecciarono, si fusero e si divisero, divennero più frammentate e alla fine sbiadirono del tutto; rimasero solo il deserto, il cielo, il sole e, da qualche parte nei pressi, un quieto svolazzare di ali.
All’inizio Imti pensò che fosse un avvoltoio venuto a divorare il suo cadavere, poi si accorse che il rumore era troppo delicato per una creatura così grande. Si guardò intorno, intontito, e vide con sorpresa che in cima alla duna, accanto a lui, c’era un piccolo uccello dal petto giallo, una cutrettola, con la testa inclinata di lato. Non aveva idea di cosa ci facesse là, nel nulla del deserto, ma, debole com’era, sorrise, perché non era forse sotto forma di cutrettola che il grande Benu si era manifestato per la prima volta, chiamando l’alba della creazione dal posatoio in cima alla potente pietra Benben? Questa, di certo, alla fine era la conferma che la loro missione era benedetta.
«Possa egli percorrere le magnifiche vie» mormorò. «Possa egli attraversare...»
Non terminò la frase, si sentì mancare le gambe e cadde bocconi sulla sabbia, morto. La cutrettola gli saltellò intorno per un momento, poi gli si posò sulla spalla. Volse la testa al sole e cominciò a cantare.
Novembre 1986. Pista d’atterraggio di Kukesi,
Albania nordorientale
I russi erano in ritardo all’appuntamento e ciò significava che la finestra meteorologica utile era svanita. Una fitta nuvolaglia correva verso est sui monti Šar e oscurava il cielo del tardo pomeriggio. Quando finalmente la limousine arrivò ai cancelli del campo d’aviazione, già cadevano i primi fiocchi di neve, e nei due minuti che occorsero al veicolo per raggiungere l’Antonov AN-24...