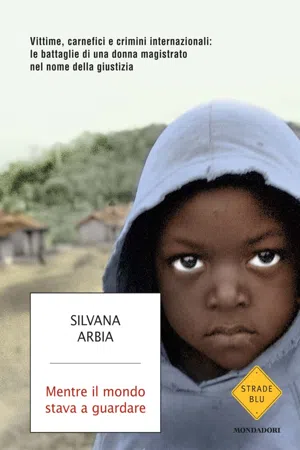![]()
Il 6 febbraio 2002 don Atanasio Sumba Bura, di nazionalità congolese, sacerdote presso la parrocchia dell’Immacolata e San Martino a Montughi di Firenze, atterrò all’aeroporto di Arusha. Arrivava dall’Italia, si era spontaneamente costituito al Tribunale penale internazionale per il Ruanda per dimostrare la sua innocenza. A prima vista, un’intenzione meritevole. Ma la storia di don Atanasio Sumba Bura è una di quelle in cui le apparenze ingannano. Tanto per cominciare, il suo nome era un altro, Athanase Seromba. E non era affatto originario della Repubblica democratica del Congo. Era nato in Ruanda, nel comune di Rutsiro, prefettura di Kibuye, nel 1963. L’unico punto su cui non aveva mentito risultava la sua professione: era un sacerdote cattolico. Educato al Grande seminario di Nyakibanda, aveva ricevuto gli ordini il 18 luglio 1993. Ma tutto questo io lo sapevo già. Su di lui erano state fatte indagini e verifiche molto accurate per la compilazione dell’atto d’accusa, ultimato qualche mese prima, nel giugno 2001.
Nell’aprile 1994, dunque, Athanase Seromba era un sacerdote, e come tale si trovava nella parrocchia di Nyange, nella prefettura di Kibuye. Nei giorni del genocidio era il responsabile di quella chiesa. Eppure, il comportamento che ebbe allora, così come è stato delineato dall’accusa e accertato dai giudici del TPIR, non ha nulla a che vedere con lo spirito e i valori che normalmente animano un prete. È naturale che di fronte a ciò che è stato capace di fare molti provino incredulità e costernazione.
Nessuno più di un sacerdote avrebbe potuto proteggere o, almeno, provare pietà per tutti quegli esseri umani in preda al terrore, perseguitati solo perché tutsi o loro «complici». Nessun tetto avrebbe dovuto essere più sicuro di quello di una chiesa per accoglierli e proteggerli dai loro aguzzini. Nella parrocchia di Nyange, invece, nel giro di soli otto giorni, trovarono la morte almeno millecinquecento persone. E chi avrebbe potuto salvarle si adoperò perché non ne rimanesse viva nessuna. Anche per questo, il processo di Seromba è stato uno dei più delicati di cui mi sono dovuta occupare.
Che fosse un caso diverso da tutti gli altri, d’altronde, se n’erano già accorti anche gli investigatori del TPIR che facevano base negli uffici di Kigali. Avevano raccolto su di lui un corposo dossier, ma esitavano, anche loro increduli che un prete potesse aver agito come risultava dai racconti dei testimoni. Durante una delle mie missioni a Kigali, dove mi recavo di tanto in tanto per visitare i siti dei massacri, incontrare i procuratori nazionali e alcuni testimoni chiave che richiedevano una particolare attenzione, ma anche gli investigatori che collaboravano ai miei casi, alcuni di loro mi sottoposero un dossier su quanto era accaduto a Nyange. Mi chiesero di leggerlo, desideravano un mio parere. Avevano pensato di rivolgersi a me, ben conoscendo la mia propensione a visionare ogni sorta di documentazione disponibile. È stato così che il fascicolo Seromba è arrivato sulla mia scrivania. Lì dentro c’erano le prove che nella parrocchia di Nyange, dove padre Athanase Seromba, alias Atanasio Sumba Bura, nel 1994 era sacerdote e parroco responsabile, avevano trovato la morte almeno millecinquecento tutsi, forse duemila. Il resto è andato da sé: una volta preso atto della solidità di tutta quella documentazione non potevo tirarmi indietro.
Con la mia équipe preparammo l’atto d’accusa, che fu depositato il 20 giugno 2001; il 3 luglio venne confermato dal giudice Williams che accolse anche la nostra richiesta di mandato di arresto internazionale.
Le accuse erano genocidio, o in alternativa complicità in genocidio, complotto con la finalità di commettere genocidio e crimine contro l’umanità, cioè sterminio. Come aveva agito Seromba in quei giorni terribili? Qual era stato il suo ruolo? Che cosa aveva fatto per impedire che la sua chiesa, anche in senso fisico, si trasformasse in un cumulo di cadaveri? Le risposte a queste domande, supportate da prove schiaccianti, inchiodavano questo religioso di fronte a terribili responsabilità.
Eppure, assicurare l’imputato alla giustizia e iniziare il processo non è stato affatto facile. Una volta confermato l’atto d’accusa e ottenuto il mandato di arresto, si sarebbero profilati all’orizzonte ancora molti ostacoli da superare. Sotto la falsa identità di don Sumba Bura, Seromba aveva trovato in Italia non solo un rifugio, ma anche un caloroso clima di simpatia. Si era presentato come un affabile religioso africano di buon cuore, sfuggito a guerre e massacri; difficile negargli solidarietà. In realtà, stava ingannando tutti.
A volte, nel corso del processo, considerando la gravità delle sue azioni e la totale mancanza di pietà e pentimento in quell’uomo, mi sono perfino chiesta se non fosse stato meglio lasciare don Sumba Bura ai suoi nuovi fedeli in Toscana. Sarebbe stato consolante poter credere che ci eravamo sbagliati e che i testimoni avevano mentito. A Firenze i suoi parrocchiani gli si erano sinceramente affezionati. Aveva mistificato la realtà così bene che tutte queste persone alla notizia della sua incriminazione reagirono esprimendo perfino compassione per lui. Lo credevano una vittima, un innocente ingiustamente perseguitato. Anche dopo che la verità iniziò a venire a galla e si seppe con certezza che aveva mentito e cosa aveva fatto, la condanna dei fedeli non fu unanime. Si formarono due schieramenti. Da una parte gli increduli leali a don Sumba Bura che tagliavano corto dicendo che le accuse contro il loro prete erano false. Dall’altra, quelli che cominciavano a nutrire qualche dubbio, prendevano le distanze e iniziavano a chiedersi se i propri matrimoni e i battesimi dei loro figli e nipoti, celebrati da quel sacerdote africano, fossero validi. Si costituì anche un comitato pro don Atanasio con l’obiettivo di sostenere il loro prete ingiustamente perseguitato. Un’iniziativa che però, non ebbe lunga durata.
Nel momento in cui presentammo il mandato d’arresto al governo italiano, con richiesta di eseguirlo, però, si presentarono enormi difficoltà burocratiche e tecniche. Uno stop che stava bloccando anche le procedure della giustizia ad Arusha, non essendo consentito nel sistema del TPIR il processo in contumacia. Perché le procedure facessero il loro corso, era necessario arrestare e trasferire l’imputato in Africa, mettendolo a disposizione del tribunale internazionale, ma queste operazioni spettavano imperativamente all’Italia, dal momento che Seromba risiedeva nel nostro paese dove esercitava le sue funzioni di prete. Il governo italiano, però, si rifiutò di far eseguire l’arresto perché all’epoca – era il 2001 – non aveva ancora attuato lo Statuto del TPIR con una legge apposita, nonostante quest’ultimo fosse stato creato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ben sette anni prima, nel 1994.
Come ho anticipato, il nostro paese aveva comunque l’obbligo di cooperare con il TPIR. Il governo italiano, però, sosteneva che non poteva aver luogo alcun arresto all’interno del sistema nazionale, se non rientrava nei casi previsti dalla legge. Di conseguenza, in mancanza della legge attuativa dello Statuto del TPIR, come anche di una legislazione ordinaria in tale materia, l’arresto non poteva essere eseguito. Le autorità italiane non potevano fare alcunché, ci veniva ripetuto invariabilmente. In pratica, era come se nel sistema legale e giudiziario italiano il TPIR non esistesse. A volte mi dicevo che se altri responsabili di crimini internazionali commessi in Ruanda nel 1994 fossero venuti a conoscenza di quelle circostanze, probabilmente sarebbero accorsi numerosi in Italia, che a quanto pareva in quel momento costituiva un sicuro rifugio per chiunque volesse sottrarsi alla giustizia del TPIR. Una situazione ovviamente imbarazzante. Che poneva con forza una domanda: come mai l’Italia stava tardando tanto ad attuare quello statuto?
Alla fine, il ministro della Giustizia pensò di risolvere la questione applicando il principio di estradizione aut dedere aut iudicare («o estradare o perseguire»).1 Non potendo consegnare Seromba al TPIR, autorizzò quindi la propria magistratura a perseguire Seromba in Italia per i fatti commessi in Ruanda. Una decisione doppiamente opinabile. Innanzitutto il Tribunale penale internazionale per il Ruanda rappresenta una giurisdizione internazionale preminente rispetto a quella dei singoli Stati, tanto da poter perfino avocare casi già iniziati a livello nazionale, mentre l’estradizione riguarda le relazioni tra paesi che concludono un trattato affrontando tutta una serie di questioni sull’applicabilità dei principi generali della stessa. Inoltre, pensai che raccogliere prove e condurre indagini sul genocidio del 1994 era già estremamente difficile per noi procuratori internazionali che operavamo sul posto, figuriamoci per dei magistrati nazionali! Sarebbe stato praticamente impossibile.
Queste gravi inadempienze agli obblighi internazionali in materia di giustizia, però, non erano rimaste inosservate. Alcuni politici le denunciarono e se ne cominciò a parlare. Vi fu pure un’interrogazione parlamentare, presentata alla Camera il 1° agosto 2001, nella quale si chiedeva di conoscere i motivi che avevano fino ad allora impedito l’esecuzione del mandato di cattura internazionale nei confronti di Athanase Seromba. Quella stessa interrogazione invitava il governo a mettere in atto tutte le procedure necessarie per accogliere al più presto la nostra richiesta.
La soluzione più semplice ed efficace per sbloccare la situazione, infatti, era che lo Statuto del TPIR venisse finalmente attuato anche in Italia. Spesso chiamavo Roma per sapere se ci fossero progressi in questo senso. Fu necessario aspettare fino al 2 agosto 2002, quando fu emanata la legge.2 Athanase Seromba si era già costituito al TPIR di Arusha da quasi sei mesi. Abbandonata definitivamente l’identità fittizia di don Atanasio Sumba Bura, alla fine aveva deciso di presentarsi di propria iniziativa, a suo dire per dimostrare la propria innocenza e aiutarci a scoprire la verità su quello che era realmente accaduto a Nyange. Anche il governo italiano, evidentemente, aveva ritenuto che si dovesse fare luce su un caso così spinoso; per agevolare le cose, aveva perfino messo a disposizione del religioso un aereo. A bordo, c’erano solo Seromba e alcuni agenti della polizia italiana che lo scortavano. Uno di loro, qualche giorno prima della partenza, mi telefonò confermandomi l’imminente arrivo del nostro imputato e chiedendomi se avevo bisogno che mi portassero qualcosa dall’Italia. Tanto, l’aereo era vuoto, mi disse. Gli risposi che avere Seromba era più che sufficiente.
L’8 febbraio 2002 si tenne l’udienza di prima comparizione. Fu solo allora che lo vidi di persona. La prima domanda che gli fece il giudice fu: «Come la dobbiamo chiamare? Seromba o Sumba Bura?». Ma ormai, almeno riguardo al nome, la maschera era stata tolta. Non fu così, però, per tutto il resto.
Athanase Seromba si era dichiarato subito non colpevole e io avevo sperato di poterlo incontrare al più presto. Dopotutto, quell’uomo aveva deciso in autonomia di venire fino ad Arusha per discolparsi, dunque avrebbe accettato senza esitazioni di rispondere alle domande dell’accusa, mi ero detta. Di conseguenza, chiesi di poterlo interrogare. Ma lui non accettò.
Il processo iniziò il 20 settembre 2004 e si concluse il 28 giugno 2006. Sessantasette giorni di udienza per il dibattimento e due per le requisitorie e le arringhe. Alla sua apertura, mi ero perlomeno augurata che il sacerdote offrisse ai giudici la propria versione dei fatti. Intendevo condurre io stessa il suo controinterrogatorio e mi ero preparata con grande impegno. Invece, non rilasciò alcuna testimonianza a sua difesa. Si avvalse della facoltà di non rispondere, dimostrando così, al di là dei suoi ostentati buoni propositi iniziali, una ben scarsa volontà di cooperare con la giustizia.
Dunque Seromba si trincerò dietro un atteggiamento ostile, alternando la negazione dei fatti al silenzio. Chi ha visto ciò che resta della chiesa di Nyange, però, non può accettare né l’una né tanto meno l’altro. E io laggiù c’ero stata.
Vi ero giunta dopo un lungo viaggio, che aveva portato me e il mio team di collaboratori attraversando laghi e colline di una bellezza che catturava i sensi e la mente. La visione dei laghi di Kibuye che si insinuano tra le colline mi lasciò senza fiato. Visto dalla cima di un’altura, a strapiombo sulla vallata, l’azzurro intenso di quegli specchi d’acqua, circondato dal verde della vegetazione che si estendeva tutt’intorno, era uno spettacolo così vivido che mi rimarrà per sempre negli occhi. Laggiù la natura non conosce mezze misure e anche i colori sono intensi, netti, senza sfumature. Lungo la strada per Nyange avevamo incontrato molte persone che viaggiavano a piedi. Camminavano con andatura elegante e imponente, del tutto indifferenti al nostro passaggio. Solo i bambini mostravano senza riserve la loro curiosità vedendo i nostri veicoli blindati e scortati da truppe militari messe a disposizione dal governo. Il paesaggio era talmente meraviglioso, di una bellezza quasi sacrale, che mi sembrava incredibile che proprio quei luoghi potessero essere stati teatro di una qualsiasi azione criminale. Una volta giunta a destinazione, però, mi sarei dovuta ricredere: quelle mie prime impressioni si scontrarono con un’altra realtà.
Arrivata a Nyange mi fu mostrata l’area dove fino al 16 aprile del 1994 si trovava la chiesa. Uno spazio abbastanza grande, recintato da pali di ferro. Pensai che sarebbe stato difficile ricostruire gli eventi culminati con la sua distruzione. Visitai anche tutti i luoghi che ci erano stati indicati dai testimoni che avevamo sentito fino a quel momento. Laggiù si era consumato uno dei massacri più atroci della prefettura di Kibuye, tra le prime in Ruanda a compiere rapidamente il «lavoro» contro i tutsi.
La strage più spaventosa era avvenuta proprio all’interno della chiesa, di cui erano rimaste solo le fondamenta. Nel 1994 era stata demolita con l’aiuto di un bulldozer. E mentre le sue mura e le travi si sbriciolavano schiantandosi al suolo tra fumi di polvere, al suo interno morivano schiacciati come scarafaggi degli esseri umani, che tra quelle pareti avevano cercato inutilmente salvezza. Proprio così, la demolizione fu decisa e ordinata con la consapevolezza e la volontà di eliminare una massa di uomini e donne, vecchi e bambini, persone di ogni età e condizione, perseguitati per essere tutsi o semplicemente per non condividere il piano di sterminio del governo. La chiesa era situata vicino alla casa parrocchiale, dove il parroco risiedeva con i propri assistenti. Quest’ultimo edificio era rimasto intatto, come constatai di persona. I suoi balconi davano sul luogo dove un tempo c’era stata la chiesa.
Per circa una settimana quelle persone avevano resistito asserragliate in ciò che avevano creduto un rifugio sicuro, che più tardi si era rivelato una trappola. Erano state lasciate morire senza pietà, tra l’altare e i banchi dove fino a pochi giorni prima probabilmente molti di loro la domenica avevano ascoltato la messa officiata da padre Athanase. In quella stessa chiesa dove i bambini erano stati battezzati e dove molti adulti avevano celebrato il proprio matrimonio e trascorso tanti importanti momenti della loro vita di fedeli. Si erano rifugiati lì convinti che nessuno avrebbe osato violare quel luogo sacro. Avevano creduto che il loro prete li avrebbe protetti.
Le cose andarono diversamente. Non solo Seromba non alzò un dito in loro difesa, ma contribuì alla loro lenta agonia fino allo sterminio finale, cui egli stesso partecipò. Nei giorni di assedio che avevano preceduto la strage impedì ai rifugiati di cercare scampo nel presbiterio, negò loro la possibilità di alimentarsi e si rifiutò di confortarli dicendo una messa. A morire schiacciati sotto le rovine della chiesa furono gli ultimi sopravvissuti a giorni di assalti, tentativi di incendi, aggressioni di ogni tipo. I racconti dei pochi scampati e dei testimoni, in tutto una ventina, che ci aiutarono a ricostruire quanto era accaduto a Nyange, e sul ruolo che vi aveva avuto Seromba, costituiscono ormai una verità accertata.
Nel 1994 il comune di Kivumu aveva una popolazione stimata di circa 53.000 abitanti, di cui circa 6000 tutsi. A quell’epoca, Athanase Seromba era vicario della parrocchia di Nyange. O meglio, secondo diverse testimonianze, era l’unico sacerdote responsabile rimasto, in quanto il curato, padre Karanganwa Straton, se n’era andato. Seromba, allora trentunenne, era in attesa di trasferirsi in un’altra parrocchia; già a marzo aveva ricevuto il nuovo incarico, ma in assenza di padre Straton era rimasto, assumendo la gestione quotidiana della chiesa. Ai fini del processo, dunque, era a tutti gli effetti il responsabile della parrocchia di Nyange.
Nell’atto di accusa sono ricostruiti tutti gli avvenimenti che hanno portato alla strage. In seguito all’attentato al presidente del Ruanda il 6 aprile 1994, anche nel comune di Kivumu erano iniziate le aggressioni contro i tutsi. La sera del 7 vennero uccisi Grégoire Ndakubana e tutta la sua famiglia così come Thomas Mwendezi, un uomo che aveva la sola colpa di avere la carta d’identità «sbagliata». Due sere dopo fu il turno di Martin Karakezi, un commerciante agricolo originario di Ngobagoba, nella località di Gasake, massacrato nel centro di Nyange. Poco distante, a Morumbi, sempre la notte del 7 aprile, erano stati sterminati tutti i membri della famiglia Rudakubana.
Il clima si era fatto incandescente per i tutsi, e restare nelle proprie case era troppo pericoloso. Come in altre località del paese, un fiume di persone terrorizzate si riversò allora per le strade cercando rifugio in edifici pubblici e chiese, compresa quella di Nyange. Nessun luogo poteva apparire a quella povera massa umana più sicuro della propria chiesa. E poi, là ad attenderli c’era padre Seromba, il loro prete. Iniziarono ad arrivare a decine, e chi ancora era in cerca di un ricovero veniva convogliato laggiù. Famiglie che avrebbero magari scelto altre vie di fuga furono individuate dalla polizia locale e trasportate in chiesa con mezzi messi a disposizione dal comune. Tra loro, un tutsi di nome Alexis Karake, sua moglie e i loro sette bambini.
La chiesa di Nyange era grande. Secondo le stime, misurava 55 metri di lunghezza per 19 metri di larghezza e aveva una capacità di almeno millecinquecento persone. In pochi giorni, tra l’8 e il 12 aprile, si era piano piano riempita. Un viavai di auto e camioncini aveva condotto fin là interi nuclei familiari, scolaresche con i loro insegnanti, anziani, donne incinte... Le operazioni erano condotte dalle autorità locali, che si sarebbero poi distinte anche nelle violenze dei giorni a venire.
In quei giorni, le autorità di Kivumu si riunivano anche negli uffici della parrocchia per decidere il da farsi. In uno di questi incontri, tenutosi l’11 aprile e presieduto dal sindaco, si decise che tutti i tutsi dovevano essere raggruppati nella parrocchia di Nyange. Inoltre, si stabilì di richiedere l’invio di gendarmi dalla prefettura di Kibuye. I rinforzi furono visti arrivare in giornata. La macchina dello sterminio era avviata e funzionava con impressionante velocità ed efficienza.
A partire da quel giorno, di fatto i tutsi che si erano rifugiati volontariamente nella chiesa di Nyange vi si trovarono prigionieri. Senza cibo né acqua e guardati a vista dai gendarmi. Un vero e proprio campo di concentramento. Intanto, erano arrivati anche i miliziani dell’Interahamwe che circondarono l’edificio. Questi ultimi erano muniti di armi da fuoco e di tipo tradizionale come machete, spade, lance e bastoni. I fuggiaschi erano in trappola.
Alcuni insegnanti che si trovavano tra i rifugiati chiesero a padre Seromba se fosse possibile almeno prend...