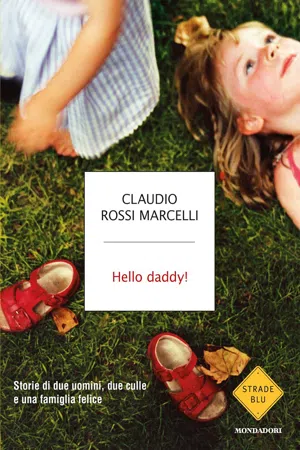![]()
![]()
Lo ammetto. Il fatto che fosse un’attivista di destra mi ha spinto a darle la notizia con un pizzico di gusto e senza l’ombra di comprensione per le sue evidenti tendenze conservatrici. Gliel’ho detto chiaro e tondo: «Queste bambine hanno due papà». E la rappresentante di lista di Forza Italia ha fatto un’espressione che per qualche secondo non sono riuscito a decifrare.
Era la prima volta che andavamo a votare tutti e quattro insieme. Io e Manlio abbiamo messo le bambine nel passeggino doppio e ci siamo incamminati verso il seggio elettorale, in una scuola elementare in fondo alla strada. Nel viavai di donne bionde e ingioiellate che andavano a dare il loro voto alla destra, noi eravamo il solito strano fenomeno che girava per il quartiere: ben quattro persone con meno di 60 anni, tutte in una volta.
Ai Parioli ci abitano solo vecchi. E quando i vecchi passano a miglior vita, arrivano altri vecchi leggermente meno vecchi che hanno aspettato tutta la vita per finire di invecchiare qui. C’è un ricambio velocissimo, ma l’età media del quartiere continua a coincidere con quella dell’aspettativa di vita della popolazione italiana: 77,5 anni per gli uomini e 83,5 anni per le donne. I bambini sono una rarità e i gemelli un vero e proprio fenomeno da baraccone, che genera ovunque reazioni isteriche.
Una volta, mentre spingevo il passeggino lungo viale Parioli, una signora è uscita da un portone e ha sgranato gli occhi appena ci ha visti. Avrà avuto su per giù 83,5 anni. Si è avvicinata con una certa fretta e ha detto: «Cosa vedo, due bambine!». A quanto pare anche la signora aveva familiarità con le statistiche dei Parioli: «In questo quartiere si fanno più funerali che battesimi. L’ultimo bambino che è nato nel mio palazzo è stato mio figlio. Che ora ha 55 anni».
Accecati dalla vista di tanta gioventù, e da qualche millimetro di cataratta, gli anziani dei Parioli tendevano a non notare altre cose, come per esempio il fatto che le fanciulle se ne andassero in giro con due uomini. Raramente si arrivava ad affrontare la questione nei dettagli, ma alla rappresentante di lista di Forza Italia appostata al seggio elettorale non ho potuto evitare di raccontarlo. Io avevo già votato e ora stavo aspettando con le bambine che votasse Manlio. La rappresentante di lista si avvicina e si accovaccia all’altezza del passeggino per giocare con le bambine. «Che amore, sono gemelle?»
Era un donna decisamente robusta e la spilletta di Forza Italia si perdeva come una goccia nell’oceano di stoffa blu che copriva le sue tettone. «Però immagino che fatica per la vostra povera mamma, eh?» No, no, le faccio io, semmai per il povero papà. Queste bambine hanno due papà. «Ma davvero?» mi chiede lei voltandosi sorpresa verso di me. Poi torna a giocare con le bambine, ma ora le fissa con uno sguardo assente. «Io l’ho sempre detto,» aggiunge infine, mentre Clelia le stringe forte l’indice, «certi papà sono più mamme delle mamme. Il mio ex marito era così, ci sarebbe voluto restare lui a casa con i bambini. E invece abbiamo sbagliato tutto.» A quel punto ci ha raggiunto Manlio e la rappresentante forzista si è alzata di scatto, ricomponendosi in fretta. «Lei è l’altro papà? Complimenti davvero. Sono bellissime.»
Il quartiere, quindi, ci aveva accolti bene. Compreso l’elettorato di centrodestra. E intanto, a casa nostra, si celebrava un banchetto senza fine: gli amici e i parenti passavano a tutte le ore, portando regali e cose da mangiare che si andavano ad aggiungere all’enorme buffet sul tavolo del salotto. C’era un’atmosfera di festa, ma anche di emergenza. Come se a me e Manlio fosse capitata una meravigliosa tragedia. Ma noi due badavamo poco alla folla: eravamo completamente rincoglioniti dal sonno, dalla fatica e dalla gioia.
TWITTER: Sono stato punto da un ragno annidato nel mio accappatoio. Non so ancora di chi sia la colpa, ma una cosa è certa: rotolerà qualche testa.
* * *
Da ragazzino andavo a scuola a piedi, compravo la pizza lungo la strada e mi limitavo a seguire il flusso di studenti senza mai deviare. Mi piaceva il mio quartiere ma, in un contesto sociale che avrebbe trasformato il piccolo Salvador Dalì in un notaio di successo, la mia condizione era leggermente diversa dagli altri. La mia era, infatti, una famiglia molto giovane.
Mi ricordo esattamente il giorno in cui mia madre ha compiuto trent’anni. Me lo ricordo perché l’ho vissuto con una certa ansia: «Oddio, mamma ha trent’anni. È diventata vecchia». Avere due figli quando si è ancora molto giovani oggi può sembrare una disgrazia – perché probabilmente oggi lo è –, ma all’epoca usava così. E quando, tre estati dopo il suo trentesimo compleanno, mamma ci ha annunciato che era in arrivo una sorellina, io ho pensato: «Povera bambina, avrà una madre anziana». In realtà i miei non si negavano proprio niente: viaggi, cinema, feste, amici, giri in barca e gare culinarie. Io e mio fratello, sempre nel bel mezzo di tutto, ci siamo goduti i nostri genitori nel fiore degli anni, ricevendo un’impronta di freschezza, di elasticità mentale che solo dei ventenni possono trasmettere ai figli.
Chiaramente, c’è stato anche un prezzo da pagare. E non parlo solo del ritornello martellante che ho dovuto subire io in tutti i miei anni da fannullone fuoricorso: «Io, alla tua età, avevo già due figli...». C’è quello di una donna che, affondata da due gravidanze, ha finito per lasciare la facoltà di architettura rinunciando alla sua realizzazione professionale. Il prezzo da pagare è stato l’amore smodato che questa donna ha sviluppato nei confronti della normalità. «Se il mio lavoro è fare la madre e la moglie,» si sarà detta a un certo punto «allora la mia famiglia dev’essere perfetta.»
In questo, mamma era sostenuta da tutto il vicinato: il quartiere Trieste. È una zona di Roma piuttosto elegante, con viali alberati e negozi per ricche signore gestiti da signore ancora più ricche. Ai Parioli, ormai una Mecca per arricchiti, già da anni si bisbiglia a mezza bocca che ci sia stato il tanto temuto sorpasso, e che il quartiere Trieste sia diventato la vera dimora dell’alta borghesia romana. Con le sue grandi scuole pubbliche e tante scuole private, con il mercato rionale e le pasticcerie della domenica, al quartiere Trieste la prima volta che vai a casa di qualcuno ti presenti con la piramide d’oro di Ferrero Rocher. Un quartiere di cui, al di là dei film di Muccino, si parla poco perché non succede mai nulla di male. L’unica volta che due portieri, ovviamente non autoctoni, si sono accoltellati, il telegiornale ha parlato di «crimine efferato che ha sconvolto la raffinata tranquillità del quartiere Trieste».
La vita in una zona borghese è piuttosto semplice perché fin da piccolo sai già cosa devi fare. Le grandi scelte della vita sono solo dei finti bivi, inventati per lasciarti l’illusione di aver fatto davvero una scelta: liceo classico o liceo scientifico; legge o architettura, matrimonio civile o religioso, gatto o cane, figli subito o figli dopo, seconda casa al mare o seconda casa in campagna. Tutto sembra filare sempre liscio e, anche quando le cose non vanno bene, a seppellire tutto ci pensa quel terrore dell’opinione altrui che serpeggia fra gli abitanti.
Sarà per questo terrore che mia madre non ha voluto sentire ragioni quando la imploravo di chiamare Madonna la nostra nuova sorellina, scegliendo invece un nome tipicamente «Agnelli». E sarà sempre per questo che non l’ha presa bene quando le ho detto che sono gay. Lei non aveva davvero nulla contro le persone omosessuali. Ma, semplicemente, la mia omosessualità andava contro il suo primo comandamento: «Va bene se capita agli altri, basta che non capiti a me». Con tutta obiettività, i gay della sua generazione non hanno certo avuto vita facile, e così lei si preoccupava che passassi un’esistenza in solitudine, senza famiglia e allontanato da tutti. Paure legittime, che però convivevano dentro mia madre con un inquilino piuttosto ingombrante: la paura di quello che diranno gli altri.
Per una donna innamorata del concetto di «normale», questa cosa dell’omosessualità era dura da digerire. Per mia madre dire «normale» equivale a dire «come piace a me». Il cornetto normale è quello con la crema. I capelli normali sono quelli con la riga da una parte, un po’ all’indietro, e le scarpe normali sono tutte tranne gli anfibi. Lei provò a tendermi qualche trappola per vedere se ritornavo normale, e cioè eterosessuale: mi ha portato da un prete di periferia, che mi ha imposto le mani e mi ha chiesto se sentivo il demonio dentro di me. Ma io non l’ho sentito. E poi mi ha mandato dalla psicoanalista dei Parioli alti: una donna fichissima, di quelle che hanno viaggiato quando nessuno ancora viaggiava e che quindi diceva cose eleganti tipo «Quando abitavamo in Isvezia» o «Durante il nostro primo soggiorno in Persia». Una gran donna, che mi ha insegnato qualche trucco del mestiere e con cui, dopo un paio d’anni di terapia, mi sono accordato per cambiare paziente: «Secondo me sarebbe meglio che da lei ci venisse mia madre». «Secondo me, pure» aveva risposto lei, mettendo così la parola fine al mio biennio junghiano.
Fu una separazione amichevole, dovuta anche al fatto che mi ero trovato un fidanzato che a lei non piaceva per niente. Un po’ farfallone l’aveva definito. Che cantonata: poteva dirmi che dopo dieci anni di fidanzamento avrebbe deciso che guardare la tv è meglio che uscire o che avrebbe cominciato a russare o che avrebbe amato decisamente troppo il suo lavoro nell’ufficio marketing di una grossa azienda di detersivi. Ma farfallone Manlio non lo è proprio.
Di me, invece, la psicoanalista dei Parioli alti pensava solo il meglio. Sentire che una donna così raffinata – santo dio, diceva «in Isvezia»! – aveva una grande opinione di me mi ha rimesso completamente a posto con me stesso. Eh sì, perché con tutto che io ero stato un ragazzino molto estroverso e sicuro di me, nella prima adolescenza qualche periodo di vacillamento ce l’avevo avuto. In pochi anni, però, ho ripreso pieno controllo della famiglia e ho ricominciato a dettare legge su mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella. Ora che avevo fatto due anni di analisi avevo sempre ragione io e, per esempio, nessuno osò contraddire l’idea che adesso dalla psicoanalista ci dovesse andare mia madre.
Mi chiedo ancora se quella professionista della mente avesse scoperto che sono un maniaco del controllo. Probabilmente sì, anche se forse non coglieva a pieno in quale misura. Ne sono sicuro: nessuno può immaginare quant’è faticosa la vita di un maniaco del controllo. Di quella persona, cioè io, che deve tenere tutto sotto controllo e fare in modo che il resto del mondo faccia esattamente quello che dice lui, cioè io. Man mano che passano gli anni, il maniaco del controllo alza il tiro dei suoi obiettivi e, mentre la gente che ha intorno comincia a rendersi conto della sua malattia, lui impara a fare tutto in modo sempre più invisibile. Anche a far crescere i glicini nell’esatta direzione scelta da lei, cioè mia madre.
Io avevo deciso che la mia vita sarebbe andata in un certo modo: mi sarei trovato un lavoro, mi sarei sposato e avrei avuto dei figli. Come i miei vicini di corso Trieste. Questa storia dell’omosessualità non doveva diventare una deviazione. In realtà, poi ho saputo che molti dei miei ex compagni di scuola passavano la vita a cercare di uscire dai confini del loro tragitto prestabilito: chi era partito per l’Africa, chi faceva il musicista contemporaneo, chi si rifiutava categoricamente di sposarsi. Io invece facevo l’impossibile per cercare di rientrarci. Ero un borghese per scelta e il mio vero obiettivo era quello di avere una vita normale. E, quando dicevo «normale», intendevo dire «come piace a me».
TWITTER: Ricordo a tutti i non residenti che camminano per i Parioli che da noi le banconote per terra non si raccolgono perché pare brutto.
* * *
Per fortuna ad aiutarci c’era Ruriko, l’amica giapponese che avevo ingaggiato come tata ancora prima di concepire le bambine. Quando si dice una persona organizzata! All’inizio le avevo proposto di darci una mano qualche ora al giorno ma, da quando era arrivata la notizia dei gemelli, mia madre continuava a insistere perché le facessimo firmare un contratto vincolante a vita con detenzione forzata in caso di recesso.
«Deve abitare con voi. Giorno e notte.» Mamma, la nostra vita sarà rivoluzionata già abbastanza e non mi sembra il caso di diventare perfino in cinque. «Claudio,» rispondeva lei con la sicurezza di chi ha gestito una famiglia numerosa per trent’anni «quando avrai due bambini scenderai in strada a tirar su la prima persona che passa, chiunque sia, basta che ti dia una mano. Sarà un inferno, credimi.»
Che esagerazione. Come la sua pretesa di aumentare il numero di ore in cui veniva la signora delle pulizie: «Claudio, Myrna dovrà venire tutti i giorni. Per quattro ore!». Mia madre, insomma, si era autonominata senior staff manager di casa mia e continuava a fare lievitare il numero di persone che ci avrebbero dovuto aiutare. All’epoca non potevo neanche immaginare fino a che punto avesse ragione.
Si dice sempre che l’arrivo di un bambino è una cosa che ti cambia la vita. Be’, l’arrivo di due bambine contemporaneamente è una cosa che ti prende la vita, te la capovolge, te la calpesta e ci piscia sopra. Il tutto due volte. Quello che resta non è affatto male, ma non somiglia neanche più lontanamente a una vita.
Meno di una settimana dopo il nostro ritorno da Columbus, Ruriko abitava con noi. Giorno e notte. E io avevo comunque la tentazione di scendere in strada e tirare su qualcun altro. Due neonate in una volta sola sono troppe, soprattutto se prendono il latte ogni due ore e mezza. Considerato che per ogni poppata bisognava preparare il latte artificiale e che le creaturine non avevano la decenza di svegliarsi insieme, la notte si riduceva a un’unica, interminabile monopoppata. Dopo le prime visite emozionate, gli amici ho cominciato a vederli sempre meno. Alberto, mio fedele alleato per tutto il periodo della gravidanza, era completamente sparito, assorbito dalla nuova casa e dal nuovo fidanzato. Manlio era tornato al lavoro e io, rimasto unico padre a tempo pieno, ho conosciuto le gioie della depressione postparto.
In quei primi mesi, il mio vero momento di pace era la lunga passeggiata che facevo ogni giorno con Ruriko e le bambine. Spesso attraversavamo Villa Borghese in tutta la sua larghezza e arrivavamo ad affacciarci al belvedere del Pincio. Ci tenevo a salutare il cupolone, che nonostante tutto continuava a troneggiare sui tetti di Roma, con la faccia tronfia di chi non vuole ammettere la sconfitta. Parlavamo poco io e lei, ma controllavamo sempre lo stato dei germogli di mandorlo che incontravamo lungo la strada. Avevamo la certezza che l’arrivo della primavera avrebbe aperto una fase meno devastante della nostra esistenza.
Tutte le persone che ci vedevano girare per il quartiere ci prendevano per una bella famigliola multietnica. Anzi, tutte meno una: la scaltra fruttivendola dei Parioli. Un giorno, mentre attraversavamo per l’ennesima volta il mercato rionale, la fruttivendola ci corre incontro sbracciandosi e urlando: «Le gemelle! Fatemi vedere le gemelle!». E senza darci il tempo di di...