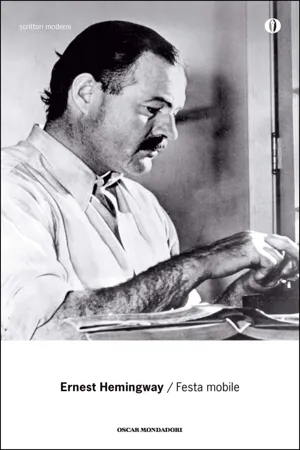Il suo talento era naturale come il disegno tracciato dalla polvere sulle ali di una farfalla. In un primo tempo non lo capì più di quanto lo capisca la farfalla, ed egli non se ne accorse neppure quando il disegno fu guastato o cancellato. Più tardi si rese conto delle sue ali danneggiate e comprese com’erano fatte e imparò a riflettere e non riuscì più a volare perché era scomparso l’amore per il volo e poté solo ricordarsi di quando volare non gli era costato il minimo sforzo.
La prima volta che incontrai Scott Fitzgerald accadde una cosa molto strana. Molte cose strane accaddero con Scott, ma questa non riuscii mai a dimenticarla. Era entrato nel Dingo Bar di rue Delambre dove mi trovavo con alcuni personaggi del tutto insignificanti, si era presentato e aveva presentato l’uomo alto e simpatico che lo accompagnava: Dunc Chaplin, il famoso giocatore di baseball. Non avevo seguito il baseball di Princeton e non avevo mai sentito parlare di lui, ma Dunc Chaplin era un tipo simpaticissimo, placido, calmo e cordiale e mi piacque molto più di Scott.
A quel tempo Scott sembrava un ragazzo con un viso tra bello e grazioso. Aveva capelli ondulati, biondissimi, una fronte alta, occhi spiritati dallo sguardo dolce, e una bocca irlandese, delicata, con le labbra sinuose, che, se fosse appartenuta a una ragazza, sarebbe stata la bocca di una bellezza. Il mento era ben fatto, le orecchie proporzionate e il naso regolare, bello, quasi perfetto. La somma di questi attributi non avrebbe dovuto dare un bel viso, ma la bellezza era nell’incarnato, nei capelli biondissimi e nella bocca, quella bocca che riusciva inquietante finché non lo avevi conosciuto meglio, e poi anche maggiormente.
Desideravo molto vederlo e avevo sgobbato tutto il giorno e sembrava davvero magnifico trovarsi in compagnia di Scott Fitzgerald e del grande Dunc Chaplin che non avevo mai sentito nominare ma che adesso era un amico. Scott parlava senza sosta e poiché ciò che diceva mi metteva in imbarazzo – parlava dei miei scritti e di com’erano belli – mi misi a guardarlo attentamente e a osservare invece di ascoltare. Tra noialtri, allora, valeva ancora il principio che di certe lodi c’era piuttosto da vergognarsene. Scott aveva ordinato champagne e lui e Dunc Chaplin e io lo bevemmo in compagnia, credo, di alcuni di quegli individui insignificanti ai quali ho accennato. Non credo che Dunc o io seguissimo il discorso con molta attenzione, perché si trattava di un discorso vero e proprio e io continuavo a osservare Scott. Era agile di corporatura, ma non sembrava in gran forma perché aveva il viso un po’ gonfio. L’abito comperato da Brooks gli stava a pennello e portava una camicia bianca con le punte del colletto abbottonate e una cravatta con i colori delle Guardie Reali. Pensai che forse dovevo dirgli della cravatta, perché gli inglesi ce li aveva anche Parigi e uno avrebbe potuto entrare nel Dingo; anzi, ce n’erano due proprio in quel momento. Ma poi pensai: al diavolo, e mi rimisi a osservarlo. In seguito saltò fuori che la cravatta l’aveva comperata a Roma.
Ormai a guardarlo non avevo più gran che da scoprire tranne che aveva belle mani non troppo piccole, e quando si sedette su uno degli sgabelli del bar vidi che le sue gambe erano molto corte. Con un paio di gambe normali credo che sarebbe stato cinque centimetri più alto. Avevamo finito la prima bottiglia di champagne e attaccato la seconda e ormai la conversazione stava scemando.
Sia Dunc che io cominciavamo a sentirci meglio ancora di come ci eravamo sentiti prima dello champagne ed era una bella cosa che il discorso stesse per finire. Fino a quel momento avevo sempre avuto l’impressione che la mia grandezza di scrittore fosse stata accuratamente tenuta segreta tra me e mia moglie e quelle poche persone che conoscevamo abbastanza bene per rivolgere loro la parola. Ero lieto che, quanto a questa possibile grandezza, Scott fosse giunto alla stessa felice conclusione; ma ero anche lieto che stesse cominciando a esaurire gli argomenti. Però dopo il discorso venne l’interrogatorio. Potevi studiarlo e trascurare di seguire il discorso, ma alle domande non si sfuggiva. Scott, stavo per scoprire, era convinto che il romanziere potesse trovare ciò che aveva bisogno di sapere interrogando amici e conoscenti. Le domande erano poste a bruciapelo.
«Ernest» disse. «Non ti secca se ti chiamo Ernest, eh?»
«Chiedilo a Dunc» dissi.
«Non fare lo sciocco. No, sul serio, senti, dimmi una cosa: con tua moglie prima di sposarvi siete andati a letto?»
«Non lo so.»
«Come sarebbe a dire, non lo so?»
«Non me ne ricordo.»
«Ma come fai a non ricordarti di una cosa del genere?»
«Non lo so; che strano, eh?»
«È peggio che strano» disse Scott. «Dovresti ricordartene per forza.»
«Mi dispiace. Peccato, eh?»
«Non parlare come uno di questi inglesi delle balle» disse lui. «Cerca di essere serio e di fartelo venire in mente.»
«No» dissi. «È inutile.»
«Potresti fare un sincero tentativo di ricordare.» Costa parecchio caro quel suo discorso, pensai. Chissà se lo faceva a tutti. Ma non doveva essere così perché lo avevo visto sudare mentre parlava. Il sudore aveva imperlato di goccioline il suo perfetto labbro da irlandese, ed era stato allora che avevo distolto lo sguardo dal suo viso abbassandolo per controllare la lunghezza delle gambe, che teneva raccolte mentre sedeva sullo sgabello del bar. Poi tornai a guardarlo in viso e fu allora che accadde il fatto strano.
Mentre sedeva al bar con in mano la coppa di champagne la pelle del suo viso parve tendersi finché ogni gonfiore scomparve e poi continuò a tendersi fin quando il viso non sembrò un teschio. Gli occhi s’infossarono e cominciarono a sembrare spenti e le labbra erano tese e il colorito abbandonò il viso, tanto che esso assunse il colore della cerogine di candela. Non era frutto della mia immaginazione. Il suo viso divenne un autentico teschio, o una maschera di morte, sotto i miei occhi.
«Scott» dissi. «Stai bene?»
Non rispose. Il suo viso era sempre molto contratto.
«Sarà meglio che lo portiamo a un posto di pronto soccorso» dissi a Dunc Chaplin.
«Ma no, sta bene.»
«Ma sembra che stia per morire.»
«No. È una cosa che gli capita ogni tanto.»
Lo caricammo su un tassì e io ero molto preoccupato ma Dunc disse che stava benone e di non preoccuparmi per lui. «Probabilmente si rimetterà del tutto prima di arrivare a casa» disse.
E dovette andare proprio così, perché cadde dalle nuvole, pochi giorni dopo, quando lo incontrai alla Closerie des Lilas e gli dissi del brutto scherzo che gli aveva fatto quello champagne. Dissi che chiacchierando forse l’avevamo bevuto troppo in fretta.
«Come sarebbe a dire che sei spiacente? Cos’è che mi ha colpito a quel modo? Di che stai parlando, Ernest?»
«Volevo dire l’altra sera al Dingo.»
«Al Dingo non mi è successo proprio niente. Semplicemente mi sono stancato di quei noiosissimi inglesi che erano con te e sono andato a casa.»
«Non c’era nessun inglese quando tu sei arrivato. Solo il barista.»
«Non fare misteri. Sai bene a chi alludo.»
«Oh» dissi. Era tornato al Dingo più tardi. O c’era andato un’altra volta. No, ora ricordavo, effettivamente c’erano due inglesi. Era vero. Ricordavo chi erano. Non si erano mossi per tutta la sera.
«Sì, certo» dissi.
«Quella ragazza dal titolo fasullo che era così villana e lo sciocco ubriaco che l’accompagnava. Sostenevano di essere tuoi amici.»
«Infatti. E lei è molto villana, certe volte.»
«Vedi? È inutile fare misteri solo perché uno ha bevuto qualche bicchiere di vino. Perché volevi fare misteri? Non ti credevo il tipo.»
«Non so.» Volevo cambiare discorso. Allora mi venne in mente una cosa. «Sono stati scortesi a proposito della cravatta?» domandai.
«Perché avrebbero dovuto essere scortesi a proposito della cravatta? Portavo una cravatta nera, di maglia, con una camicia sportiva bianca.»
A questo punto mi arresi e lui mi domandò perché mi piaceva quel caffè e io gli spiegai com’era una volta e allora cominciò anche lui a sforzarsi di trovarlo piacevole e restammo là seduti, io che lo trovavo piacevole e lui che si sforzava di trovarlo piacevole, e mi fece delle domande e mi parlò di scrittori ed editori e agenti e critici e di George Horace Lorimer, e dei pettegolezzi e dei problemi che comportava l’essere uno scrittore affermato, ed era cinico e divertente e molto allegro e affascinante e affettuoso, anche se si osservava la massima prudenza con chiunque diventasse troppo affettuoso. Parlava con sprezzo ma senza amarezza di tutto ciò che aveva scritto, e capii che il suo nuovo libro doveva essere molto buono per permettergli di parlare senza amarezza dei difetti degli altri libri. Voleva che leggessi il nuovo libro, Il grande Gatsby, appena fosse riuscito ad avere indietro la sua ultima e unica copia dalla persona alla quale lo aveva prestato. A sentirlo parlare, non avresti mai capito quant’era buono, solo che lui aveva nei confronti del suo libro il riserbo che hanno tutti gli scrittori non presuntuosi quando sono riusciti a fare qualcosa di molto bello, e io speravo che glielo restituissero al più presto per poterlo leggere.
Scott mi disse di avere saputo da Maxwell Perkins che il libro non si vendeva bene ma che aveva avuto recensioni favorevolissime. Non ricordo se fu lo stesso giorno, o molto tempo dopo, che mi mostrò una recensione di Gilbert Seldes che non avrebbe potuto essere migliore. Avrebbe potuto essere migliore solo se fosse stato migliore Gilbert Seldes. Scott era perplesso e addolorato per il fatto che il libro non si vendesse bene ma, come dicevo, allora non era affatto amareggiato ed era insieme schivo e felice del buon livello del libro.
Quel giorno mentre stavamo seduti fuori sulla terrasse dei Lilas e vedevamo farsi buio e la gente passare sul marciapiede e la luce grigia della sera che mutava, non si verificò in lui alcun mutamento chimico a opera dei due whisky e soda che bevemmo. Spiai il sopraggiungere di quel mutamento, ma non venne, e lui non mi pose domande sfacciate, non fece nulla d’imbarazzante, non tenne discorsi e si comportò da persona normale, intelligente e piena di fascino.
Mi disse che a causa del maltempo lui e Zelda, sua moglie, erano stati costretti ad abbandonare a Lione la loro piccola Renault e mi chiese se volevo andare giù in treno a prenderla e tornare a Parigi in macchina con lui. I Fitzgerald avevano affittato un appartamento ammobiliato in rue de Tilsitt 14, poco lontano dall’Etoile. Ormai era primavera inoltrata e pensai che la campagna sarebbe stata in pieno rigoglio e che avremmo potuto fare un ottimo viaggio. Scott sembrava così gentile e così ragionevole, e lo avevo visto bere fino all’ultima goccia due whisky e non era successo nulla, e il suo fascino e il suo apparente buonsenso facevano sembrare la serata al Dingo un brutto sogno. Perciò dissi che lo avrei accompagnato giù a Lione molto volentieri: quando contava di partire?
Fissammo un appuntamento per l’indomani e decidemmo di partire per Lione col direttissimo del mattino. Questo treno partiva a un’ora comoda ed era molto veloce. Faceva una sola fermata, a Digione, se ben ricordo. Il programma era di arrivare a Lione, far controllare e rimettere in ordine la macchina, farci un buon pranzo e ripartire per Parigi il mattino seguente di buon’ora.
L’idea del viaggio mi rallegrava moltissimo. Sarei stato in compagnia di uno scrittore affermato, più anziano di me, e in macchina, nelle ore che avremmo avuto a disposizione per discorrere, avrei certo imparato molte cose che mi sarebbe stato utile sapere. È strano ora ricordare che pensavo a Scott come a uno scrittore più vecchio, ma allora, non avendo ancora letto Il grande Gatsby, lo credevo molto più vecchio di me. Ricordavo che per il «Saturday Evening Post» aveva scritto tre anni prima dei racconti che si erano letti ma non lo avevo mai ritenuto uno scrittore serio. Alla Closerie des Lilas mi aveva spiegato come scriveva per il «Post» quelli che considerava dei buoni racconti, e che in effetti erano ottimi racconti, e poi li cambiava docilmente, perché sapeva che cosa doveva fare per trasformarli in racconti da vendere alle riviste. La confessione mi aveva scandalizzato e gli dissi che secondo me ciò equivaleva a sputtanarsi. Lui disse che era effettivamente un modo di sputtanarsi, ma che doveva farlo perché le riviste gli permettevano di guadagnare i soldi per scrivere libri decenti. Dissi che non credevo che qualcuno potesse scrivere senza distruggere il suo talento se non al meglio delle sue possibilità. Ma lui rispose che siccome prima scriveva il racconto vero e proprio, le modifiche e i cambiamenti che vi apportava in seguito non gli arrecavano il minimo danno. Questo per me non era concepibile e avrei voluto persuaderlo che aveva torto, ma mi occorreva un romanzo per rafforzare la mia fiducia e per mostrarglielo e convincerlo, e non avevo ancora scritto un romanzo del genere. Da quando avevo cominciato a demolire tutti i miei scritti e a evitare ogni facile soluzione cercando di “fare”, anziché descrivere, scrivere era diventata una cosa magnifica. Ma era molto difficile, e non sapevo se sarei mai riuscito a scrivere qualcosa che fosse proprio lungo come un romanzo. A volte impiegavo un’intera mattina per finire un paragrafo.
Hadley era contenta che facessi questo viaggio, anche se non prendeva sul serio le pagine di Scott che aveva letto. Per lei lo scrittore di valore era incarnato in Henry James. Ma trovava una buona idea che mi prendessi un po’ di vacanza per fare quel viaggio, anche se desideravamo tutti e due avere abbastanza soldi per comperare una macchina e andarcene in giro per conto nostro. Ma quella era una cosa che non pensavo sarebbe m...