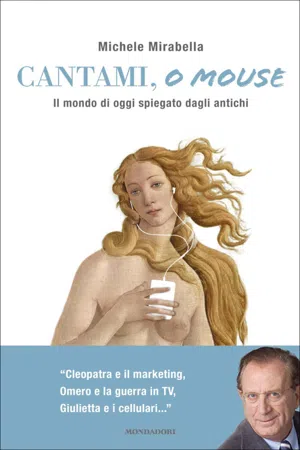![]()
Pippa. Un nome di donna, anzi un vezzeggiativo attivato da una soave lallazione. Pippa deriva da Filippa. Ci pare di sentire la tenerezza materna che intrattiene la pupa Pippa alle prese con la pappa. La pappa di Pippa. E per chi è la minestrina? Per lo zio? No! Per il nonno? No! E, vola vola vola, è per questa bimba! Una bimba destinata al red carpet più altezzoso e altolocato che si possa sognare di calcare. Pippa sarà famosa. Grazie a una sorella che si chiamava Catherine con l’acca, come garantisce Wikipedia che ci segnala anche il suo vezzeggiativo Kate.
C’era una volta un principe non particolarmente azzurro e non particolarmente solitario. Un principe moderno, un’altezza reale che guidava l’elicottero, beveva birra con gli amici e giocava a racchettoni. Suo fratello, più giovane e, quindi, un po’ meno principe, qualche volta esagerava: beveva birra più alcolica e si vestiva da nazista. Per scherzo, si scusava. Di cognome facevano Windsor. Sì, signora mia, proprio loro. Dio salvi la regina.
Il principe principale, detto anche “erede al trono”, si chiamava William e, forse, gli amici lo chiamavano Bill. Bill si innamora di Kate, che si era preventivamente innamorata di Bill, e gli eventi felicemente precipitano: gli dèi Windsor sono tutti d’accordo, i mortali Middleton pure, tripudiando. E ci mancherebbe altro.
Nel reticolo della favola si colora la cronaca dei nostri giorni: le regali nozze si celebrano in grande spolvero nella primavera dell’anno del Signore 2011. William potrebbe succedere a sua maestà la regina Elisabetta II da un momento all’altro. Il più tardi possibile, si affrettano ad augurare gli affezionati sudditi del Regno Unito. Quanto a Kate, da un momento all’altro diventerebbe principessa consorte.
Tutto va liscio, i due giovani si sposano nell’abbazia di Westminster ed è il matrimonio del secolo, anche se i soliti maligni obiettano che sia un po’ presto per stabilirlo: vuoi che nei prossimi ottantanove anni non si trovino un altro paio di semidei che convolino a nozze altolocate? Aspettiamo a decidere.
Chi non aspetta, invece, sono i media che, con assiduità, nell’ultimo secolo hanno allietato tutte le feste in casa Windsor con la loro discreta presenza. Già negli anni Trenta, quando le tecnologie emettevano pionieristici e britannici vagiti televisivi, la BBC trasmise la solenne processione in Hyde Park per l’incoronazione di Giorgio VI. Gli indici di ascolto furono quelli che furono, un’inezia, ma l’importante era cominciare. Negli anni Cinquanta un’altra grande diretta: l’incoronazione di Elisabetta II. Per l’occasione la stampa inglese si preoccupò di coniare il neologismo “eurovisione” per spiegare al pubblico il collegamento tra le reti europee.
Il tripudio per le nozze di Carlo e Diana ancora rimbomba dagli anni Ottanta e continua a essere evocato dall’immane tabloid globale. Con William e Catherine i media del terzo millennio non possono che scodinzolare alla festa acclamata dietro una cortina di sicurezza di cinquemila uomini e davanti a una platea di miliardi di spettatori incantati. Ma c’è un’ombra che appanna la gioia di ciambellani e caudatari e, soprattutto, toglie il sonno al royal art director: le iniziali dei nomi degli sposi.
William e Catherine, WC. WC vuol dire “gabinetto”, non c’è niente da fare, in tutta Europa, figuriamoci in Inghilterra dove l’acronimo ha gorgogliato per la prima volta. E non nel senso di “governo” o “ufficio”, come si usa qualche volta dire in Italia. Già dire “gabinetto di sua maestà” sarebbe in ogni caso sconsigliabile, figuriamoci emblematizzare fauste nozze regali con WC ricamato dovunque, trascritto sugli inviti, le partecipazioni, i menu, istoriato sulle porcellane e i cristalli, intarsiato nelle boiseries, proiettato rumorosamente nelle sigle televisive. Abbreviazione impensabile e riprovevole, WC non può essere. E non è.
Si cambia l’ordine tradizionale delle iniziali nei souvenir del matrimonio. Ne deriva che la “C” della borghese Catherine sovrasta la “W” del nobile William in ogni gadget ufficiale dell’evento. La traccia in oro riservata allo sposo non basta a sminuire il ruolo di quella “C” che troneggia proprio sotto la corona. Per molto meno, in altri tempi, avrebbero diligentemente scricchiolato sugli arcigni cardini le reali porte della Torre di Londra. Ma non basteranno delle altezzose stoviglie, per quanto pregiate, a seminare la discordia sulla tavola del banchetto reale. Il mio regno per un centrotavola? Andiamo!
A proposito di centrotavola, pare sia prescritto che il ninnolo civettuolo debba essere il regalo delle cognate, invitate che hanno un ruolo delicatissimo non solo nei caserecci sponsali latini, ma anche nei vertiginosi wedding days anglosassoni. Come dimostra Pippa.
Pippa Filippa, la sorella di Kate Catherine, è anche lei commoner, bisnipote di minatori che sudarono e annerirono nelle miniere dei Bowes-Lyon, come si chiamava la bisnonna di William prima di sposare Giorgio VI. Quando si dice le coincidenze.
La cognata, memore delle rustiche origini, il suo centrotavola non l’ha voluto far mancare a Westminster. Incedendo con decisione sui suoi tacchi a spillo in bianco concorrenziale e reggendo lo strascico di sua sorella, firmava la sigla di chiusura dell’avanguardia del corteo con le sue movenze posteriori.
In pochi fotogrammi è balenato nel mondo il guizzo morbido delle sue fattezze di moderna Venere Callipigia. Natiche, insomma, buttate lì, come la mela di Eris sul tavolo imbandito per le nozze di Peleo e Teti.
Eris e la fascia di Miss Olimpo
Eris, “Discordia”, detta anche “Contesa”, nella mitologia greca presiedeva la litigiosità nell’arco ispido che va dalla scazzottata stradale fino alla guerra globale. I mitografi la descrivono come una donna dalla velenosa chioma di serpi che, spietata e sanguinaria, godeva nell’animare conflitti e dissidi. La rabbia furente e la coazione alla violenza crudele erano le sue specialità. A volte non ricorreva neanche a pretesti: bastava litigare, far litigare e bearsi.
La dea era figlia, sorella e moglie di Ares, il dio della guerra. È da crederci che avesse la vocazione a seminare odio: contemporaneamente tormentata dai conflitti col papà, dai bisticci col fratello e dalle liti coniugali, si era guastata il carattere. Al tempo in cui le davano retta, pur non invitandola ai ricevimenti, pare abbia fomentato anche una rissa per un celebre mancato diritto di precedenza a un incrocio tra Edipo girovago e Laio re, padre e figlio inconsapevoli di esserlo. Dei guai che seguirono ancora si racconta in tutti i teatri classici e appassionatamente si discute sui lettini degli psicanalisti.
Eris, dicevamo, fu l’istigatrice dell’alterco mitico durante le nozze tra Peleo e Teti. Mortale lui, ninfa dei mari lei: un’unione impreziosita da una democratica differenza di classe ben prima del clamore di William e Kate e di qualsiasi Cenerentola. Per celebrare il fausto evento Zeus, come si conveniva nell’Olimpo “bene”, invitò tutte le personalità di riguardo a uno sfarzoso ricevimento. Il parterre dei VIP riuniti a banchetto fioriva di ospiti come Era, Efesto, Afrodite, Atena, Apollo, Dioniso e ogni altra celebrità del pantheon della Grecia antica, vale a dire dello star system del tempo.
Igino, nelle Fabulae, ci informa che Peleo e Teti trascurarono prudentemente di far recapitare anche solo la partecipazione di nozze a Eris. Come biasimarli? Astiosa sino alla cima dei serpenti, di certo non sarebbe stata un buon auspicio per la loro felicità coniugale. Ebbene, la dea anguicrinita* (per questi termini contrassegnati da asterisco si veda il breve glossario in fondo al volume), con tanto di permanente alle bisce, si presentò lo stesso ai cancelli della sala ricevimenti e, bloccata dalla security olimpica all’ingresso, trovò il modo di scagliare sul tavolo del convito nuziale, proprio a tiro della mano di Zeus, un prezioso quanto subdolo dono: una mela d’oro, il proverbiale “pomo della discordia”.
Sull’asperrimo omaggio si leggeva, incisa, l’iscrizione “Tè kallíste”, cioè “Alla più bella”, una dedica pericolosa perché istituiva un primato ambìto da tutte le divine e vanitose commensali. Pericolosa per il giudice, s’intende, oberato dall’onere di un’elezione evidentemente discrezionale e che non contemplava premi di consolazione. I bambini che restano in noi hanno già riconosciuto il mitologema* del mancato invito e della connessa vendetta che reggono la favola La bella addormentata nel bosco con l’inspiegabile narcosi e il bacio del risveglio.
Le concorrenti più litigiose e determinate a conquistare la fascia di Miss Olimpo erano le molto charmantes Era, Atena e Afrodite. Chiunque avrebbe perso il sonno per eleggere la più radiosa tra queste bellezze: come sancire l’avvenenza suprema? E come, inevitabilmente, ammettere il fascino minore delle altre? Certo, con l’infame lancio della mela d’oro Eris non aveva designato come giudice un centauro opinionista qualunque o una ninfa aspirante soubrette, bensì Zeus, il padre degli dèi, il dominatore del cielo, del tuono e dei concorsi, oltre che infaticabile tombeur de femmes.
Stiamo parlando dell’editore dell’Olimpo in persona, nulla avrebbe potuto far vacillare il suo piglio deciso e la sua insindacabile volontà. Infatti, preso il pomo tra le mani, si levò dallo scranno e, tormentando la folta barba, solennemente emanò la sua sentenza: “Passo”.
Per togliersi dall’impiccio, e anche per scansare le ritorsioni della gelosissima moglie Era nel caso, assai probabile, avesse preferito le grazie delle avversarie, l’onnipotente Zeus decise di delegare. E, per non fare torto ai colleghi che gozzovigliavano a tavola, addossò il gravame del verdetto a un mortale. Non uno a caso, ma un predestinato.
Per comandare c’è sempre tempo
Zeus ordinò a Ermes di scortare le contendenti al cospetto di Paride, un pastore troiano, in modo che si potessero sottoporre alle sue valutazioni estetiche. Oggi sappiamo che Paride, in realtà, era il figlio minore di Priamo, re di Troia, ma, allora, non era ancora avvenuta l’agnizione* che l’avrebbe rivelato un principe al pari di William.
Paride pascolava le pecore perché durante la gravidanza di sua madre un menagramo, uno tra i tanti tiresia indispensabili ai plot dei miti, aveva previsto un mare di guai scatenati dall’ennesimo figlio. Priamo era prolifico, di figli se ne aspettava una caterva e, affidandosi a quel dubbio spirito paterno ricorrente nella mitografia come nella favolistica, consegnò a un pastore il fantolino per liberarsene. Il principino, però, sopravvisse grazie al buon cuore di alcuni mandriani che lo chiamarono Alessandro, cioè “colui che protegge”, e lo avviarono a una rassicurante carriera di allevatore specializzato, pare, nel contrastare gli abigeati. Mai fidarsi di terzi, come si accorgerà la spietata regina di Biancaneve, afflitta pure lei da problemi di mele e mandatari inetti.
Al momento della nomina come giurato unico dell’esclusivo concorso, Paride conduceva ancora l’umile vita da rustico Alessandro tra caciotte e filati di lana. Mentre le sue pecore brucavano sul monte Ida, apparvero tre dee nude come mamma, o chi per lei, nelle varie teogonie, le aveva fatte. Gli mancò il fiato e, assorto in una sconcertata contemplazione, realizzò la complessità della scelta appena gli spiegarono il regolamento. Le concorrenti, forse per eludere ulteriori rimbalzi ed esitazioni, presero subito a mercanteggiare per la vittoria. E fu il primo voto di scambio che memoria d’uomo, anzi di semidio, riporti.
La maestosa Era, regina dell’Olimpo, per ottenere un risultato favorevole offriva ricchezze infinite e poteri smisurati al punto da rendere l’elettore padrone del mondo intero. Pallade Atena prometteva il dono della sapienza e dichiarava che nei primi cento giorni del mandato, in caso di vittoria, avrebbe fatto di Paride il più valoroso tra tutti i guerrieri e il più abile tra tutti gli artisti. La seducente Afrodite, dal canto suo, assicurava che, nel caso il responso le avesse arriso, gli avrebbe regalato l’amore della più bella tra tutte le donne mortali: Elena, moglie del re di Sparta Menelao.
Menelao figurava nell’agenda di Eris tra i migliori e più rissosi confidenti, come confermeranno in seguito innumerevoli intercettazioni.
Paride ascoltò con attenzione i comizi, valutò attentamente grazie muliebri e programmi e, dopo una breve riflessione che potremmo rubricare come silenzio elettorale, votò. Assegnò la mela d’oro alla candidata che garantiva un così lussuoso appagamento delle sue smanie erotiche.
Monte Ida, collegio uninominale. Elettori: 1. Votanti: 1. Astenuti: 0. Ottiene la maggioranza assoluta: Afrodite.
La preferenza espressa per la dea dell’amore fa tornare in mente una stagionata sentenza che riassume una piccola filosofia da boudoir evidentemente ancora ignota al principe pastore. “Cummanna’ è meglio ca’ fottere”: la locuzione contiene un lemma un poco greve, addolcito solo dall’intonazione che vuol essere vernacolare con quel verbo tronco del tutto meridionale, per la precisione napoletano.
L’adagio è notissimo e il suo senso molto spesso condiviso, non sempre, ma molto spesso. Il modo di dire esprime una consapevolezza freudiana ante litteram circa la voluttà del potere che riassumerebbe sublimazioni in campo sociale delle più intime pulsioni o frustrazioni delle sfere sessuali e, più poveramente, genitali.
I maligni ritengono, e ritenevano anche all’epoca dorata di Paride, che la tesi per cui vi è maggior piacere nell’imperio che nella fornicazione discenderebbe da un’altra constatazione, fatale, che arriva a una certa età, quando si registra una, diciamo così, diminuzione della propensione e resistenza alle corvée d’amore, d’amore fisico. In verità non è una “certa età”, è un’età certa, ahimè! Generalmente è l’età in cui, quelli a cui tocca, fanno carriera e possono comandare. Come si potrebbe dire, si lascia il talamo e si scende in campo. E allora arriva questa specie di premio di consolazione che la saggezza popolare sancisce con l’adagio in questione.
Non erano davvero queste le condizioni anagrafiche di Paride quando, giovanissimo, ebbe l’occasione di emanciparsi da capre e armenti per intraprendere, con garantito successo, la carriera politica, militare e artistica. Gli sarebbe bastato un voto per primeggiare globalmente da enfant prodige, parola di dea. Ma niente, non ci fu verso di dissuaderlo dal ribaltare l’aforisma campano e scegliere quell’altra cosa lì che non ripeto, tanto hanno capito tutti. In fondo aveva ragione: quale gusto c’era a diventare padrone del mondo, poi? Perché non accontentarsi dell’esiguo confine del proprio villaggio o, meno ancora, della propria casa? Canticchiò nel suo dialetto frigio quell’inno che, in latino, diventerà coro della goliardia: Gaudeamus igitur juvenes dum sumus. E, forse, sentenziò in conclusione: per comandare c’è sempre tempo.
Ancora si sente balbettare la vecchia nenia rapsodica: “Non son padrone nemmeno a casa mia, i pantaloni li porto io ma chi comanda è mia moglie”. In verità, Paride i pantaloni li dimenticava volentieri un po’ dovunque: pagliai, tuguri e camere da letto. Figuriamoci, poi, se la camera da letto è quella di un re e se questo re è un tiranno che deve render conto a un’intera famiglia di rapaci conquistatori e mercanti. Questi sì che vogliono essere padroni anche a casa d’altri, soprattutto se edificata e ostinatamente riedificata dieci volte nello stesso posto, laddove, cioè, si controlla il traffico. Almeno, così Menelao aveva saputo, e, poi, confidato a suo fratello Agamennone, intercettando i racconti che un certo Ulisse aveva inteso dai naviganti del mare Oceano che narravano nelle osterie degli angiporti di una città chiamata Troia. Era costui un re minore che bazzicava le lontane isole Ionie, esperto dei vizi umani e del valore, come, più tardi, sarà riconosciuto da un altro curiosone non da poco.
Odisseo, tale era il nome greco di Ulisse, restò a lungo indeciso tra il “cummanna’” e il “fottere” e questo provocò un’odissea di viaggi e avventure e, per secoli, l’aggravio dolcissimo e indimenticabile dei programmi scolastici. Paride no, Paride scelse: incise sul tufo delle immani mura di Ilio “Paride ama Elena” e perse molti amici nel mar Egeo. E rinunciò alle pretese regali.
Quanto sarebbe utile e provvidenziale se pure taluni nostri contemporanei preferissero Afrodite al potere. Anche arrivati a una certa età, quella in cui, tradizionalmente, ci si consola come suggerisce la saggezza partenopea. Ce ne sono di testardi restii alla mutualità del desiderio che continuano a preferire i doni di Era e le promesse di Atena. Cocciuti, vezzeggiano, caparbi, il loro ego ipertrofico a cui gioverebbe un poco di sesso scapigliato invece delle tante ambasce e ansie della politica.
È anche vero che oggi la scienza si incarica di fornire supporti capaci di scardinare l’imbarazzo della scelta tra la voluttà dei sensi e le lascivie dell’imperio. Ma, attenzione, chi scende in campo per più agevolmente salire sul talamo, finisce per trascurare il bastone del comando, distratto nella gestione della cosa pubblica da preoccupazioni, per così dire, pubiche. E, questi, si attira le critiche sin dal tempo di P...