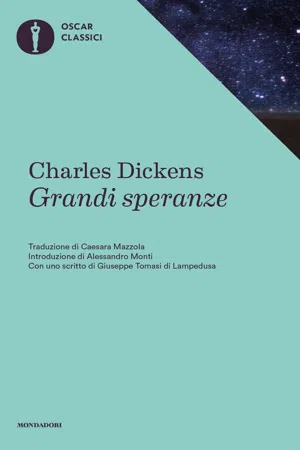La scena iniziale del romanzo si svolge in un cimitero fumigante di nebbia e isolato nel cuore di una landa inospitale: The Marshes (Le Paludi) formate dall’estuario del Tamigi.
Pip, il giovane protagonista di Great Expectations, è assorto di fronte alla tomba che racchiude, insieme, le spoglie mortali della famiglia in cui nacque: padre, madre e cinque fratellini.
Figurina fragile e patetica nella solitudine di un paesaggio che sembra essere tratto di peso da un romanzo gotico o da un racconto di fantasmi,1 Pip è un orfanello indifeso come Oliver Twist, una creatura ingenua e tiranneggiata al pari di David Copperfield. Ritorna nella presentazione del ragazzo quella forte tensione emotiva, ricca di risvolti autobiografici, con cui Dickens tratta il tema della solitudine infantile, resa più dolorosa dalla vicinanza a un mondo di adulti indifferenti, o addirittura crudeli.
È tuttavia lecito leggere la situazione in maniera meno negativa. Nel muto colloquio che Pip ha con la tomba dei suoi cari, un lettore colto d’epoca poteva forse cogliere un richiamo implicito a una poesia di Wordsworth, intitolata Noi siamo sette, nella quale una ragazzina di campagna spiega al poeta come in una famiglia non vi sia differenza tra i morti e i vivi, tra chi è rimasto e chi si è allontanato: le persone continuano a essere presenti nella memoria che gli altri hanno di loro.2
All’isolamento apparente di Pip si contrappone, quindi, una dimensione familiare implicita, analoga a quella enunciata da Wordsworth, e tuttavia più complessa. I personaggi del romanzo sono legati da vincoli di sangue a loro stessi ormai ignoti, o ripudiati, o che non possono essere riconosciuti come legittimi dalla società.
Mentre la poetica romantica di Wordsworth tende a unire con spontaneità esistenze che la morte o la vita quotidiana dividono, nella narrativa di Dickens le persone si ricongiungono dopo eventi complessi e spesso drammatici, durante i quali sono rivelate identità sino a quel momento celate o misteriose e viene restaurato un ordine legale, almeno nella forma, laddove in precedenza regnavano il sotterfugio e il mascheramento.
Il discorso sulla famiglia svolto da Dickens in questo romanzo ha come punti impliciti di riferimento due luoghi di crisi come il carcere e l’ospedale, in particolare quello psichiatrico. Appare ovvio che non si possa parlare di edifici nel senso concreto della parola (in parte ciò è possibile nel caso della prigione, in quanto il lettore è introdotto a Newgate), ma di stati patologici, sia della mente sia del modo di comportarsi, e delle cure, cliniche o punitive, da essi richieste.
Non è forzato affermare che Great Expectations rielabora in modo profondo un tema già affrontato nel precedente Oliver Twist (1838): quello dello scontro tra l’individuo rimasto isolato (un ragazzo senza famiglia, in genere) e le istituzioni sociali (gli Ospizi di mendicità e le Nuove leggi per il controllo dei poveri).3 Manca in Great Expectations, rispetto alla visione reintegrativa propugnata dal primo Dickens, qualsiasi prospettiva consolatoria affidata alla dimensione privata; a differenza di quanto avviene in Oliver Twist, il fatto di poter riacquistare la propria identità grazie al ricongiungimento con la famiglia e con il ceto sociale originari non sottrae la persona alla tutela della sfera repressiva.
Bisogna tuttavia dire che, anche nel caso di una soluzione a lieto fine, il soggetto smarrito ritorna a essere se stesso solo passando da una situazione di dipendenza a un’altra: dal ricovero pubblico a quella che Philippe Ariès definisce la famiglia nucleare,4 in cui vivono insieme i genitori e i figli non ancora autonomi, all’ombra di un legame che è determinato dall’intreccio assai complesso tra affetto e necessità economica.
Nell’Inghilterra ottocentesca, il nucleo familiare si presenta come una struttura oltremodo compatta: un vincolo di appartenenza che neppure la morte può sciogliere. Prevale infatti in esso un’idea di legalità talmente forte da considerare come colpa l’inserimento di una persona in un nucleo che non è il suo per diritto di nascita, anche in presenza di una stretta consanguineità. Si deve interpretare in tal senso la vita difficile, da un punto di vista psicologico, avuta da Pip nel periodo vissuto in veste di figlio adottivo presso la sorella; il ragazzo rimane, sempre e comunque, un frutto per così dire collaterale.
In Great Expectations il concetto di famiglia assume un carattere che è decisamente claustrofobico, come è testimoniato da uno dei simboli centrali del romanzo: una stanza chiusa alla luce del giorno e al calore del sole. È l’idea stessa di legalità borghese che è diventata più rigida, ma anche più complessa. Se in Oliver Twist la distinzione tra bene e male è ancora vista nei termini semplificati, e pressoché manichei, di onestà contrapposta a delinquenza (il discorso di critica riguarda piuttosto il sistema sociale, che genera mostri come Fagin o il suo compare Sikes), nella vicenda di Pip il fenomeno costituito dall’infrazione a una norma data è entrato a far parte della vita quotidiana di una famiglia qualunque e qualsiasi.
L’ossessione per chi è (o appare) diverso si presenta dunque con un duplice aspetto di malattia. Nel primo caso si ha una patologia dell’esclusione, ovvero il rifiuto di tutto ciò che non sia conforme a un rituale di riconoscimento, specifico e particolare per ogni determinato nucleo familiare. Nel secondo caso prevale l’intenzione di riunire in luoghi appositi, e a loro soli riservati, tutti quei soggetti estranei o irregolari nei confronti del microcosmo domestico.
Non si tratta quindi, in Great Expectations, di recuperare delle persone a condizioni di vita normali; l’autore ha indossato i panni non più del taumaturgo, ma di chi pronuncia delle diagnosi e classifica in base a esse. Nonostante le apparenze, Great Expectations è romanzo intriso di un forte spirito burocratico e di un poco tollerante atteggiamento censorio; l’analisi sembra compiersi in vista di un ricovero, mentre l’indagine pare essere lo strumento scelto per definire la verità su una persona.
Se i colpi di scena all’interno del romanzo sono quelli della narrativa poliziesca tradizionale, con le false identità e gli inseguimenti, lo spirito generale di colpevolezza (o malignancy) che pervade le pagine di Great Expectations riconduce il motivo dinamico dell’enigma a un dissidio dell’essere con se stesso, a una lacerazione di vita quotidiana tra i desideri e le possibilità.
Nella parte iniziale della vicenda il tema dell’incomprensione tende a essere risolto con tono di commedia, in quanto i fatti sono visti attraverso gli occhi di un fanciullo, ignaro del mondo. Traspare tuttavia un senso assai forte d’isolamento e di estraneità rispetto al mondo circostante: è come se le scelte del soggetto fossero condizionate dall’esterno, in un’atmosfera soffocante e soffocata che è quella del microcosmo chiuso in se stesso e nel rifiuto degli altri.
Il carcere da cui evade Magwitch è un primo simbolo, ancora relativamente semplice, di questa situazione. Esso permette, grazie ai suoi caratteri disumani, di cogliere il rapporto tra la violenza esplicita che si consuma in certe istituzioni e quella, più sottile, di cui è molte volte responsabile l’ambito familiare.
L’apparizione in scena del forzato evaso introduce nel romanzo il discorso della paura (Pip ruba in casa per aiutare Magwitch, e vive nel terrore che il suo furto venga scoperto), che è l’altro aspetto della diagnosi: l’ansia e lo sgomento provati dal paziente che attende di sapere una verità per lui crudele.
D’altra parte Magwitch introduce nel destino di Pip la presenza di una figura paterna attiva, tale da correggere in qualche modo la condizione di quasi orfano del ragazzo. Il galeotto diviene così il padre putativo di Pip, il protettore-ombra. Ripreso e deportato in Australia, Magwitch accumula una fortuna come allevatore di pecore;5 le sterline guadagnate vengono utilizzate per fare di Pip un gentiluomo, senza che al giovane sia rivelata la provenienza del denaro elargitogli. L’ex forzato ritorna infine in Inghilterra, mosso dal desiderio di rivedere il giovane da lui protetto. Con tale atto segna però la sua condanna a morte: le persone deportate in Australia non potevano rimettere piede in patria.6
Sono evidenti i legami tematici generali di Great Expectations con I miserabili (1862) di Victor Hugo; in entrambi i casi l’identità borghese può essere solo assunta come travestimento di superficie, forma mimetica di valori ormai in crisi. Per Dickens, tuttavia, l’enigma costituito dalla doppia vita condotta dal fuggiasco (mescolatosi alla borghesia rispettabile) diventa secondario rispetto all’importanza che ha ne I miserabili. L’autore è soprattutto interessato alla mancata crescita, morale e intellettiva, di Pip, che nel suo tragico ma banale fallimento anticipa un romanzo di atmosfera già crepuscolare come L’educazione sentimentale (1869) di Gustave Flaubert.
Nel tono dimesso con cui è descritta la carriera londinese di Pip, Dickens nega ogni convinzione di possibile mobilità sociale (riservata, comunque, a individui di buona nascita, anche se decaduti), espressa in precedenza da altri romanzi vittoriani, quali Jane Eyre (1847) di Charlotte Brontë e il già menzionato David Copperfield (1849-50). Allo spirito d’iniziativa si sostituisce, in Great Expectations, lo sfruttamento passivo di una rendita ottenuta con il denaro altrui; l’immagine del consumo vale così come simbolo centrale di disadattamento alla vita pratica e in essa si riflette l’opacità, morale e vitalistica, di un’ideologia provvidenziale giunta ormai allo stremo.
Abbiamo visto, con il richiamo a Wordsworth, come nella tradizione culturale inglese prevalga una fenomenologia del domestico e del familiare, che assorbe in sé ogni elemento eventuale di realtà turbata. La vita incolore e le prospettive mancate di Pip (a cui corrispondono in modo più esplicito, nella caratterizzazione dei personaggi, i vari travestimenti d’identità di cui il romanzo è pieno zeppo) non si rispecchiano nel tumulto di sconvolgimenti rivoluzionari, come avviene invece ne I miserabili e in Flaubert. Non è possibile scuotere o sovvertire il mondo borghese vittoriano nei suoi rapporti sociali; bisogna agire per vie oblique, sul sistema di segni, biologici e culturali, che regolano le relazioni di similarità e di contiguità tra gli individui.
In Great Expectations i legami di sangue o di parentela costituiscono elemento esplicativo, sia perché comunicano con chiarezza informazioni che altrimenti rimarrebbero sepolte, sia perché spostano nel tempo il problema delle identità, così da coinvolgere nella struttura sistematica non solo il momento della nascita, ma quello ben più importante (per le ragioni che vedremo) della discendenza.
Le complicazioni in apparenza gratuite della trama (dove tutto alla fine deve coincidere) si rivelano strumento prezioso di verifica; grazie al loro svolgersi simmetrico è possibile esprimere giudizi sorprendenti di affinità, recuperare nessi smarriti di filiazione.
In questo romanzo di Dickens il percorso della verità coincide senza ombra di dubbio con le rivelazioni del sangue, tuttavia il gioco complesso delle agnizioni comporta uno spostamento progressivo di significati. Le famiglie (o quanto di esse rimane) che qui si ricompongono davanti agli occhi stupefatti del lettore obbediscono a leggi ben diverse da quelle dell’innocenza giovanile o della semplice pietas cristiana. La sopravvivenza dell’unità familiare non è più affidata alla memoria delle persone che ne fanno parte; la sua coesione può essere ricostituita solo dopo un intervento esterno, dopo un lavorio travagliato di congetture basate sulla rivelazione implicita suggerita dall’indizio, dalla lettura di segnali sparsi che per trasformarsi in segni devono essere esaminati dentro la rete intricata di relazioni il cui dipanarsi plasma l’identità reale dell’essere.
La forma narrativa ridefinisce ciò che è noto valendosi dell’ignoto; da un lato la coscienza borghese si apre al dubbio e alla verifica spesso priva di risposta significativa, dall’altro nasce e si sviluppa il positivismo tutto di un pezzo di una detection (o spirito d’indagine) che vuole cancellare a ogni costo il mistero dalla vita quotidiana.
Se Dickens chiarisce simmetrie che prima apparivano disgiunte o frammentate, il materiale umano di cui si serve è spesso refrattario a qualsiasi esigenza d’ordine. Ciò giustifica la dimensione patologica, l’irrompere di una morfologia del diverso (di quella differenza che è soprattutto di natura psichica), e dei luoghi clinici a essa collegati.
Il discorso verte quindi sulla malattia, e intorno ai probabili focolai d’infezione. L’incontro tra Pip e Magwitch si compie in una palude malsana e caliginosa, che sembra essere pervasa da una doppia sporcizia, biologica (lì tutto si decompone) e morale (l’evaso obbliga il ragazzo con la violenza, sia pure verbale, a procurargli del cibo e una lima).
L’atmosfera di contagio che è intrinseca alla situazione può essere commentata alla luce di prospettive diverse. Vi si può vedere un simbolo di perturbazione malsana, e in questo caso il riferimento d’obbligo rimanda al critico, e moralista, John Ruskin che in epoca vittoriana denuncia come nella narrativa operi una forza nefasta e diabolica, da lui definita Teologia della decomposizione (Divinity of Decomposition).
In tale ottica, l’acquitrino di Great Expectations dovrebbe essere letto come un luogo di corruzione attiva e virulenta, nel quale si nega ogni legge morale. Vi agiscono «il vigore rigenerativo del letame, e le oscurità necessarie della Provvidenza fimetica, in cui appare come per l’errore dell’uno sia responsabile l’altro, come l’infezione non conosca legge, la digestione volontà e la profittevol...