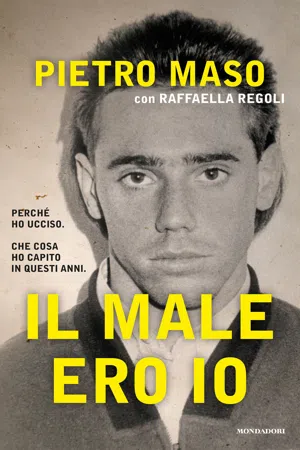![]()
“Credi al male con la stessa rapidità con cui credi al bene.”
JEAN COCTEAU
17 aprile 1991
Il male, appunto. L’ho toccato da vicino, il male.
Il male ero io.
Sono in piedi accanto ai loro corpi. Morti. Sono in piedi ma non ho percezione di me. Una linfa gelata mi è entrata dentro, nelle vene, nelle ossa, nel cervello. L’immagine di me torna indietro fredda, vuota, estranea. Rimango sospeso in una calma piena di tutto e assente di realtà. Vado in bagno. Devo lavarmi. Apro a manetta l’acqua calda, tengo la testa bassa. Fisso le macchie sul dorso delle mani. È sangue.
È il sangue di mio padre. È il sangue di mia madre.
Ci è schizzato sopra, sulle dita. Ma io lo vedo allargarsi sulla pelle, dappertutto. Schiaccio sul dosatore del sapone. Schiaccio, ne voglio tanto. Devo lavarmi bene. Lavo e lavo e lavo ancora. Non so quanto dura: attimi, minuti, mesi, anni. Fuori non c’è niente. Non sento le voci dei miei compagni. Non sento l’acqua che precipita. Non smette di venire giù. Corre più rapida del mio respiro.
Sono in aperta campagna: odore di foglie bagnate, ticchettio di pioggia, vento che pettina il campo. Vastità. E in questa vastità il mio cuore si perde.
Alzo gli occhi, punto lo specchio. Mi vedo. Mi vedo. È la mia faccia. E non è la mia faccia. Sono io. E non sono io.
Giorgio mi spunta alle spalle. A bruciapelo gli chiedo: “Guardami, guardami bene: sono diverso?”.
Giorgio non capisce: “Che...? In che senso diverso? Sei tu. Chi cazzo vuoi essere”.
“Mi vedo cambiato... Non so... Sembro più vecchio.”
Il male. Aveva accelerato improvvisamente la mia vita. Mi cerco nello specchio ma non mi trovo. Il mio corpo è di un altro.
Quante volte ho dovuto richiamare la mia coscienza alla realtà. Mi sentivo uno spettatore il cui castigo è guardare il più atroce dei delitti e non provare nulla.
Assenza. Quella notte aveva operato sul mio cervello all’opposto della “cura Ludovico”: aveva cancellato qualsiasi emozione.
Eppure in ogni momento della mia vita penso a quello che ho fatto. E in ogni momento, con uno sforzo carico di dolore, vado a caccia di quei frammenti e guardo in faccia la realtà, senza alibi.
Ci sono voluti più di vent’anni di carcere e quasi altrettanti di preghiera. È difficile ritrovare se stessi, ricomporre quello che è accaduto, quando hai scaricato su un altro te la responsabilità di tutte le tue nefandezze.
Avevo cresciuto, allevato, nutrito Maso, l’altro me, privo del peso della coscienza.
Come Maso, sono assenza, non ho odore, colore. Non ho lacrime. Non ho pianto per tanto tempo.
È accaduto quando ho rivisto per la prima volta Nadia e Laura, le mie sorelle. Era passato un anno dal delitto.
Il loro perdono mi ha liberato da me stesso. Come se qualcuno mi fosse entrato dentro e mi avesse rovesciato.
Ora volto le spalle allo specchio, lascio il lavandino ai miei compagni. Mi guardo addosso: voglio capire se sono sporco di altro sangue. Non vedo nulla. I miei pantaloni, invece, sarebbero stati presi come prova, perché il sangue ci era schizzato sopra eccome.
Gli altri hanno indossato le tute. Le hanno messe sopra i loro vestiti. Sono blu, da meccanico, con la cerniera davanti. Le ha procurate Damiano che lavora come metalmeccanico in una ditta di San Bonifacio.
Io no. Io non l’ho voluta.
Giorgio e Paolo si sono coperti anche la faccia. Con maschere di Carnevale. Maschere da diavoli.
Non ho messo neppure quella. Avevo la mia faccia. Mi bastava.
Ah... il Carnevale. Lo abbiamo passato a fare scherzi macabri. Quanto mi sembra assurdo e folle oggi tutto questo.
Abbiamo scherzato con la morte. Forse, dentro di noi, sentivamo che ci sarebbe servita la sua complicità. Entriamo in un’agenzia di pompe funebri. Ci fingiamo addolorati. Raccontiamo al titolare che se n’è andato un nostro parente. Quando usciamo, con noi abbiamo una cassa. Sì, una cassa da morto: legno scuro, senza fronzoli. Abbiamo comprato la più economica.
Così io, Giorgio, Paolo e, a turno, altri ragazzi della compagnia, andiamo in giro per il paese con quella cazzo di bara che spunta dal baule della macchina. E a ogni casa ci fermiamo. E suoniamo al citofono. E quando ci aprono ripetiamo la filastrocca: “Siamo venuti a consegnare la cassa che avete ordinato...”.
Di solito il malcapitato, con una faccia da ebete, se ne sta sulla porta qualche minuto senza parlare. I più svegli ci rispondono: “Avete sbagliato indirizzo. Non abbiamo chiesto nessuna cassa...”.
Noi pronti ribattiamo: “Ma come... non è qui il morto?”. E giù a ridere.
Giochiamo con la morte. E quel gioco macabro ci diverte molto. Giochiamo e non sappiamo che la morte ci sta venendo incontro a passi rapidi.
La prima volta che ho pensato di uccidere i miei avevo quattordici anni. È notte, sono a casa, nel letto, non riesco a dormire. L’estate è già esplosa. Quando è estate a Montecchia di Crosara lo capisci subito perché il paese si svuota. Si fa ancora più silenzioso. La sera vago per le stradine di campagna con l’aria tiepida che accarezza la faccia. Ho una Vespa bianca, me l’ha comprata mio padre. Il 17 luglio del 1985. Il giorno del mio compleanno: quattordici anni. Non ho neppure dovuto desiderarla. Per i miei compagni è stato lo stesso.
A quell’età il paese ci stava stretto. Ci si spostava a Verona, a trenta chilometri più in giù. Si cominciava ad andare in discoteca al pomeriggio, e poi c’erano le ragazze. Anche per le mie sorelle era stato così: alla mia età avevano avuto in regalo il motorino, il Ciao della Piaggio. Loro lo avevano avuto, ora spettava a me.
Papà l’aveva pagata, allora, un milione e seicentocinquantamila lire. L’ho voluta bianca, di un bianco accecante. Papà è tornato indietro con la macchina. Io con la mia Vespa. Nuova di zecca. L’ho fatta modificare subito: da 50 di cilindrata è diventata 125. Ma questo lui non l’ha mai saputo.
Quella stessa sera mio padre si è infuriato perché è arrivato in paese, ha trovato la mia Vespa ma non ha trovato me. Io ero salito sulla moto di un mio amico ed eravamo andati a Verona. Quando rientro a casa mi sta aspettando. Con voce grossa mi fa: “Dove sei stato? Sei andato fuori dal paese?”.
Mento: “No, sono stato qui, in giro...”.
“Sì, c’era la tua Vespa, ma tu non c’eri: mi hai detto una bugia.” E lì comincia a urlare, bestemmia. Mi minaccia. Una sfuriata così non me l’aveva mai fatta. Questa mi sembra davvero una stupidaggine. È preoccupato dell’assicurazione, dei soldi. Comincio a sfidarlo. Gli rispondo. Lui perde la pazienza. Prova a darmi uno schiaffo. Faccio in tempo a tirarmi indietro. Lo schivo. “Ma vaffanculo” gli urlo contro e scappo via. Lui fa la mossa di corrermi dietro, ma si arrende.
Passo tutto il pomeriggio a trivellarmi il cervello. Sono incazzato nero con lui. Non posso ubbidire. Non posso promettergli che non lo farò più.
È allora che tra noi si rompe qualcosa. Una frattura che non ho più risanato. Mi sento grande. Mi sento più forte di lui.
Quella notte fa caldo a Montecchia. Le lenzuola mi si appiccicano addosso, il sonno non vuole consolarmi. E io penso: “Ma perché questo stronzo non muore?”.
Poi quel desiderio. Arriva come un’intuizione maligna: “E se lo uccido io...?”.
La verità è che stavo cambiando. Il debole Pietro aveva già dato la vita all’invincibile Maso. E Maso cresceva in fretta. Non solo si ribellava a suo padre, presto sarebbe sfuggito anche al mio controllo. Papà aveva posto un limite, Pietro lo avrebbe rispettato. Maso no, non poteva. Maso voleva di più.
Mio padre ha continuato a sgridarmi. Io ho continuato a fare come volevo. L’incantesimo era rotto.
Ucciderlo, liberarmi di lui. Quel pensiero sprofonda nel mio abisso. Ma una sera d’autunno, all’improvviso, riemerge col suo carico di morte. Sono passati cinque anni. Arriva per caso. Ma con quell’assoluta precisione con cui finisce in buca una palla da biliardo.
Siamo all’aperto, seduti davanti al bar, il bar John. Sono le dieci e mezzo di sera. Il freddo ci mangia le ossa. Decidiamo di scaldarci in macchina. Io mi accendo una sigaretta, Giorgio si appoggia con un braccio allo schienale del sedile. Mi guarda e se ne esce con quella domanda che doveva girargli da un po’ nella testa: “Pietro, come si potrebbe fare per avere più soldi... Per averne tanti e subito?”.
La domanda è semplice. Ingenua. Assurda. Terribile. A quel tempo lavoravamo. E poi giocavamo a biliardo. Eravamo diventati bravi. Scommettevamo un sacco. Il grano insomma non ci mancava. Anzi. Ma ne volevamo di più. Volevamo stordirci.
“Se vogliamo più soldi” gli rispondo io “abbiamo una sola possibilità: uccidere i miei.”
Non è un progetto. La butto lì, a caso, quasi a effetto. Voglio stupirlo. Ma quella chiave apre l’inferno.
Giorgio rimane in silenzio, guarda fuori, pesca la seconda domanda: “Come sarebbe uccidere i tuoi...?”.
“Sì... uccidiamo i miei e anche le mie sorelle, vendiamo i terreni, la casa, tutto. Ce ne andiamo. Ce ne andiamo via da questo paese di merda.”
Lui sorride. Complice. Assapora il sogno. Se lo gusta. Poi la sigaretta finisce. “È ora di muoverci, dài, si va a ballare. La discoteca ci aspetta...” E il discorso muore lì.
Ma a gennaio accade che Giorgio vuole una macchina nuova. I suoi si oppongono, e lui si fa prestare dalla banca, dietro garanzia del suo datore di lavoro, venticinque milioni di lire. Il finanziamento arriva a febbraio, ma quell’auto nuova non la comprerà mai. E noi intaschiamo la nostra maledizione. I soldi finiscono d’un colpo nelle nostre mani, mie e di Giorgio. E d’un colpo li bruciamo. Così quel progetto di morte ritorna con prepotenza.
Dobbiamo restituire i soldi. Dobbiamo uccidere i miei.
È tardo pomeriggio. La giornata di lavoro è finita. A schiaffeggiare l’aria si è levato un vento freddo che fa sbattere i vetri delle finestre. Il paese è scappato. Ci rintaniamo nel nostro bar. Il bar John.
La sala è vuota, siamo solo in tre. Io e Giorgio iniziamo a giocare a biliardo. Paolo se ne sta in un angolo.
Giorgio dice: “Ehi ragazzi, siamo nella merda. Devo restituire i soldi entro metà aprile”. Ci guardiamo. Nessuno risponde. Anche Paolo ha un piccolo debito da saldare. Alzo la faccia sopra la stecca già puntata per colpire la palla e spedirla in buca.
“Be’, se dobbiamo fare soldi in fretta” rispondo “l’unico sistema che abbiamo è uccidere i miei. Intaschiamo l’eredità, paghiamo i debiti e scappiamo via.”
Paolo esce dall’oscurità.
“Sì, ma come si fa...?”
“Io un’idea ce l’ho” rispondo senza esitare, a voce bassa.
Colpisco la palla. E la palla rotola sul tappeto. Entra in buca. Arriva gente. Vuole vederci giocare. Siamo bravi. E siamo l’unica attrazione di questo maledetto posto.
Lo abbiamo fatto per i soldi, così hanno scritto. È vero. Ma come per ogni verità, quello che si conosce è solo una parte. Io e Giorgio non avevamo bisogno di soldi. Ne avevamo sempre in tasca, tanto che gli altri due, Damiano e Paolo, ci avevano chiesto di entrare nel nostro giro. Chissà quali traffici immaginavano.
Anche il padrone del bar, Tony, aveva notato che eravamo sempre gonfi di moneta. E noi non facevamo nulla per nasconderlo. Anzi. Serviva a darci un tono.
Di sicuro erano in tanti a pensare che ci fossimo messi in un brutto giro, ma poi ogni pensiero veniva sconfessato dalla realtà. Noi ci comportavamo in maniera impeccabile. Da bravi ragazzi. Mai una lite. Mai droga. Sempre e solo soldi.
Ogni tanto Tony ci lanciava una battuta. Lo faceva quando per strafare pagavamo da bere a tutti. Allora ci veniva incontro con uno strano ghigno sul muso e stringendo la mano a pugno davanti alla nostra faccia, come ad afferrare qualcosa, con una vocina stridula ci diceva: “Eh eh... tanto prima o poi vengono a prendervi e vi portano via, al gabbio!”.
La verità è che stava bene anche a lui. Eravamo i suoi migliori clienti. Spendevamo in continuazione. Puntavamo biglietti da cento quando giocavamo a biliardo. Forse gli andava meno bene che sua moglie, qualche volta, venisse a sedersi sulle mie gambe. Io però non l’ho mai toccata.
I soldi li avevamo. Ma quei venticinque milioni, tutti insieme, in biglietti da cento... non li avevamo mai visti. Ci diedero alla testa. E il problema non fu più solo restituirli. Ci illudemmo che i soldi fossero l’unica speranza che avevamo per andarcene. Fuggire via, lontano.
Volevamo un’altra vita.
L’ultimo a saperlo fu Damiano, il più piccolo della compagnia. Assurdo trascinarlo nel nostro progetto di morte. A turno noi tre abbiamo accelerato, decelerato, indietreggiato. Ma nessuno mi ha mai fermato veramente. Nessuno mi ha mai detto: “Che cazzo vuoi fare? Uccidere i tuoi? Ma sei pazzo?”.
Giorgio, Paolo, Damiano: forse avevano voglia di essere come me. Ognuno di noi voleva dimostrare all’altro di essere all’altezza. Io ero il loro leader. E per il solo fatto che gli prospettassi la bella vita, dovette sembrare a tutti una gran cosa. L’America. Miami. Il sogno. La salvezza.
Nessuno aveva pensato alla gravità di quello che stavamo per fare. Nessuno. Men che meno io. Non conoscevamo la violenza. Quello che gli prospettavo era più forte di ogni scrupolo. Eravamo pronti a tutto pur di spezzare la maledizione a cui ci avevano condannato i nostri padri, e i padri dei nostri padri.
Montecchia di Crosara è terra da coltivare. Montecchia di Crosara è una provinciale, una piazza, una chiesa, un cinema parrocchiale, una sala giochi e un bar.
Per chi ci abita, una cambiale già firmata: sacrifi...