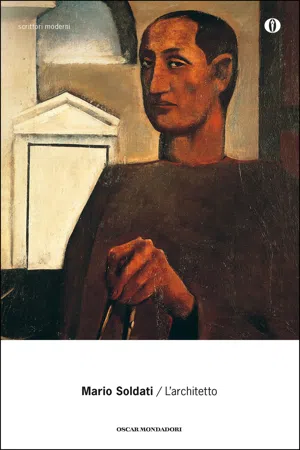Lizzie veniva verso di me correndo. La vidi a un tratto, dall’alto dello scaffolding ma così rimpicciolita per la distanza e così schiacciata dalla prospettiva che il suo vestitino verde vivo non disturbava né lo sfondo sfumato dello skyline di Chicago né l’intrico ortogonale e mondrianesco delle nere tubature. Per caso, per godere un istante il panorama del lago e la brezza della mattina primaverile, mi ero affacciato proprio allora al ridicolo, assurdo davanzale spesso 75 centimetri di una di quelle sciagurate mille finestre che mi ossessionavano col problema dell’incorporato doppio meccanismo di chiusura. Ma un istante bastò, indovinai subito nella disfrenata corsa di Lizzie il particolare entusiasmo che la possedeva tutte le volte che poteva recarmi una notizia sgradevole o addirittura inquietante: malgrado la sua straordinaria intelligenza e devozione, apparteneva anche lei alla categoria dei subalterni catastrofici!
Eppure, quando ancora trafelata arrivò in alto col traballante saliscendi dei muratori e di slancio saltò sul planking, tutto ciò che doveva dirmi era cosa da niente: passando dalla baracca degli uffici aveva trovato un messaggio da Chicago, del portiere del nostro albergo. C’era per me una telefonata urgente provenienza Roma:
«There is no reason at all you should worry» aggiunse subito Lizzie, non esiste nessuna ragione che ti debba preoccupare. Oh, certo! l’incosciente vizio dei subalterni catastrofici è complicato e contraddittorio: vogliono essere i primi anche a rassicurare!
Per fortuna non riuscivo a pensare notizie in grado di spaventarmi. Mia moglie e i miei figli vivevano a Milano, i miei amici più cari anch’essi a Milano o in diverse città del mondo, nessuno a Roma. Domandai di chi fosse la telefonata. Qualcuno che parlava solo italiano, il portiere non aveva capito il nome. Lizzie tuttavia si accorse che mi ero rabbuiato, e io capii che ciò la addolorava e allo stesso tempo la eccitava: sì, una nuova fettina di potere che acquistava su di me! Fui allora io a rassicurare lei e, questo, senza bisogno di mentire: sincerissimo, diamine. Mi ero rabbuiato? Ma senza motivi precisi… salvo, forse, un sospetto, una domanda sinistra che a poco a poco finii col rivolgermi quando già ero tornato alle mie finestre: che cosa mai, da Roma, poteva venirmi di buono?
Rimasi in cantiere l’intera giornata a discutere con i tecnici. Come spiegare le difficoltà che avevo incontrato? E come, senza l’aiuto di fotografie e schizzi ecc. che sarebbero chiari a soli specialisti, dare un’idea della copertura metallica che avevo preteso per non rovinare il mio progetto e, insieme, contentare i più stupidi, i più ostinati sapientoni della commissione di controllo, cioè proprio gli architetti di cui più si fidavano i pezzi grossi del trust? A loro volta, i sapientoni avevano consegnato la patata bollente a un gruppo di tecnici, e appunto con costoro avevo a che fare oggi. Dopo un litigioso lunch di lavoro, dimenticando my usual nap, la mia breve siesta a cui non rinunciavo mai, continuai la battaglia.
Nel progetto avevo previsto finestre all’antica: apertura manuale. La commissione, invece, voleva finestre immobili, aria condizionata a temperature variabili. Ma ci eravamo subito messi d’accordo, raggiungendo un compromesso: l’adozione di un meccanismo che permettesse l’uso alternativo di entrambe le chiusure. E dovevo, appunto oggi, scegliere insieme ai tecnici il migliore tra i vari modelli che avevamo fatto costruire di double gear, throw-in e throw-out, innesto e disinnesto dell’elettricità. Teoricamente, era manovra semplicissima: trac trac, dalla nostra buona vecchia cremonese, due aste verticali comandate mediante la rotazione di una normale maniglia, si passava all’energia elettrica che chiudeva oppure permetteva di aprire, tutte insieme, le finestre di un piano. E, teoricamente, i tempi delle due manovre avrebbero dovuto essere identici. Incredibile, abbiamo perso ore a cronometrare uno dopo l’altro tutti i modelli: ma i due tempi per passare dal manuale all’elettronico e viceversa non erano mai uguali, anzi, esisteva sempre una notevole differenza tra l’uno e l’altro. Inoltre, io propendevo per un modello che dava la possibilità, in qualunque momento, di aprire o di chiudere ogni finestra, ma i tecnici concordi si ostinavano a esigere un modello che presentava un inconveniente assurdo: ogni finestra poteva, sì, venire aperta a mano in qualunque momento, anche quando tutte erano chiuse elettricamente, ma nessuna poteva venire chiusa a mano, bisognava richiuderle tutte insieme!
Naturalmente, io non potevo cedere. Ma neanche loro hanno ceduto. E le cose, quel triste giorno, si fermarono lì. Ridicolo a dirsi: era la prima grossa noia che mi capitava da quando non avevo esitato a gettarmi con entusiasmo in un’impresa così meravigliosa come la IUH. Accanto a Lizzie, che con la sua piccola Capri verdechiara come il suo vestitino mi riportava all’albergo dove forse avrei saputo che cosa significava quella telefonata da Roma, ma chissà, forse si trattava di uno sbaglio cretino… accanto a Lizzie, una volta tanto me ne stavo quieto, senza lamentarmi, senza chiacchierare, fingendo di assopirmi. Pensavo alle finestre, a come mandare all’inferno tutti i tecnici e anche agli sbagli che potevo avere fatto trattando con qualcuno di loro meno intelligente degli altri, e al mio comportamento non proprio diplomatico, talvolta incapace di moderare uno spontaneo umorismo, e non abbastanza consapevole di uno sciocco complesso di superiorità. Seccato con me stesso, desideroso di riflettere e giustificarmi, nulla mi avrebbe irritato, in quel momento, come la solita, irrefrenabile chiacchiera della mia cara Lizzie e più ancora, forse, il suo accento newyorkese, quello che Henry James chiamava “drawling”. Continuai, perciò, a fingere di dormire, ma, senza volerlo, aprivo appena appena l’occhio destro – in direzione, cioè, del finestrino e non di Lizzie – e attraverso la fitta rete delle ciglia vedevo sfrecciare la strada che percorrevo sempre la stessa due volte al giorno, e mi tornavano a mente questi ultimi anni della mia vita già così lunga, e questa ultima avventura…
… qualche tempo fa, verso la metà degli anni Settanta, mi trovavo a Chicago. C’era il Congresso Mondiale di Architettura e finalmente potevo parteciparvi. Prima, nelle ricorrenze della stessa occasione, ero già stato a New York, San Francisco, Miami; ma impegni di lavoro mi avevano trattenuto in Europa ogni volta che il Congresso si teneva qui! Ora, questa era la città che verso la fine del secolo scorso divenne il terreno sperimentale della “Scuola di Chicago”, famosa in tutto il mondo per la storia dell’architettura moderna. Qui nel 1883 W.L. Baron Jenney costruì il primo grattacielo propriamente detto, lo Home Insurance Building. Qui Frank Lloyd Wright, pioniere solitario, il più grande architetto del nostro secolo, fece le sue prime prove, e più tardi costruì le sue Prairie Houses, fondò la sua Prairie School.
Infine, Chicago era la città degli States che conoscevo meglio di ogni altra, scelta d’obbligo per un laureato in architettura che, superato l’esame di stato in Italia, volesse perfezionarsi in America. Venni a Chicago nel ’29, e vi rimasi a lungo: presidente era Hoover, non ancora Roosevelt, non ancora il New Deal!
Ebbene, dopo la guerra, sono tornato molte volte in America e un po’ dappertutto negli States ma, per uno strano destino, senza mai venire a Chicago! Sino a quando colsi l’occasione del Congresso per rivedere questi luoghi così cari alla mia gioventù, e allora lo stesso destino superandosi in stranezza manovrò in modo che appunto a Chicago, prossimo ormai alla vecchiaia, ricevessi forse la migliore, la massima offerta di lavoro di tutta la mia vita.
Si trattava di progettare l’intera costruzione della IUH, la International University of the Humanities, che doveva sorgere, a poche miglia dalla città, sulla riva occidentale del Michigan.
Naturalmente, i grandi capitalisti del trust, i banchieri e gli industriali che finanziavano l’impresa erano partiti con un grande programma pubblicitario. E calcolando la necessità di presentare una faccia culturalmente prestigiosa avevano voluto quattro grossi nomi come sponsors, quattro garanzie di un’assoluta serietà: Saul Bellow e Norman Mailer, il poeta James Merrill e il critico George Steiner. Naturalmente, li avevo conosciuti: ma li avevo visti una sola volta, alla cerimonia for the laying of the corner stone, la posa della prima pietra, sul promontorio di Wilmette, tra le due baie.
Il mio progetto poteva definirsi la traduzione architettonica della parola che aveva ispirato tutti questi sopracciò della finanza e della cultura a battezzare, concordi sebbene in malafede perché ignari del concreto significato storico della parola stessa, a battezzare la nuova Università col crisma dell’Umanesimo. In uno straordinario trasporto di fervore, credendo io sul serio all’Umanesimo, il mio primo pensiero volò al genius loci: a F.L. Wright, un vero, spontaneo, irresistibile umanista. E l’espressione genius loci è doppiamente valida, in questo particolare caso perché Wright cominciò a operare qui, in tutti i casi perché secondo Wright l’architettura doveva essere antiformale, organica, figlia del genius loci e delle proprietà specifiche dell’ambiente: clima, paesaggio, terreno, vegetazione, materiali di costruzione.
Tuttavia, diversamente dal solito, il mio progetto era destinato a attraversare una strana peripezia. Raggiunto con quelli del trust un immediato accordo di massima circa le condizioni economiche del mio impegno, ebbi subito una quantità di idee su ciò che assolutamente non si doveva fare: nessuna su ciò che mi sarebbe piaciuto. Poi, nelle settimane successive, allungai a poco a poco la lista delle perentorie esclusioni annotandomele in un apposito taccuino, e intanto evitavo di riflettere un solo istante al grande problema del progetto in sé. Insomma, ci fu una pausa. E perché mai? Molto semplice. Dawson e Parker, i due principali incaricati dal trust, rinviavano di giorno in giorno la stesura del vero e proprio contratto, e a me non andava di incominciare a lavorare prima di averlo visto e firmato: temevo che mi portasse sfortuna. Follia. Scaramanzia.
Forse mi aveva irritato il comportamento di quei due. In attesa del contratto, il tempo cominciò a passare e anche se non era affatto stabilito che io dovessi dedicare giorno su giorno a occuparmi del progetto, a studiarlo, a prepararlo, Dawson e Parker seguitavano a parlarmene come se, sospettando la verità, volessero incitarmi al lavoro. Presto e per caso scoprii che, invece, erano ingenui e innocenti: ma proprio questa loro ingenuità e innocenza fu la causa della mia irritazione.
Ogni mattina, infatti, percorrevo 50 miglia con la mia Jaguar, andata e ritorno tra Chicago e Wilmette, dove assistevo alle necessarie fotografie, misurazioni, trivellazioni – ma puntualmente, nel pomeriggio, mi guardavo bene dal prendere in mano una matita, disegnare una pianta, schizzare un profilo, tracciare un frego qualsiasi. E ecco come feci la scoperta: ebbi una prova che non cercavo.
L’indomani del giorno in cui mi era stata fatta la straordinaria proposta di costruire la IUH, il direttore dell’albergo Drake dove ero sceso mi comunicò una novità, aveva ricevuto l’ordine di traslocarmi. Senz’altro mi accompagnò al settimo piano. Era una suite sontuosa, principesca: camera da letto, salotto, studio. E nello studio trovai, completa di accessori, questa perfetta, grandissima tavola da disegno che uso da quattro anni – ma che, in quel momento, ebbe il potere di mandarmi in bestia!
Il contratto dunque tardava per le solite complicazioni burocratiche e sindacali, dato che non ero a citizen of the US. Così mi avevano detto Dawson e Parker, e a me parevano soltanto delle scuse. Credevo che mentissero mentre erano sinceri, non nascondevano altri scopi, non indagavano su di me. Se un minimo sospetto li sfiorava, si sarebbero affrettati a informarsi dai camerieri dell’albergo su come passavo i miei pomeriggi, e avrebbero saputo che la grande tavola da disegno rimaneva immacolata.
Ripeto: la scoperta della franchezza di Dawson e Parker non mi persuase a contraccambiarla come certamente sarebbe stato mio dovere. Forse ci tenevo troppo a fare la IUH. La scaramanzia era più forte di tutto, e il cattivo umore mi passò d’incanto solo quando, arrivato un bel giorno il contratto regolare con le firme del trust, vi applicai la mia. Era il 17 novembre. No, non sono superstizioso, eppure dalla nascita alla laurea e a tutti i più importanti avvenimenti della mia vita, la data è sempre il diciassette!
La cerimonia della firma del contratto, come quella della posa della prima pietra, si svolse a Wilmette, all’interno di una grossa baracca prefabbricata, provvisoria sede amministrativa del cantiere e per il momento unico immobile che spiccava, verniciato di un lucidissimo verdevagone, in mezzo alla prima neve caduta sull’area del mio futuro capolavoro.
Fuori faceva molto freddo ma non nelle stanze della baracca, così ben scaldata che bisognava tenere aperte le finestre. Brindammo a bourbon, bicchieroni di neat, e ci sbrigammo. Era un sabato mattina. All’uscita, capii che, digiuno (refrattario al breakfast adesso come quarant’anni prima!), ero allegro, anzi un po’ brillo. Saltai sulla mia Jaguar, felice di essere solo. Non esisteva ancora Lizzie. E felice di guidare in velocità su quei lisci lunghi rettilinei verso Chicago. Per la prima volta, all’improvviso, mi ricordai che c’era, là, a aspettarmi, la mia splendida tavola da disegno. Avevo una voglia matta di disegnare. Ma che cosa?
Rallentai. Che cosa avrei disegnato? Come diavolo era la mia Università?
Mi fermai. Ripartii, ma per tornare indietro. Tornai alla baracca verdevagone. Non c’era più nessuno. Il cielo, un immenso soffitto grigio, unito, compatto. Il lago, una lastra di peltro. E il fumo bianco che usciva dal tubo di latta e saliva verticale nell’aria ferma e gelida mi diceva che Mic, il custode della baracca, tra poco si sarebbe seduto con gioia davanti al suo lunch. Era jugoslavo, giovane, simpaticissimo. Nelle mie visite quotidiane a Wilmette, avevamo fatto amicizia. Ah, perché non entravo? Sapevo che mi avrebbe invitato a mangiare con lui, e io ero affamato, affamato, il bourbon neat aveva scavato nel mio stomaco un buco da riempire subito.
I capelli biondi e riccioluti di Mic, il suo volto scavato e pallido, il suo sorriso malizioso e buono si sovrapponevano nel mio sguardo alla sottile, lieve, appena palpitante colonnina di fumo bianco e alla tentazione che provavo di mangiare insieme con lui. Credo di non avere mai sofferto una tentazione così terribile anche se in sé innocente: infatti ero tornato indietro a Wilmette perché sentivo che quel momento non si sarebbe ripetuto e che era destinato a qualcosa di più. Chissà, la fame, qualche volta, è meglio non soddisfarla, ispira.
Uscii dalla Jaguar e chiusi lo sportello cercando di non fare rumore. Forse un istinto angelico mi aveva guidato, mi ero fermato non proprio lontano dalla baracca ma abbastanza perché Mic non mi udisse. Altrimenti, se Mic veniva fuori, se Mic mi vedeva, tutto era perduto.
Me ne andai piano piano sulla prima neve, attento a non scivolare. Camminai per buoni venti minuti. Arrivai fino al ciglio del promontorio. La base del faro era un parallelepipedo, quattro alti gradini di labradorite. Qualcuno aveva spazzato accuratamente la neve. Ma sapevo che non c’erano custodi. Il faro scattava cronometrato da un prestabilito dispositivo elettronico, variabile secondo il variare delle stagioni e azionato dalla centrale di Winnetka, che in caso di nebbia poteva accenderlo anche di giorno, a qualunque ora. Salii sul primo gradino e continuando passai dall’altra parte dove la mole del faro era a picco sul lago e mi nascondeva all’acuta vista di Mic. Certo, se gli saltava in mente di fare due passi, avrebbe riconosciuto la Jaguar. Ma non credo sarebbe venuto a cercarmi così lontano. Mi guardai intorno. Non mi ero mai spinto fino qui, e mi resi conto che, invece, avrei dovuto venirci dal primo giorno.
Proprio la base del faro, grazie alla quota del suo naturale rilievo su tutte le modeste ondulazioni del terreno per un raggio di alcune miglia, era il solo punto dove si poteva fantasticare, sognare di vedere sorgere, un po’ come nel fenomeno detto fata morgana, un complesso architettonico di una serie di edifici in razionale armonia con la struttura del paesaggio.
I sapientoni, naturalmente, si erano adoperati affinché, prima cosa, io perlustrassi la zona con un elicottero.
«Grazie, no!» avevo detto subito. «Verrò con l’elicottero soltanto dopo avere visto come è l’Università che mi piace e dopo averla disegnata su una planimetria al diecimila! Forse che noi viviamo in aria? Viviamo sulla terra, molto tempo in macchina purtroppo, ma le idee giuste vengono solo quando sulla terra posiamo i piedi!»
I sapientoni allora scoppiarono in una concorde e corale risata adulatrice. Credevano che volessi fare dello spirito, poveri disgraziati!
Ma ecco: eccola la mia Università. L’ho vista quella mattina, dalla base del faro di Wilmette, in un improvviso lampo d’argento che illuminò il plumbeo Michigan e le due lunghissime, sottili ghirlande della risacca lacustre, silenziosa e bianca contro la roccia scura, scioltasi ormai la neve: cioè gli orli delle due lunghissime baie, una a nord l’altra a sud di questo faro che le separava e insieme le collegava come il rostro di un’aquila che, puntato al cielo, collega e separa le due nere ali distese.
E era così. Al centro, al posto del faro, ma su un’area cento volte maggiore, la facoltà di Architettura. Simile al Castello Estense di Ferrara, al Castello Sforzesco di Milano, al Castello di Sanvitale presso Fontanellato, Rinascimento norditaliano con i merli e le torri coperti da tetti di tegole embriciate, esattamente come le non lontane di qui Prairie Houses di Wright – e, subito sotto i tetti, una corona di superattici non più larghi di cinque metri, lunghe passeggiate panoramiche e munite di grandi cristalli (questi sì, scorrevoli, automatici, apribili) di modo che dal livello del suolo si vede sempre, attraverso i cristalli o senza i cristalli, la luce del cielo, insomma superat...