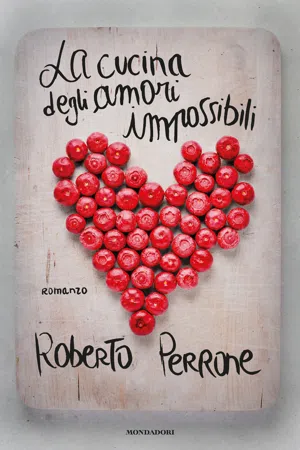![]()
![]()
Naturalmente, l’avvio della mia carriera di cuoco (nel ristorante del Grand’Uomo era vietato, pena pesanti sanzioni, utilizzare il termine “chef”) non è stato così agevole come le premesse avevano fatto sperare. I primi successi – con le mie “ragazze” – sono stati fuorvianti.
Abbiamo cominciato una specie di ménage à quatre. Io e Rossella, i ristoranti Da Iole e Maggiorasca. Due cuori e due cucine. E non solo (ahinoi). Non posso negare che ci sia stata una parte divertente in questo strano miscuglio di cose, fornelli, uomini e donne. Non posso non confermare che entrare nella vita del ristorante mi abbia intrigato, ma forse, se gli unici protagonisti fossimo stati io e lei, la storia avrebbe avuto una diversa sceneggiatura.
La prima volta che mi sono messo la giacca bianca da cuoco c’è stata una specie di cerimonia. È successo la sera dopo “la notte dei pansotti” tra me e Lorenza. Negli anni è stata raccontata così. Siamo rimasti a mangiare, a bere e a parlare fino quasi all’alba. Lei, la mia cocca, si è fatta raccontare tutto (non proprio tutto, naturalmente) quello che avevo fatto con Rossella nella nostra gita fuori porta, compresa la ricetta della catalana di granchio (anzi di King Crab), ma io le ho imposto il segreto. Nulla doveva uscire da quella cucina. Lorenza ha giurato (senza fare gli occhioni e quindi avevo qualche speranza che mantenesse la promessa). Poi siamo andati a dormire. E io ho dormito tanto. Nella mia vecchia camera da ragazzo sono sempre stato molto bene, finché è stato il mio domicilio. Era rimasto tutto come quando me n’ero andato, come se avessero messo i sigilli e non si potesse spostare nulla in attesa del dissequestro. Gli scaffali con i miei libri, anche quelli segno di ribellione nei confronti dei gusti paterni: filosofia, storia, cinema. Il vecchio mappamondo, consumato a furia di girarlo, con la mano e con l’immaginazione. Il poster di Doctor J mentre effettua un “gancio cielo” accanto a quello, meravigliosamente vintage, dei Nuovi Angeli, la cui presenza faceva impazzire le mie sorelle (di stretta osservanza pop-rockettara) e tutti i 45 giri della mia preziosa collezione anni ’70, con mangiadischi ancora perfettamente funzionante. Li avevo lasciati, quando avevo abbandonato la casa paterna, con un intento preciso: avere una scusa (recuperarli) per tornare, se ci fosse stata un’emergenza, se una delle mie sorelle mi avesse lanciato un sos, insomma, qualsiasi cosa. Avevo detto a Iole, partendo, di difenderli a ogni costo dalla possibile furia iconoclasta di mio padre.
E ora eccoli lì, tutti in fila, belli con le buste spolverate da mano pietosa. Mi sono addormentato con Sarà la nostalgia di Sandro Giacobbe, lo straordinario cantante di Gli occhi verdi di tua madre. Preferisco gli “occhi verdi” alla “nostalgia”, ma in quel momento, in cui si chiudeva un’epoca della mia vita e se ne apriva un’altra, un po’ di nostalgia mi sembrava più appropriata.
Giovanna aveva definito la mia camera “il reliquiario”. Mi ero chiesto, ritrovando tutto intatto e tirato a lucido, come mai mio padre avesse permesso la conservazione di quel mausoleo ma, dopo la lettura della lettera che mi aveva lasciato, molte cose mi erano sembrate più chiare. Anche per lui era un reliquiario. Me lo sono immaginato che entrava di nascosto, per timore che qualcuno scoprisse il suo lato debole, l’amore segreto per il figlio esule e ribelle. Nella mia mente si formava l’immagine di lui seduto sul letto, che abituava gli occhi al buio e poi percorreva il perimetro dei miei gusti di ragazzo, quasi inebriandosene, come un sub che prende fiato prima di una lunga discesa in apnea. Chissà: avrà mai fatto suonare uno dei miei dischi, nei giorni in cui era sicuro che nessuno fosse in casa?
Difficile. Lì, in quel luogo declinato al femminile, c’era sempre una donna che ti sbucava da dietro un angolo, che origliava. Le mie meravigliose sorelle, urca, erano le donne più curiose e pettegole che conoscevo. Mia madre no, era più riservata. O più attenta a non farsi individuare.
È stato quindi con una certa sorpresa che, nel sonno pieno e rotondo, ho avvertito come una presenza e ho aperto gli occhi trovando il volto di mia madre a qualche centimetro dal mio. Mi sono quasi spaventato. Lei ha riso, invece, bella ed elegante come il sole che aveva fatto entrare spalancando le imposte.
«Scusa, non intendevo svegliarti, ma volevo capire come stavi. Mangiato pesante?»
«No, mangiato molto. Ma bene.»
«Ho saputo.»
Impossibile mantenere un segreto in quel gineceo.
«Che ore sono?»
«Le tre.»
«Di notte?»
«Sciocco.»
A Boston, talvolta, dormivo fino al pomeriggio inoltrato. Magari quando non avevamo allenamento al mattino o in certi giorni liberi in cui mi piaceva oziare a casa. Passavo da una stanza all’altra e poi mi buttavo sul divano davanti al camino a guardare la tv via cavo. E magari mi riaddormentavo lì, fino a che non mi svegliava la signora delle pulizie che, per inciso, si lamentava che c’era poco da pulire. Sono sempre stato molto ordinato.
Il sonno, per me, non è mai stato una necessità, o almeno non solo, soprattutto un piacere.
«Be’, che hai intenzione di fare?»
«Una doccia.» Mi sono alzato e sono andato in bagno.
Quella sera ho esordito in cucina, nella partita dei primi, con esiti disastrosi. L’unico aspetto della vita del cuoco a cui non riesco a adattarmi è quello di dover pranzare prima del lavoro. Capisco che dopo, alle quattro del pomeriggio o a mezzanotte, non sia possibile, però volevo provare a farlo. Veramente non sapevo ancora, di preciso, cosa volevo. Ero entrato in quel periodo della vita in cui un essere umano ha chiuso un’epoca della sua esistenza e non ne ha ancora iniziata un’altra. Non ero un cuoco e non ero uno sceneggiatore. Però ero lì, e con le parole di mio padre ad ancorarmi alla famiglia, non potevo certo mettermi in vacanza. Sì, avrei avuto il denaro per poterlo fare. Ma non era quello il punto. Così mi sono presentato alle sette di sera con un paio di vecchi jeans, una maglietta e delle Superga recuperate in uno stanzino (quante cose di me rimanevano in quella casa). Nella sala è calato il silenzio. Sono andato al tavolo dove c’erano le pentole e i vassoi con la cena. Penne al ragù e cosce di pollo con patate al forno. Chi pensa che la squadra di cucina di un grande ristorante si cibi con i piatti che vengono preparati per i clienti, s’inganna. Mi sono seduto a un posto libero. Lorenza, a cui toccava la sala quella sera (le ragazze facevano a turno), mi ha fatto l’occhiolino quando le sono passato accanto.
Ho guardato i ragazzi attorno a me. Erano tutti molto giovani, anche il sous chef di mio padre, Attilio, un toscano ironico e pungente, che non arrivava alla mia età. Era famoso per le sue battute pepate che non temeva di indirizzare neanche al Grande Capo. Il quale, per parte sua, ne apprezzava la franchezza e lo trattava molto meglio di Maggiorasca e, in generale, di tutti gli altri che avevano occupato il posto ai piedi del trono. Ma anche lui sembrava intimorito dalla mia presenza. Mi hanno salutato tutti con cordialità, ma stavano sulle loro. L’unica anziana, e l’unica che si è alzata per abbracciarmi e baciarmi, era la Titti, “a segnua dei pansotti”. Non so quanti anni avesse, ma nei miei ricordi c’era sempre stata, come la Lucia di San Maurizio con le sue torte di riso. Era la signora che preparava le paste fresche, ma era dispensata dall’ultimo atto: del ripieno, infatti, si occupava mio padre, chiuso in qualche stanza segreta con la ventiduesima erba. Ora sarebbe toccato a me.
La Titti era sempre curata, anche con il grembiule unto. Un bel taglio di capelli di colore ramato, un filo di trucco. Un ricordo mi ha attraversato improvviso. Io, mio padre e Maria in cucina. Io che lo osservo mentre taglia un calamaro. «Vi faccio una fisarmonica» dice papà. Infila nel calamaro color marmo un grande coltello e, con un altro, più piccolo, rapidamente taglia la parte superiore del mollusco in tante piccole fettine. Quindi toglie il coltello e ci mostra il calamaro agitandolo. Fa effettivamente uno strano effetto, sembra proprio una fisarmonica. A me piace, sorrido, capisco che è un gioco ma anche che ha un senso nella preparazione di qualche piatto. Maria invece scoppia in lacrime. La signora Titti spunta improvvisamente da chissà dove.
«Pulin cusse ti ghe?», e si porta via Maria. Io invece rimango, curioso di vedere che fine faccia il calamaro-fisarmonica.
Dov’erano questi ricordi? Dove li avevo nascosti? Stavo lì, con una coscia di pollo in mano e quasi non mi sono accorto del silenzio sceso nuovamente sulla sala. Ho alzato lo sguardo e ho visto che tutti guardavano dietro di me. Mi sono voltato.
Alle mie spalle c’erano mia madre e le mie sorelle. Iole teneva le mani tese in avanti e reggeva qualcosa di bianco. Giovanna aveva una macchina fotografica, Maria una magnum di champagne e Lorenza portava solo i suoi occhioni, ma bastavano.
Mia madre mi ha sorriso. Poi ha detto: «Ragazzi e ragazze, questa sera Augusto esordisce in cucina. Siamo tutti contenti ed emozionati e vogliamo dividere questa gioia con voi».
Mi sono trovato così in una specie di cerimonia di cui ero protagonista. Iole ha mostrato che cosa portava.
Una candida giacca da cuoco. Nuova di zecca, doppiopetto, con dei bei bottoni di madreperla. In petto, a destra, c’era scritto “Da Iole”, sotto un pansotto, il simbolo del ristorante tutto in oro. A sinistra, in rosso, il mio nome.
“Augusto Cavasso.”
Mi sono alzato e l’ho indossata. Mi stava bene, ci stavo bene.
Che cos’era quella trasformazione?
Ma prima che potessi darmi una risposta attendibile il botto dello champagne ha scatenato applausi e urla.
È stato tutto molto eccitante.
Fino all’ingresso in cucina.
![]()
Nessuno si aspettava il mio fallimento. Nemmeno io, lo confesso. Credevo che me la sarei cavata meglio, anche se ero convinto, alla prima esperienza in cucina, di non poter fare scintille. Però non lo ricordo come un incubo e neanche con un senso di imbarazzo, piuttosto come una rivelazione, la scoperta di una nuova coscienza, come quando cominci a giocare, a qualsiasi gioco di squadra. Magari pensi di avere un ruolo e invece scopri che vai meglio in un altro. Certo nessuno, e io per primo, pretendeva che arrivassi subito alle vette di mio padre, ma il racconto di Lorenza sulla mia interpretazione dei pansotti e il clima di entusiasmo attorno a un Cavasso maschio in cucina, hanno prodotto un’attesa negli altri e in me una sicurezza, che si sono rivelate eccessive.
Insomma, anche le cose più semplici si sono dimostrate insormontabili. Siete mai entrati nella cucina di un ristorante in piena operatività? Si va, si viene, ci si sfiora, come in un autoscontro ma senza la possibilità e il divertimento di rimbalzare uno addosso all’altro: se ti scontri, si sbagascia tutto. È un continuo strappo di brevi urla che portano comande. Quando il servizio è entrato nel vivo, Attilio ha preso in mano la situazione, come faceva sempre quando non c’era mio padre. Tutti si muovevano rapidi ed efficienti.
Tutti, tranne me. Li guardavo affascinato, appoggiato al mio spicchio di bancone, quando Attilio si è rivolto proprio a me.
«Prepara un soffritto di topinambur.»
Dopo, nei mesi successivi, ho scoperto che i ragazzi della cucina mi chiamavano “Mister Topinambur”.
Ho afferrato una padella qualsiasi e l’ho messa su un fornello, rimanendo lì a fissarla come intontito. Ho capito, in quel momento, che non sapevo di cosa parlava, ho compreso l’enormità dell’equivoco.
«Olio, poi fai imbiondire l’aglio, aggiungi lo scalogno...» mi ha sussurrato Attilio, cercando di non far catalizzare l’attenzione della cucina su di me. Ma tutti, ormai, mi stavano guardando.
Ho messo l’olio nella padella e ho cominciato a tagliuzzare l’aglio su un tagliere. La mia velocità di esecuzione doveva essere estremamente ridotta perché una mano, gentilmente, mi ha spinto di mezzo metro più in là.
«Scusi...»
Un cuochetto con lo sguardo imbarazzato mi ha sorriso. Neanche il tempo di meravigliarmi per quanto fosse bravo con il coltello, e aveva già preparato quello che spettava a me.
Il suo intervento, se da un lato è stato umiliante, dall’altro mi ha salvato da una figuraccia ben peggiore.
Non avevo, infatti, la più pallida idea di cosa fosse un topinambur.
Con abilità, come sfuggendo a un blocco in una partita dura, mi sono sfilato dalla batteria dei primi e, sempre sorridendo, sono arretrato fino a uscire dalla cucina.
Era mancata la comunicazione tra me e la mia famiglia. Il momento di commozione aveva preso il sopravvento sul senso della realtà e la realtà era che i miei successi con i pansotti e prima ancora con il King Crab erano indiscutibili, io avevo una capacità. Ma, per usare un paragone da basket, il problema era il trasferimento dal playground nel parco al Madison Square Garden, dalle partite con gli amici o dalle sfide uno contro uno nel cortile dietro casa, allo Staples Center, con ventimila persone che ti ululano contro e cinque giganti quasi sempre neri che ti stritolano non appena prendi la palla.
Ero stato vittima di un equivoco. Io ero un cuoco creativo, ma non ancora un cuoco da combattimento. Avevo, probabilmente, il genio e, di sicuro, il sacro fuoco, ma dovevo studiare e applicarmi per reggere al clima da battaglia della cucina di un grande ristorante. Per questo mi serviva un buon professore.
Meglio, se oltre che bravo, fosse stato anche bello.
![]()
Io ho smesso di ansimare prima di lei. Rossella, in fondo, non era un’atleta come me. Fino a pochi giorni prima giocavo le finali della NBA, perdinci. L’ho guardata. Per fortuna portava uno dei suoi meravigliosi prendisole anni ’70, facili da togliere, e sotto delle nuove Eres (rosa, modello Festin), che ero stato attento a non distruggere come l’altra volta. Adesso le mutandine erano arrotolate a una delle sue caviglie, perché non mi aveva lasciato il tempo di completare l’opera e di sfilargliele del tutto. Però, recuperandole, ha notato una macchia d’erba.
«Cazzo, devo cominciare a comprare l’intimo sulle bancarelle del mercato per velocizzare...