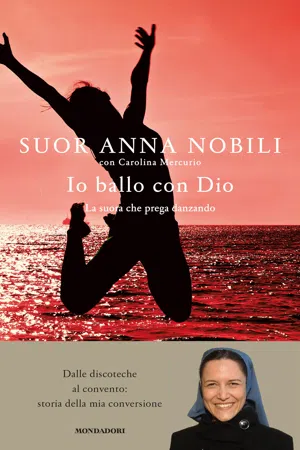![]()
Il tempo passa e sto per finire la terza media a Milano. La convivenza in casa degli zii diventa ogni giorno più difficile, noi ospiti sappiamo di essere un peso e ci accorgiamo che nessuno ha più voglia di fingere, di nascondere l’insofferenza con l’indifferenza. Mamma, alla fine del suo lavoro di donna delle pulizie a ore, continua a cercare una casa tutta per noi, in affitto. Ci dice che è più difficile di quanto sembra, è complicato trovare un buon alloggio a un buon prezzo. Cerca, cerca e quando finalmente trova, non riesce a essere felice come avrei immaginato dovesse essere. Sembra un robot, da quando ha perso l’amore della sua vita, che l’ha abbandonata senza nessuna spiegazione è disperata. Non pensa che a lui e al perché della sua sparizione. Sa che mio padre l’ha denunciato e che rischia di essere cacciato dalla caserma, ma vorrebbe parlare con lui almeno un’altra volta, vuole sentire la sua voce. Chiede il mio aiuto per convincerlo a tornare o almeno per avere una spiegazione. Mi chiede di telefonargli e io non so più quante volte l’ho fatto senza approdare a nulla. Il ritornello è sempre lo stesso: «Ciao sono Anna».
Muto
«La mamma sta male, perché non torni con lei?»
Muto
«Lei ti pensa sempre, vuole almeno parlarti.»
Muto
«Perché hai lasciato la mamma?»
Muto
«Torna con lei per piacere…»
Muto
«Lei non è felice senza di te.»
Muto
A un certo punto non ha più risposto e nemmeno alzato la cornetta.
Bastano sedici passi per misurare la mia nuova casa ringhiera, dieci davanti e sei di lato, gabinetto alla turca in cortile, bagnarola di plastica nel sottoscala per il bagno delle grandi occasioni, letti a scomparsa e, grande lusso, un piccolo frigorifero tutto per noi. A noi inquilini di diritto e cioè io, mamma, i miei fratelli, un gatto nero, due tartarughe e un canarino, ben presto si aggiunge il nuovo fidanzato di mia madre, un indiano di venticinque anni di cui lei è di nuovo perdutamente innamorata. Lavorano insieme, nella stessa casa, lei va a stirare a ore e lui fa il maggiordomo, si piacciono e mamma se l’è portato a casa.
La terza media finisce, esco con sufficiente e con la prospettiva, suggerita dagli insegnanti, di una scuola professionale. L’unica possibile, pare, adeguata alle “mie scarse risorse e capacità”. Non sanno, né sapranno mai che io sogno il liceo artistico, ma devo dare loro ragione, come sempre gli altri hanno ragione, io devo incominciare a lavorare il prima possibile, mia madre, i miei fratelli, la nostra casa hanno tutti bisogno del mio aiuto e allora, via i grilli dalla testa, prima incomincio a lavorare e meglio è.
Mi iscrivo a una scuola professionale femminile di operatrice di ufficio. Durerà due anni e dopo quattro esami e un titolo di studio, potrò cercare un lavoro. In alternativa potrei lavorare subito con mia madre per fare pulizie a ore. Meglio la scuola, anche se non è quella che mi piace.
Ed è proprio in questa scuola che le mie compagne di classe danno un nome importante a “quel miscuglio di inadeguatezza”, parole delle mie insegnanti, che mi accompagna. Dicono che ho un complesso d’inferiorità. Per me non cambia nulla se invece di timidezza o di semplicità lo chiamano complesso d’inferiorità. So di certo che, se ipoteticamente riuscissi a parlare senza tartagliare, nessuno ascolterebbe quello che ho da dire e se avessi qualcosa da dire nessuno ne sarebbe interessato. So di valere poco, so di non essere come gli altri ragazzi, ne sono certa, mi sento come i vestiti usati della parrocchia che ho addosso, un avanzo. Oramai tutta la classe mi insulta e qualsiasi cosa faccia o dica è motivo di maltrattamenti. Il mio stato di “inferiorità” in questa scuola peggiora di giorno in giorno, mi fa male, mi offende ma non posso farci niente.
Mia madre mi vuole aiutare, mi ha regalato un jeans Rifle che, anche se non è la marca del momento, è pur sempre una marca e in più è un jeans nuovo tutto per me. Ho deciso, voglio che gli altri si accorgano di me, al pantalone nuovo che indosso con orgoglio, d’ora in poi aggiungerò una bella novità: inizio a truccarmi la faccia, spennello il viso con tanta terra, contorno gli occhi con mezzo centimetro di matita nera e tanto rimmel e infine coloro le labbra con un rossetto rosa luccicante. Mi sento più bella e più vicina alle mie compagne. Le suore, che gestiscono la scuola, si lamentano del mio cambiamento, rimpiangono la semplicità perduta, si lamentano della mia esagerazione e stanno provando a farmi tornare come prima. Io me ne frego di loro e vado avanti per la mia strada. Una cosa mi dispiace: solo le suore si sono accorte del cambiamento.
E gli altri?
C’è un ragazzo che mi piace tanto, lo vedo ogni giorno quando vado a scuola perché lo incrocio alla fermata del bus. Quei momenti in cui osservo di sfuggita i suoi vestiti, i suoi capelli, la figura snella e attraente sono sufficienti a farmi sognare. Certo è un problema, lui non sa che esisto.
Sono presa di mira da un gruppetto di ragazze compagne di classe, si divertono a torturarmi accentuando con ogni sistema possibile le mie difficoltà. Balbettare continua a essere il mio supplizio maggiore e loro mi molestano fino a costringermi a reagire, a parlare ed espormi così al loro scherno.
Oggi ci sono riuscite in pieno. Fabiana, invece di poggiare la cartellina sul mio banco, come ha fatto per tutti gli altri compagni, l’ha tirata con violenza contro di me e io, per la prima volta, vincendo la paura, mi sono costretta a chiederle:
“Pe pe pe per ché lo ha ha ha hai fa fa fa fat fat ttto?”.
Mi ha risposto con uno schiaffo in piena faccia e con un secco:
«Stai zitta tu» e poi ha continuato rivolta agli altri: «Adesso questa parla pure!».
Non ho più osato controbattere, loro sono superiori a me, io non posso stare al loro livello e allora devo stare sotto.
Le amiche del quartiere sono diverse dalle mie compagne di scuola, non mi trattano male, però mi trascurano. Per esempio non mi chiamano mai per uscire a passeggio insieme e mi lasciano ad aspettarle inutilmente pomeriggi interi.
È un po’ che penso di parlare loro per sapere perché si comportano così, ci provo ma la paura mi blocca e non mi resta che continuare a fare finta di niente e a sperare che si ricordino di me.
A me piace avere delle amiche, mi piace fare dei regalini, pensare bene di loro, essere gentile, uscire insieme, raccontare e ascoltare i nostri segreti, incontrarsi per studiare, giocare e farsi le confidenze.
Un’amica è importante, è importante come una sorella.
Io alle mie amiche di quartiere ci credo, allora mi sono fatta forza e sono riuscita a chiedere, dopo tanti ripensamenti, perché non mi fanno uscire con loro e finalmente, senza arrabbiarsi, mi hanno spiegato. Loro vorrebbero sempre portarmi a passeggio ma non possono perché quando usciamo insieme i ragazzi non le guardano più, dicono che guardano solo me perché sono la più bella. A me dispiace, io non mi sento bella e non mi sono mai accorta di essere guardata più delle altre. Vorrei discutere, spiegare che a me dei ragazzi non importa niente, che non voglio rubare niente a nessuno, che preferisco la loro compagnia a cento ragazzi, ma non ce la faccio, non me la sento di discutere e di rischiare di perderle per sempre.
Non mi resta che stare sotto.
Io mi sento, anzi io sono, una sfigata.
Ho un’amica nuova, una sfigata come me. Siamo due escluse, la nostra amicizia ci consola e crediamo, senza dircelo, che due sfigate insieme possono fare una persona normale.
Ma come bisogna essere per sentirsi una persona normale?
Usciamo insieme da un po’ di tempo e per non andare dove stanno gli altri, giriamo al largo infilandoci per interi pomeriggi nei grandi magazzini. Guardare tutte quelle cose nuove sistemate sugli scaffali in bell’ordine, divise per colori, per prezzo e per qualità ci affascina.
Come sarebbe bello avere a casa un po’ di quella roba.
Il massimo piacere ce lo dà il reparto profumeria, i trucchi sono veramente affascinanti. Ispezioniamo attentamente i banconi, proviamo le novità sul dorso delle mani, ci imbeviamo polsi, collo e vestiti di più profumi possibili, passiamo gli ombretti con la punta delle dita sulle palpebre e ci tappezziamo le labbra con lucidi coloratissimi e luccicanti. Usciamo contente delle prove e delle scoperte fatte ma afflitte e insoddisfatte per l’impossibilità di comprare. Tornare a casa senza nessun acquisto è veramente frustrante. Ci consoliamo stazionando ancora un po’ fuori dalle grandi porte a vetri, per guardare le donne uscire gratificate, con pacchi e pacchettini, felici delle scelte. Io le immagino tornare a casa, scartare gli acquisti, condividerli prima con lo specchio e poi con la famiglia.
Io torno nella mia casa di sei passi per dieci, affollata e disturbata dal giovane fidanzato indiano di mia madre e non ho nulla da scartare, nulla di cui godere. Rifletto e mi dico che questo nuovo gioco è una crudeltà, forse è meglio cambiare e andare a divertirci in qualche altro posto, dobbiamo perdere questa abitudine di girare per grandi magazzini.
Ne parliamo, io e la mia amica sfigata siamo d’accordo, questo gioco è cattivo. Io e la mia amica sfigata, però, non abbiamo nessuna voglia di cambiare gioco.
E allora?
Allora determinate e incazzate inventiamo una variante strepitosa.
Non so bene di chi delle due è l’idea, anche se credo che a questo punto non ha nessuna importanza, mi chiedo invece come mai non ci sia venuta in mente prima.
Seguendo un piano preciso, studiato, meditato, provato e riprovato, arriviamo organizzate alla prima meta: upim. Come normali clienti ci aggiriamo fra gli scaffali e i banconi del reparto profumeria. Sappiamo che non dobbiamo fare niente per attirare l’attenzione. A me tocca la parte più difficile, me ne rendo conto quando la mia amica rimane in disparte, si guarda intorno e con un movimento impercettibile della faccia mi dà il via.
Sono sola intorno allo scaffale illuminato, fingo interesse per un ombretto viola con i brillantini, lo prendo, mi avvicino allo specchio e provo a vedere l’effetto del colore sulla mia pelle. La mia amica, dall’altra parte del reparto non si muove, sta a significare che è tutto sotto controllo. Provo a chiudere l’ombretto nel palmo della mano, ci sta comodo e decido che si può fare. Lo tengo stretto mentre passo a ispezionare i rossetti, anche se sono così agitata che non li vedo. Gli occhi si muovono troppo velocemente per mettere a fuoco, mi guardo intorno, ho paura, è troppo difficile, devo scambiare i ruoli con la mia amica che cattura il mio sguardo e fa cenno di sì con la testa. È facile per lei, mi dice di sì e poi sparisce. E io? Se mi beccano a casa succede il finimondo con l’indiano che vuole comandare e mia madre che lo lascia fare. Però l’ombretto è bello e costa troppo per me.
Mi arriva la cacarella, gira nella pancia e spinge, devo decidere, devo sbrigarmi, ho la bocca secca, ingoio la saliva che non trovo e asciugo ancora di più bocca e gola. Guardo la borsa appesa al braccio e mi accorgo che è posizionata come nelle prove. Ho la sensazione che il rossetto bruci come un peperoncino sulle labbra, ho bisogno di un fazzoletto e decido di cercarlo nella borsetta. Ne ho messo un pacchetto di carta, ne sono sicura, ho bisogno di pulirmi la bocca, soffiarmi il naso e asciugare la lacrima che sento bagnarmi l’occhio sinistro, ho bisogno di trovare un gabinetto. Rovisto agitata nella borsa e mentre cerco, tento di prendere una decisione su come uscire da quella situazione insopportabile e quasi senza rendermene conto, apro la mano e lascio cadere nella borsa ombretto e rossetto che continuavo a stringere. Incredibile, i due astucci sono nella borsa e intorno a me è tutto normale.
Il sollievo inatteso mi ricarica.
Mi piace, vorrei prendere tutto e scappare.
Sono euforica e terrorizzata insieme, non riesco più a scegliere. Le mani si muovono spasmodiche su scatoline, astucci, ampolle e matite. Non cerco il consenso della mia amica, non ho tempo da perdere, afferro l’afferrabile, lo imbosco in borsetta e scappo.
Cammino spedita sino alla fermata del bus e crollo seduta sulla panchina. Ho il cuore che batte frenetico in contrasto con il senso di leggerezza e di soddisfazione che provo. Quasi subito mi raggiunge sfigata-due che sembra più spaventata di me, aspettiamo l’autobus senza parlare e dopo poche fermate scendiamo in un parco e ci dividiamo il bottino. È un piacere strano, sembra che tutto quello che porti a casa ti sia dovuto, almeno per la paura che hai provato, è come fossi una paladina della giustizia perché ti pare in questo modo di poter rimediare alle differenze odiose e insopportabili fra chi può e chi non può.
A casa però è un’altra storia, il piacere di possedere qualcosa di superfluo, arrivato come una festa a sorpresa, sparisce immediatamente dinanzi alla prepotenza di quel ragazzo, poco più grande di me, che solo perché è il fidanzato di mia madre, ha deciso di sostituire mio padre. Da quando è arrivato si è imposto, è arrogante e autoritario. Dice che siccome ci manca il padre deve controllarci e comandare a ogni costo. Il mio presunto patrigno si concentra soprattutto su di me e pretende di darmi gli orari per uscire e rientrare, mi controlla vestiti, trucchi e amici. Sta diventando padre-padrone e siccome non voglio accettare i suoi ordini, sto imparando a rispondergli a tono. Con lui non intendo stare sotto per nessun motivo e per non stare sotto, imparo a reagire. Mi ribello, non ascolto mai quello che vuole, non mi interessa quello che dice perché ne sono sicura, è tutto sbagliato, per me lui non esiste. Non posso accettare che uno sconosciuto prenda il posto di mio padre, anche se è un posto vuoto.
Quel buco nero continua a esserci grande e profondo e non si riempie nemmeno con tutta la mercanzia proveniente dalle spedizioni, ormai sempre più frequenti, ai grandi magazzini. È una frenesia di cui ho bisogno, è un gioco che mi appaga. Uscire dopo il pericolo scampato con la borsa piena, mi dà un’esaltazione a cui non voglio rinunciare anche se so bene che, a bottino diviso e tornata a casa, tutta quella euforia svanirà nel nulla, anzi quelle stupidaggini rubate mi daranno un fastidio strano che necessiterà di altre inutili merci da aggiungere alla mia inutile collezione, il prima possibile.
Ripetere i furti diventa necessario, il pensiero di rinunciarvi non mi sfiora, non posso più farne a meno. Giungerà in mio soccorso l’incubo notturno ricorrente di essere beccata e condannata a togliermi il vizietto.
La scuola è finita e mi tocca cercare subito un lavoro. Mi guardo intorno, le possibilità sono tante e io non sono capace di scegliere. Mi basta un qualunque sì di un datore di lavoro per sentirmi coinvolta e, quasi mi facessero un piacere, non oso rifiutare nulla, non rifiuto nemmeno le loro mani che mi toccano spasmodiche dove capita senza un motivo apparente, se non quello di verificare la mia sottomissione a loro.
Sarò ortolana per qualche mese, barista in un chiosco stradale per un’estate e cameriera in diversi ristoranti. Distribuirò volantini pubblicitari e tanti piccoli lavoretti occasionali. Ora vendo cerotti porta a porta. È il lavoro più brutto che ho provato sino a ora, è difficile vendere porta a porta e se ti limiti a suonare solo alle case dei privati lo è ancora di più. Infatti, per allargare il mio campo d’azione inizio a rivolgermi a uffici e studi.
Una mattina suono alla porta di uno studio di architettura. Mi fanno entrare ...