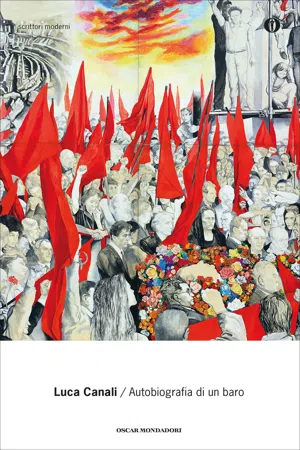![]()
Il mio primo innesto, dalla Sezione Colonna alla Monti, determinò una violenta reazione di rigetto. Ora so che fu responsabilità mia: questa reazione, più o meno intensa, si è determinata in ogni trapianto settoriale che abbia visto in me l’intruso venuto a sancire l’insufficienza di un organismo in tal modo considerato incapace di esprimere dirigenti politici propri. Ma il punto d’attrito doveva essere superato da una dimostrazione di efficienza e di serietà che mettesse in luce la validità dell’operazione. E questo sono riuscito a fare negli anni ’50-55, in altre tre sezioni.
A Monti fallii, per l’inevitabile ostilità dei compagni, scompensata dal mio risentimento: venivo dalla direzione di Colonna, e pensavo che la stima mi fosse dovuta come a un capo già largamente collaudato sul campo, una sorta di carisma ereditabile da un quartiere all’altro.
Ero invece solo un pivello con una buona esperienza alle spalle, ma, nella nuova mansione, presuntuoso, permaloso, e per di più invaghito di una Miki diciottenne che mi accompagnava in Sezione il pomeriggio, o s’appartava con me la sera dietro la Basilica di Massenzio facendo levare grida ai frati d’un convento sovrastante che una sera ci rovesciarono addosso un catino d’acqua facendo prendere la grippe a Miki.
Gaio, figlio di Teodoro – il vecchio segretario spodestato, con molta sua buona grazia invero, e anzi addirittura con una parvenza di aiuto che cercò di darmi all’inizio –, giovane per sua natura incline all’ironia e alla beffa, mimava con efficace cattiveria le mie telefonate d’amore con voce bassa e il capo quasi contro il muro da cui rimbalzavano alcuni «sì, cara», «certo, cara», «dimmi, cara», che divennero proverbiali, e argomento di riso apparentemente bonario fra tutti i giovani della Sezione, che Gaio – forse pretendente per diritto di successione alla scrivania di segretario – capeggiava con il suo prestigio di indigeno e la sua audacia nel dileggiare l’investito dall’autorità federale.
Gaio, l’ho sempre saputo, mi era ostile. Ma io non fui capace di superare la sua diffidenza e la sua opposizione. Del resto neanche io lo amavo, come non amavo nulla di Monti, e questo era il mio basilare difetto. Non mi piaceva il quartiere – la Suburra, via Cavour, via dei Serpenti, via del Boschetto, via Capocci – che pure aveva stupendi confini, Colle Oppio e la Basilica di Massenzio. Lo trovavo socialmente anonimo, declassato senza vitalità sottoproletaria, o piccolo-borghese e bottegaio, privo di redenzione passionale, scarso di umori sia pure mercantilmente popolareschi. Vi sentivo qualcosa di bieco e untuoso. Inoltre ci aveva abitato Blasi, gappista traditore dei Gap in tempi di Resistenza.
Ma ero epidermico nel giudizio e nel risentimento. Monti era un rione popolare dove un rivoluzionario di professione, quale credevo di essere, doveva riuscire ad ambientarsi. Era però, a mia discolpa, la prima esperienza extra moenia della mia quinquennale roccaforte di Colonna, di cui conoscevo tutto, compagni, cellule, strade, aziende, vicoli, colore di palazzi e selciati, fontanelle, angoli bui.
Di Monti – ciò è tipico di un’intima rimozione – non ricordo né luoghi, eccettuati quelli dei miei convegni con Miki, né compagni, se si tolgono Teodoro, il figlio Gaio e il buon filiforme Fiacchi che poi morì in un incidente d’auto. Di cellule di azienda ricordo solo lo stabilimento tipografico Nava e i Vigili del Fuoco; di cellule di strada nessuna.
«Luca è meglio che cambi sede. Ora più che qui serviresti a Mazzini, dove Ventura è stanco e vuole intraprendere la sua attività di magistrato» mi disse Sergio, vice-organizzatore federale. Aveva capito tutto. Monti con me ristagnava peggio che con l’anziano Teodoro.
«Che ne dici di Mazzini? I compagni già aspettano da noi un rinforzo.»
«Ne dico bene. Quando?»
«Anche subito.»
Non ricordo neanche il congedo da Monti.
A Mazzini non volevo deludere. Non ci fu bisogno di abnegazioni. Fui accolto senza acredine, e io stesso non feci errori mettendomi a sussurrare frasi d’amore al telefono contro il muro, e Miki la portai a lavorare ai giornali murali in Sezione. Il quartiere era difficile: media e alta borghesia impiegatizia, avvocati, magistrati, professionisti, medi e alti gradi militari, scuole, caserme. V’erano anche zone mercantili, ma isolate e scarse. Nerbo rosso del quartiere il Deposito Atac Bainsizza, Personale Viaggiante e Operai, e Cassa Mutua Atac; alla periferia di zona persino un’appendice sottoproletaria, con i suoi angiporti, vecchie case cadenti, baracche, compagni dall’indecifrabile passato ma dal sincero presente, Prato Falcone.
Lavoravamo molto, persino nelle difficili agende Poste-Mazzini e Rai-Tv. Ripetevo l’esperienza di Colonna, spesso mi prodigavo anche al mattino in volantinaggio, convocazioni, riunioni, giornali murali o parlati al mercato, e mi ritrovavo stanco con Guido a concedermi un panino con raffinatezza borghese di bresaola o culatello, seduto su una panchina vicino a una fontanella dei giardini pubblici.
Tenni comizi volanti, e alcuni statici e bene organizzati come quello con Luciano L., allora segretario nazionale dei chimici, senza pipa e la sfumatura dei capelli alta, in piazza Mazzini. Guidai scontri con i missini e i savoiardi più virulenti del quartiere, con esito incerto data la loro abitudine di spadroneggiare nelle strade. Il filo rosso passava soprattutto attraverso case private e salotti, a parte le aziende, agucchiato da distinte signore, chiarissimi professori, capi-ufficio, persino nobiluomini staliniani che indussi ad accompagnarci nell’affissione di manifesti e raccolta di firme per la pace. Insomma, non vivacchiai, ripetei l’esperienza in ascesa di Colonna, dimenticai Monti. Mi preparavo inconsapevolmente a Ludovisi, che di lì a poco sarebbe stata privata per decisione federale del suo segretario affarista.
A Mazzini sentivo l’amicizia dei compagni: Ferruccio, gigante biondo, segretario della III di strada, e suo fratello Leo, geologo, Ruggero, gentile e astratto, della V di strada, Ruscani, emaciato dalla vita, di Prato Falcone, Pisapìa dei tassisti, Garofalo delle Poste, Ciofi, allora segretario giovanile, ora dirigente regionale, i Marra, marito, moglie e figlio, attivi e affettuosi, i fratelli Di Crescenzio con Fortunato attempato scapolo, inesauribile inventore di fantasie, cacciatore di fidanzate di cui s’invaghiva perdutamente e che mai si risolveva a impalmare, Boni, scattante operaio del Deposito Atac, Bruno barbuto di Solidarietà Democratica, persino Aldo R., pittore, discusso compagno di passate ribalderie estremistiche, Antonucci, organizzativo, giovane avvocato, Pedicino, pediatra di vaglia, e notabili come Lucio L.R., Guido M., la Regard, madre della gappista; e il solerte Pelacani, il sistematico La Cognata, buffi nomi, buoni compagni.
Vestivo un’indistruttibile giacca di tweed, camicie senza cravatta, pantaloni di flanella, scarpe casual con suola di gomma, una comoda tenuta polivalente, per comizi, attacchi, assemblee, fughe dalla polizia.
Organizzammo un’assemblea di quartiere per Molè e riempimmo il Delle Vittorie, fenomeno mai accaduto nel quartiere. Molè se ne compiacque in Federazione. Mi ero riabilitato dalla disfatta di Monti.
Tenni un affollato comizio in piazza Strozzi, e belle ragazze mi chiedevano l’autografo. Solo a una che mi guardava, in disparte mormorai un appuntamento poi degustato a Villa Balestra.
La domenica partecipavo ai balli di Sezione, ma senza tediare nessuno con allocuzioni, alla fine aiutavo Gigi nel conteggio degli introiti.
Era un’attività continua, stancante, ma anche una vita piena e serena, meno appassionatamente torbida che a Colonna. Continuavo a studiare per la laurea.
Un sabato sera, la Sezione era quasi deserta, mi telefonarono dall’Ufficio Propaganda di Federazione. Alla rosa di comizi domenicali mancava un oratore per Villaggio Breda, zona tutta operaia, mi dissero. Avrei dovuto andare io. Fui felice di acconsentire. Ancora vagheggiavo l’espressione “proletario”; e l’esperienza operaia mi mancava. Prenestino era ancora lontano.
Pensando al comizio dell’indomani immaginavo compagni rudi e gentili, uomini semplici, ma ricchi di umanità, evoluti nei limiti dell’ideologia e della pratica rivoluzionaria quotidiana, incontaminati dalla tv, dalle file domenicali in macchina per la gita al mare, dall’assenteismo programmato, dal fucile da caccia, dall’evoluzione neocapitalista.
Il boom non c’era ancora stato. Non avrei amato in seguito gli operai “imborghesiti” dalla società affluente. Avrei lottato al loro fianco, ma senza passione, in fondo senza stima. E in questo si celava un errore: la visione deformata di uno stereotipato operaio-artigiano di piccola industria. Non conoscevo, non immaginavo nemmeno le flessioni, tensioni, fughe indietro e in avanti, ambizioni motivate, spiegabili contraddizioni sociali e psicologiche di un grande agglomerato industriale. Misuravo ancora la condizione operaia con l’esperienza d’un velleitario ribellismo nutrito da individuali utopie e intellettualistici rigori. La realtà mi dava torto, tanto più mossa, frastagliata, spietata e insieme indulgente delle mie illusioni egalitarie.
La lezione la ebbi subito, proprio in quel fantomatico comizio a Villaggio Breda. Presi il trenino delle vicinali alle quattro del pomeriggio. Era una nuvolosa giornata di aprile. Avevo dimesso il tweed, indossavo l’abito blu con in tasca gli appunti, una camicia con cravatta rossa, all’occhiello il distintivo del Partito. Mi ero messo in divisa da oratore comunista. Avevo persino cambiato le scarpe casual con un paio nere che mi stringevano, facendomi sentire nell’impaccio di una circostanza eccezionale, come un battesimo, un matrimonio, una testimonianza in tribunale. Mancava poco che mi fossi anche tagliati i capelli.
Mi ero proposto di fare un comizio sull’attualità politica – in vista di una tornata di elezioni amministrative in giugno. Ma avevo anche ripassato I principi del leninismo. Pensavo che soprattutto in una zona come quella fosse necessario collocare la pratica riformatrice in una prospettiva di teoria rivoluzionaria.
Vidi attraverso i vetri del finestrino sfilare grandi quartieri, poi i palazzi diradare, e venirmi incontro gruppi di case modeste, squallide borgate, poi campagna. Cominciò a piovigginare. Non m’impensierii, da rivoluzionario coerente mi ero portato anche l’ombrello, e mi immaginai protetto da quella cupola di rayon nero, sul palco, concionare nella pioggia davanti a una platea invisibile sotto una tettoia di altri ombrelli. Ripassavo mentalmente il comizio.
La pioggia cadeva ora fitta, insistente, da un compatto cielo grigio. Mi preoccupai.
Scesi sul piazzale del Villaggio, al riparo della pensilina della fermata. Era una grande spianata fangosa. Sullo sfondo il cupo edificio d’una fabbrica, i cancelli sprangati, le ciminiere senza fumo. Ai lati, palazzi di recente fabbricazione, modesti ma decorosi.
Ora pioveva a dirotto. Mi passò dalla mente il testo del comizio, uscii dalla pensilina con l’ombrello aperto, le scarpe nere subito infangate. Non c’era nessuno ad aspettarmi. Non mi avevano detto il luogo dell’appuntamento. «Vai al Villaggio Breda», mi avevano semplicemente proposto, e io pensavo a una comunità in attesa, non a un deserto sotto il diluvio.
In un angolo del piazzale scorsi uno scheletro di tubi Innocenti, un progetto di palco non realizzato. Non ci sarebbe dunque stato comizio. La rivoluzione rimandata per la pioggia d’una sera d’aprile, pensai scioccamente. Mi chiesi se i compagni si fossero dispersi o fossero riuniti in qualche luogo. Cominciai la ricerca.
Sotto l’ombrello insufficiente, con le suole delle scarpe che passavano l’acqua, cominciai una battuta nel Villaggio che sembrava deserto. Si sentiva solo il latrato furioso di un cane dietro il cancello della fabbrica. I palazzi sul piazzale sembravano disabitati, quasi tutte le serrande abbassate. Da un quarto d’ora ero lì e non avevo ancora visto una persona.
Imboccai una stradetta che metteva nell’entroterra. Udii in lontananza delle voci. Scorsi a cinquanta metri una piccola piazza: lì, dietro l’imbellettata faccia esterna del Villaggio, c’erano povere case, l’antica struttura dell’agglomerato. I palazzetti presuntuosi, deserti, ospitavano certo nuovi ricchi, era la zona residenziale; gli inquilini, forse caporeparto e impiegati della fabbrica – l’intero Villaggio, mi avevano detto, viveva di quella media industria – dovevano essere andati in città, al cinema, in visita a qualche parente, alla partita. Le voci che udivo dovevano essere quelle degli operai rimasti in zona.
Mi avviai verso il punto da cui provenivano forti e compatte, con qualche tono stridulo, qualche bestemmia, una risata, un battere di nocche sul legno di un tavolo.
Era una grande bettola stipata. Entrai in quell’aria fumosa, odore forte di vino, litri semivuoti sui tavoli, carte da gioco, carichi di briscola sbattuti con forza sul tavolo – ecco quel rumore di nocche –, avventori vestiti a festa, sbarbati, vestiti blu come il mio, ma anche maglioni, giacche di cuoio, impermeabili non tolti.
Restai sulla soglia, fradicio di pioggia, con i piedi a bagno. Sentivo umidità e disagio fin dentro le ossa, nonostante fossi rinfrancato dalla presenza di tanti compagni.
Decisi di chiedere all’oste, dietro la cassa ricavata da una botte. Era un uomo grasso, calvo, sudato, con baffetti unti, sottili, in strano contrasto con le gote cascanti. Aveva un lapis dietro l’orecchio, una salvietta intorno al collo. Mi avvicinai, guardò il mio strano aspetto.
«C’è qui il segretario di Sezione?»
«Quale sezione?»
«Quella comunista.»
S’incuriosì, mi squadrò. «Io sono missino, qui ce n’è molti. Ma giocano a carte con i compagni. Siamo tutta gente che lavora, meno i disoccupati s’intende. Anche fra i disoccupati ci sono camerati. Lei cosa vuole dal segretario comunista? Mengoli, dice, quello che lavora alle Tasse. Ma sarà andato a Roma, ha figli e nipoti laggiù. La domenica va sempre a trovarli.»
Rimasi interdetto, anche stordito da quella miscela di notizie deludenti.
«Ci doveva essere un comizio in piazza.»
«Già, ma è stato rimandato per il tempo. Lei era venuto per questo? Vede, sono missino, qui ci sono, come le dicevo, camerati, democristiani, repubblicani. I comunisti sì sono i più, ma siamo tutti lavoratori. E sa quale è il primo partito della zona? I socialdemocratici, i piselli, come li chiamate. Vai a capire. Ma c’è molta gente nuova che abita qui, impiegati, negozianti, borghesi; il Villaggio è cambiato. Voi comunisti non volete rendervene conto. E poi la domenica questa gente che lavora tutta la settimana vuole passare qualche ora tranquilla, a casa, a giocare a carte o al bigliardo nel bar di fronte. Anzi guardi, li troverà di sicuro Capoferro, un vecchio comunista che anche noi rispettiamo, è stato in carcere, ha pagato, non tanto vecchio poi, oltre i sessanta. Chieda a lui, starà sicuramente giocando a boccetta, è il campione qui.»
Aveva avuto forse pietà del mio aspetto di cane bagnato.
Al bigliardo trovai in effetti Capoferro. Giocava con impegno, ma interruppe, serio, quando gli dissi che la Federazione m’aveva mandato per il comizio. Era davvero come aveva detto l’oste: capelli bianchi a spazzola, volto amaro, ma occhi limpidi, sereni, corpo asciutto, giovanile per la sua età, una maglietta che gli lasciava scoperte le braccia con le grosse vene di chi ha lavorato a lungo manualmente.
«Mi dispiace, compagno. La Propaganda in Federazione sapeva che il comizio era incerto per il tempo, dovevano dirtelo. È già qualche giorno che piove. Ora mi vesto e se vuoi ti accompagno ai tram della Stazione. Ho una vecchia seicento. Ti risparmio il trenino.»
«Ma non si potrebbe riunire i compagni in Sezione, fare una riunione al chiuso?»
«La chiave della Sezione – una stanzetta, cosa credi? – ce l’ha il compagno Mengoli, e lui non c’è. Poi in Sezione entrano non più di venti, trenta persone. E i compagni aspettavano un comizio, riunioni ne facciamo anche troppe, e pochi fatti. Togliatti avrà anche ragione, ma qui la gente vorrebbe risolvere presto i problemi, la casa, il pane, una scuola qui e non a dieci chilometri, la piazza asfaltata e non polvere d’estate e fango d’inverno. Tu cosa sei, studente?»
Annuii. Mi sentivo ridicolo con i miei appunti in tasca. Non c’erano stati operai in tuta, forse neanche in fabbrica la portavano. Né comizi sotto gli ombrelli. Scene da film, o da foto sul giornale. Era questa la mia esperienza? Eppure la disfatta di Monti e la vittoria di Mazzini dovevano avermi insegnato qualcosa. Non esistevano falansteri né paradisi né inferni operai. C’erano uomini che lottavano per una vita migliore, non individualmente ma insieme, e spesso a fianco di avversari politici. E la domenica volevano riposare, giocare a carte e a bigliardo, anche se erano vecchi compagni che erano stati in carcere.
«No, compagno Capoferro, non ti scomodare. Torno in treno. Speriamo in un’occasione migliore.»
«Speriamo. Mi dispiace per il tuo viaggio a vuoto. Torna tu al prossimo comizio. Sei un intellettuale, e noi ...