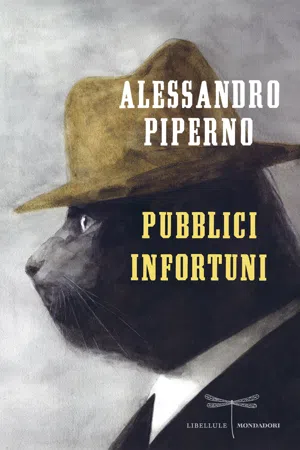![]()
Non amo i romanzi d’avventura. Non sono mai riuscito a terminarne uno. Stevenson mi annoia, per non dire di Verne. Persino il grande Conrad mise a dura prova i miei nervi infantili.
Capisco che il mio aspetto sedentario possa autorizzare chiunque a immaginarmi invischiato fin da piccolo con carta, inchiostro, fumanti tazze di tè. La verità è che a dodici anni, a fronte di una sensibilità precocemente esacerbata, sguazzavo nel tiepido mare dell’analfabetismo di ritorno. I miei sogni di gloria, del tutto convenzionali, si esaurivano in qualche prodezza podistica o canora.
Così oggi mi ritrovo a invidiare i miei colleghi che, intervistati sulle prime letture, possono aprire cassetti pieni di corsari, selvaggi, principesse... In quanto ai miei, di cassetti, be’, sarebbero vuoti se non potessi contare sulla storia che sto per servirvi: l’avventurosa storia che fece di me un sentimentale lettore di romanzi seri.
Galeotto fu l’amore.
Ero all’ultimo anno delle medie quando scoprii quanto avvincente e drammatico potesse essere un amore non corrisposto. Vi risparmio i dettagli sulla volubile ragazzina e sui miei patimenti di teenager. Vi basti sapere che lei si chiamava Viola e che il pozzo in cui mi aveva infilato era talmente pesto e profondo (per non dire dei pipistrelli) da instillarmi il sospetto, non troppo sano, che amare significasse precipitare nel buio.
Un giorno decisi di smettere di mangiare. Uno sciopero della fame in piena regola. Come quelli di Gandhi, con la differenza che lui protestava contro la protervia dell’imperialismo britannico; io, in modo più saccente, contro l’imperturbabilità dell’universo.
All’undicesima ora di digiuno (a conti fatti, un solo pasto saltato), mio padre entrò nella mia stanza. Evidentemente era stato informato che, dopo il pranzo, ero intenzionato a saltare anche la cena. Malgrado fossi fiaccato dal languore degli innamorati, e dai morsi della fame, ero deciso a difendere quella che a tutti gli effetti mi sembrava una posizione politica (in seguito non ne avrei più prese).
Lui non mi parlò di cibo, né osò minacciarmi. Si limitò a poggiare un libro sul comodino.
«Leggilo» disse.
Che sciocchezza! L’idea che una cosa pallosa come un libro potesse sciogliere il grumo di desiderio frustrato che mi ostruiva l’esofago sembrava un insulto. Tuttavia il ragazzino in copertina aveva qualcosa di famigliare. Si trattava del quadro di Modigliani Il figlio del portinaio, così recitava la didascalia. So che campeggiava sulla copertina color latte in polvere della collana letteraria all’interno della quale, negli anni a venire, avrebbero trovato spazio i libri più emozionanti della mia vita. Eppure nessuna delle cose che so oggi è in grado di restituirmi l’empatia che mi colse alla sprovvista la prima volta che incrociai quel mesto sguardo di ragazzo. Tutto mi accomunava a lui: solitudine, indolenza, inessenzialità.
Il libro si intitolava Il segreto. L’autore era anonimo. Per la precisione, Anonimo Triestino. Una specie di inno al mistero. Oh, ecco finalmente un mistero attraente. Il mistero del ragazzino senza nome con un segreto da custodire, ovvero il mio stesso mistero, il mio stesso segreto.
L’introduzione di Linuccia Saba (la figlia del grande poeta triestino) iniziava così: “Qualche anno fa, in uno dei piccoli, famosi caffè, rifugio e abitudine dei triestini, e nei quali si usava trovarsi con gli amici (...), in uno di questi locali lungo la riva del mare, mi davo spesso appuntamento con un mio vecchio amico, vecchio di anni e amico da sempre (uno di quegli amici che ci fanno sentire, come la famiglia, ancora un po’ bambini e che si ritrovano solo nelle nostre città natali, e ai quali si dà del lei mentre loro ci danno del tu). Era un uomo affascinante, solitario, timido e appassionato, aperto, generoso e schivo”.
Doveva essere lui l’uomo senza nome cui alludeva il titolo. Il ritratto che ne faceva Linuccia Saba mi metteva addosso una strana inquietudine. Come se una parte di me capisse tutto l’ostinato riserbo di quel vecchio signore.
Ve la faccio breve. Il tizio solitario accompagna Linuccia Saba alla stazione e, prima che lei salga sul treno, le dice di aver scritto un romanzo. E aggiunge: “Nessuno lo ha mai letto, e nessuno, me vivo, lo leggerà. Ma quando sarò morto vorrei che tu lo leggessi e, se pensi che ne valga la pena, fallo vedere a un editore. Ma devi promettermi che non dirai mai a nessuno, per nessun motivo, che l’ho scritto io”.
Linuccia, un po’ spiazzata dalla melodrammatica richiesta, promette, se ne riparte per Roma e dimentica la faccenda. Fino a quando, pochi mesi dopo, riceve il manoscritto del vecchio amico, insieme alla notizia della sua morte. Lo legge, lo trova sensazionale, lo fa pubblicare da Einaudi e maledice se stessa per essersi lasciata estorcere l’incauto giuramento.
Il turbamento suscitato in me da questa introduzione non era niente a confronto del terremoto emotivo prodotto dalla dedica del libro e dal suo incipit.
A Bianca,
nel cui costante pensiero le ho scritte,
dedico queste pagine, perché si meravigli, e sorrida
di tante fanciullaggini,
e provi forse un po’ di rimpianto.
Se oggi, nel trascriverla, mi colpiscono soprattutto la sintassi macchinosa e il lessico ottocentesco, la prima volta che la lessi mi bastò sostituire al nome “Bianca” quello della mia amata (da un colore all’altro) per sentire il groppo in gola premere fin quasi a soffocarmi di commozione. Ero certo di essere il solo uomo sulla faccia della Terra che potesse capire una dedica del genere. Così romantica, così nostalgica, così piena di magnanimità. Ma allo stesso tempo così subdolamente ricattatoria!
L’attacco del libro, invece, era decisamente autocelebrativo: “Non c’è alcun dubbio: io fui un bambino precoce”. Possibile che quest’uomo mi avesse letto dentro così bene? Fu la prima volta nella mia vita in cui provai risentimento verso un autore che mi aveva rubato l’idea per un romanzo.
Molti anni dopo, all’università, sarebbero stati parecchi i professori che avrebbero cercato di inculcarmi due principi fondamentali della lettura:
1) Non identificarsi mai con i personaggi.
2) Non confondere la voce del Narratore con quella dell’Autore.
Per fortuna l’Anonimo Triestino mi aveva già donato l’antidoto per resistere al veleno di quei dogmi assennati e meschini.
A tredici anni non ebbi il minimo dubbio: il romanzo d’amore dell’Anonimo Triestino con la sua Bianca e il mio con Viola erano due gocce d’acqua. La sola differenza era che lui l’aveva già vissuta, digerita e scritta. Io non avevo avuto accesso neppure alla prima fase. Pagina dopo pagina, scoprii che Il segreto non era altro che la vicenda nevrotica di un ragazzo sensibile e precoce che si innamora di una ragazza sui banchi di scuola e per tutti e cinque gli anni di liceo non riesce a dirglielo. Non mi sorprendeva che dopo una storia del genere il tizio si fosse trasformato in un vecchio solitario, uno scrittore di romanzi anonimi. D’altra parte ero contento che quel romanzo fosse diventato un bestseller. Il riscatto postumo dell’Anonimo Triestino mi sembrava davvero una gran bella cosa.
Grazie al cielo mi tornò l’appetito e con esso la voglia di vivere. Concepii un piano temerario, e lo portai a termine. Regalai a Viola il romanzo. Ne fu molto stupita: i libri non erano il nostro forte. Non arrivò oltre pagina 40. Mi disse che era troppo pesante, troppo deprimente.
Imparai un altro paio di lezioni:
1) Mai regalare libri amati a persone amate.
2) Diffidare dei lettori che si deprimono.
La lettura appassionata fece nascere in me una morbosa curiosità nei confronti dell’identità dell’Anonimo Triestino. Non avevo motivi di dubitare della veridicità dei fatti narrati da Linuccia Saba. Cominciai a investigare. Interrogai diverse persone (a cominciare da mio padre). Nessuno ne sapeva niente. Feci anche una telefonata al “Messaggero” per chiedere se Linuccia Saba fosse ancora viva. Mi dissero che non potevano aiutarmi, lì non lavorava nessuno con quel nome. Scrissi all’Einaudi. Da bravo editore, non rispose. Finché me ne feci una ragione. Non avrei mai conosciuto il nome dell’Anonimo Triestino.
Ultimo anno di liceo. Sono ospite nella casa al mare di un mio compagno. È notte fonda. Dovrei già dormire da un pezzo nella stanza che mi è stata destinata ma non la smetto di rigirarmi nel letto. Inutile combattere. Accendo l’abat-jour e mi metto a curiosare nei cassetti (una delle mie occupazioni preferite in casa d’altri). Purtroppo il bottino è modesto: un libro (assai malconcio) di storielle ebraiche. Via, meglio di niente. Non senza tedio, inizio a leggere il saggio introduttivo pieno di triti cliché sull’ironia ebraica... A un certo punto vedo apparire questa frase meravigliosa: “Senza naturalmente dimenticare quel capolavoro tardo: Il segreto dell’Anonimo Triestino (alias Guido Voghera)”.
Avevo un nome. Finalmente, dopo un sacco di tempo, avevo un nome.
All’epoca non esisteva ancora Google, ma le biblioteche sì. Tornato a Roma, mi chiusi alla Nazionale e cercai altre opere di Guido Voghera, o almeno qualcuno che avesse scritto di lui. Niente. Di Voghera ce n’erano parecchi, ma nessun Guido. Mi rassegnai piuttosto in fretta. E in una parte remota di me ne fui felice: ero contento che l’Anonimo Triestino rimanesse fedele a se stesso. La sua storia, persino molti anni dopo averla incontrata, continuava a sembrarmi a dir poco esemplare di ciò che uno scrittore dovrebbe fare: scrivere e scomparire. Dal mondo delle ombre, vendicarsi con encomiabile discrezione.
Passano altri anni. Frattanto sono diventato (anche per l’influenza mefitica dell’Anonimo Triestino) una di quelle sbiadite figure che la nostra società produce industrialmente: un aspirante accademico con velleità di scrittore.
Un giorno ritiro in libreria i testi per un esame di Letteratura italiana. Mi siedo al tavolino di un bar e do un’occhiata ai libri. L’attenzione viene subito rapita dal cognome di uno degli autori. Voghera. Purtroppo non il Guido Voghera che inseguo da qualche tempo, solo un Giorgio Voghera qualsiasi. Il libro si intitola Gli anni della psicanalisi. Il risvolto mi informa che l’opera contiene il ritratto dal vivo di alcuni mostri sacri della grande tradizione triestina: Svevo, Saba, Bazlen e compagnia bella. Scorro distrattamente l’indice e mi blocco esterrefatto di fronte al titolo di un capitolo: Biografia di Guido Voghera. La vera storia di mio padre.
Proprio così: il libro che avevo in mano era stato scritto dal figlio dell’Anonimo Triestino. Dunque l’Anonimo Triestino aveva avuto un figlio. Già questo era incredibile e in qualche misura increscioso. L’Anonimo Triestino, almeno il mio Anonimo Triestino, non avrebbe mai fatto un gesto così costruttivo come quello di procreare.
Ero troppo emozionato per mettermi a leggere. Il piacere di svelare finalmente il piccolo mistero che mi accompagnava da qualche anno meritava di essere procrastinato. Riuscii a indugiare per un altro paio di giorni. Poi mi immersi nella lettura. Più leggevo, più restavo deluso. Non solo per il tono cronachistico di questa breve biografia, non solo perché Il segreto dell’Anonimo Triestino tardava a essere menzionato. Ma perché l’individuo di nome Guido Voghera, almeno nel ricordo del figlio, non corrispondeva in alcun modo all’uomo sulla cui vita antieroica avevo così fervidamente fantasticato.
Ok, era un misantropo. Per il resto si trattava di un tipo gagliardo, dai fermi ideali socialisti. Non uno che manda tutto a puttane per amore. Non un romantico fallito. Come poteva un uomo del genere aver scritto Il segreto?
Finalmente arrivo alla parte in cui Giorgio Voghera parla della sola opera narrativa scritta dal padre: Il segreto, per l’appunto. Poche righe, del tutto impersonali, nelle quali Giorgio rivela che, per scrivere il suo unico romanzo, il padre si è ispirato a un’esperienza vissuta dal figlio. È Giorgio, il figlio, l’amante inconsolabile di Bianca Sorani. Non Guido, il padre. Che storia è questa? Il figlio vive un amore segreto e il padre ne tira fuori un romanzo? E se l’amore del figlio è davvero segreto, come può il padre esserne a conoscenza? Qualcosa non quadrava. Mi sentivo preso in giro, turlupinato. La storia più commovente in cui mi fossi mai imbattuto, la storia che mi aveva formato, non era altro che un divertissement letterario, l’ozioso esercizio di un vecchio signore che vuole fare il verso al figlio.
D’altro canto tutto questo mi induceva a riflettere sul potere della letteratura. Ero un lettore già abbastanza consapevole da sapere che tipi smart come Borges e Nabokov avevano suggerito un’idea della letteratura come mistificazione e inganno. Ciononostante stentavo ad accettare che l’autore che aveva cambiato la mia vita fosse un impostore. No, questo non riuscivo a perdonarlo, né a Guido né a Giorgio Voghera.
Da che insegno (ho iniziato a farlo presto), ho l’abitudine di andare in facoltà al mattino molto presto. I corridoi vuoti ravvivati dal bagliore ramato dell’alba. L’odore del caffè scadente nel bicchiere di plastica. La lezione da preparare in santa pace.
Anche quel giorno ero arrivato in facoltà alle sette e mezza. Prima di mettermi al lavoro avevo dato una scorsa ai giornali. Partendo dalle pagine sportive per scivolare su quelle culturali. C’era un breve elzeviro in cui Claudio Magris commemorava la morte appena avvenuta di Giorgio Voghera. Tra le altre cose, Magris scriveva: “Con Giorgio Voghera, nato nel 1908, scompare l’ultimo classico della letteratura triestina e della Trieste ebraica. Autore di libri di diversa qualità, alcuni dei quali indubbiamente notevoli, Giorgio Voghera è legato soprattutto a uno straordinario romanzo, che narra la sua storia, come egli ammetteva, ma del quale non si sa con certezza se l’autore sia egli stesso o, come ufficialmente si ritiene, suo padre Guido Voghera: Il segreto dell’Anonimo Triestino, uscito da Einaudi nel 1961, un capolavoro aspro e struggente, la storia impietosa e inesorabile di una incantata perdizione amorosa che si blocca in un’acre inibizione”.
Quando lessi queste parole di Magris avevo quasi trent’anni. Ne erano trascorsi diciassette dalla prima volta in cui mi ero interrogato sull’identità dell’Anonimo Triestino, ed ero convinto di aver da tempo risolto il rebus. Ma ecco che un articolo rimetteva tutto in discussione. Era evidente che Magris non fosse poi così convinto che quel formidabile libro lo avesse scritto il padre per conto del figlio. Anzi, Magris lasciava intendere che l’autore misterioso fosse il figlio e che l’idea di attribuirlo al padre fosse da derubricare tra i gesti di pudicizia estrema: una beffa inflitta a se stesso con sconcertante determinazione. Ecco: questo sì che mi sembrava un atto degno dell’Anonimo Triestino.
Quella che segue non è la trascrizione della...