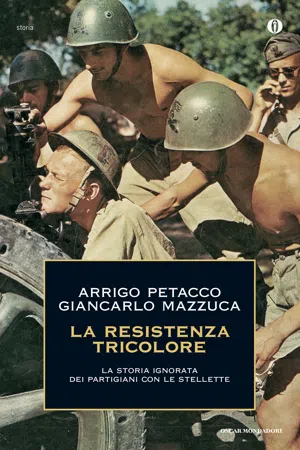![]()
Una pagina dimenticata
Come purtroppo è capitato ai tanti partigiani con le stellette, anche la storia degli internati militari in Germania è stata per molto tempo trascurata. Ne conoscevamo il numero (circa seicentomila). Sapevamo con quali angherie i tedeschi e i rappresentanti della Repubblica sociale avevano cercato di indurli a cooperare. Sapevamo che la stragrande maggioranza aveva tenacemente resistito alle loro false lusinghe. Ma sapevamo anche che la loro resistenza era stata dettata dal giuramento di fedeltà al re d’Italia.
Proprio per questa ultima ragione, la storia degli internati non era gradita alla sinistra comunista e, di conseguenza, essa finì in una sorta di limbo della memoria. Molti di loro, fra i quali Giovannino Guareschi, Giovanni Giovannini, futuro presidente della Federazione della Stampa, Giovanni Ansaldo, giornalista famoso, e Giuseppe Novello, uno dei più acuti disegnatori umoristici italiani, scrissero i loro ricordi o documentarono la loro prigionia con significativi disegni, ma l’Italia ufficiale preferì esaltare soltanto la Resistenza senza stellette e la sua epopea.
Il ghiaccio fu rotto da Alessandro Natta, segretario generale del Partito comunista dal 1984 al 1988, che solo nel 1991, dopo il crollo del Muro di Berlino, parlò della propria esperienza di internato e rivelò che già nel 1954 aveva scritto un libro sulla sua vicenda, ma che il suo partito gli aveva proibito di pubblicarlo perché «non opportuno» o, come si dice ora, non «politicamente corretto». Il libro fu infatti pubblicato soltanto nel 1997 con il titolo L’altra Resistenza ed ebbe il merito di «sdoganare» finalmente anche a sinistra la storia dei nostri internati.
I seicentomila che dissero no
«Schnell!» divenne dopo l’8 settembre un avverbio tristemente noto anche a chi non parlava tedesco, insieme al tono minaccioso con cui veniva pronunciato. I militari italiani, tra soldati e ufficiali, catturati e imprigionati nei lager dopo l’armistizio, per un ordine della Wehrmacht datato 10 settembre 1943, come abbiamo detto, furono circa seicentomila. Di questi, soltanto un’esigua minoranza (circa diecimila) accettò di aderire alla Repubblica sociale, e furono subito rimpatriati, mentre coloro che rifiutarono l’adesione, per fedeltà al giuramento, rimasero nei lager nazisti sino alla fine del conflitto, sottoposti a un trattamento particolarmente duro. I tedeschi decisero infatti di non riconoscere la dichiarazione di guerra fatta dal governo del Regno del Sud il 13 ottobre 1943 e quindi di non applicare nei loro confronti quanto stabilisce la Convenzione di Ginevra per quanto riguarda i prigionieri di guerra. Di conseguenza, gli italiani non godettero del trattamento riservato ai prigionieri inglesi, francesi e americani. Per i nostri soldati fu coniata l’inedita classificazione di Imi (Internati militari italiani), che era del tutto ignorata dalle convenzioni internazionali e che li sottraeva alla tutela della Convenzione. Essi potevano perciò essere sottoposti ai lavori forzati ed essere passibili di fucilazione in caso di resistenza o di tentata fuga. Nella gerarchia della sofferenza, essi venivano dopo gli ebrei e alla pari con i russi, i polacchi e gli slavi.
Nell’inverno del ’43, durante i primi mesi di prigionia, capitarono nei lager i rappresentanti della Repubblica di Salò per cercare nuovi adepti. L’ambasciatore a Berlino della Rsi, Filippo Anfuso, e i suoi emissari lanciarono, sotto lo sguardo scettico degli stessi tedeschi, appelli alla difesa della patria e di Mussolini, alla lotta contro i demo-plutocratici-giudaici-bolscevichi alleati, che concludevano, puntualmente, con la promessa di più pane e margarina! Gli appelli non ebbero il sostegno delle autorità naziste, che tolleravano ma disprezzavano ormai sia i fascisti sia l’esigua minoranza che aderì alla Repubblica di Salò. Tanto che furono gli stessi tedeschi a definire «volontari della fame» coloro che passarono in un secondo momento alla Rsi, molti dei quali restarono comunque per mesi nei campi accanto a chi non aveva aderito alle lusinghe dei repubblichini, separati dagli altri prigionieri solo da qualche filo spinato, ma sostanzialmente equiparati a essi quanto a trattamento.
La Germania aveva allora un urgente ed estremo bisogno di mano d’opera, sia nell’industria che nell’agricoltura. Gli uomini tra i diciotto e i cinquant’anni erano stati tutti richiamati alle armi, le fabbriche e le campagne si erano svuotate, cosicché, con milioni di uomini disseminati sui vari fronti, occorrevano nuove braccia per mandare avanti la produzione. L’idea di utilizzare, a costo zero, le migliaia di prigionieri a disposizione era stata suggerita dal dinamico ministro degli Armamenti Albert Speer, grazie al quale, secondo gli storici, la durata della guerra fu prolungata di almeno due anni. Con questo espediente, Speer riuscì infatti a intensificare la produzione bellica portandola a livelli mai raggiunti neppure in tempo di pace.
Per la verità, già dall’inizio della guerra molti lavoratori italiani erano impiegati nell’industria tedesca, ma si trattava di volontari attratti dalle buone paghe. Al Reich comunque non bastavano e Hitler aveva insistito con Mussolini per averne altri. Da parte sua, il duce non lo aveva accontentato del tutto e gli aveva inviato soltanto dei disoccupati non in età di leva, trattenendo invece i giovani in età di leva e gli specializzati che lavoravano nelle industrie belliche italiane. Soltanto dopo il 25 luglio 1943, caduto il fascismo, le cose cambiarono. Già il 26 luglio nel quartier generale del Führer, prevedendo l’uscita dell’Italia dal conflitto, era stata messa allo studio la possibilità di utilizzare le forze armate italiane catturate come manodopera a costo zero. «È un imperativo» aveva dichiarato il feldmaresciallo Wilhelm Keitel, capo del comando supremo delle forze armate tedesche.
Dal 15 settembre 1943 i direttori delle fabbriche e delle aziende agricole più importanti della Germania cominciarono a richiedere alla Wehrmacht operai e agricoltori da inserire nel ciclo produttivo. I prigionieri italiani che erano stati deportati negli oltre seicento campi di concentramento del Reich vennero quindi selezionati per essere destinati al lavoro coatto. Interi gruppi finirono nei lager di Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Flossenbürg, Bergen Belsen, a formare il cosiddetto Arbeitskommando, unità di lavoro. Altri vennero dirottati nelle fabbriche e nelle miniere, dove erano stati approntati dei recinti abitativi dai quali non era consentito uscire.
Hitler pertanto mandò avanti l’industria bellica grazie a centinaia di migliaia di prigionieri privi dei requisiti necessari per essere protetti dalle convenzioni internazionali (italiani, russi, slavi eccetera), che furono sottoposti a turni di lavoro massacranti e a condizioni di vita durissime. Alloggiati in sudicie baracche di legno, con le pareti piene di fessure da cui entravano pioggia e gelo, con servizi igienici volutamente umilianti e giacigli infestati dai pidocchi e dalle cimici, i soldati italiani, considerati traditori, furono trattati senza alcuna pietà e rispetto.
Ecco, per esempio, la testimonianza di Lino Monchieri, tratta dal libro Gli schiavi di Hitler di Ricciotti Lazzero, che ben riassume il trattamento riservato ai nostri soldati:
Fui immatricolato col mio vero nome e grado, nel lager XB di Wietzendorf-Soltau, con il n. 158353. Sulla piastrina era incisa ben chiara la sigla «Kr. Gef.» (Kriegsgefangener), prigioniero di guerra, ma in realtà ero uno schiavo. Fui infatti segregato in un campo di prigionia cintato da due ordini di filo spinato, guardato a vista da sentinelle incombenti su torrette munite di mitraglia, nonché maltrattato e insultato dai soldati di guardia, carichi d’odio e di brutalità. Soltanto verso la fine del mese di settembre 1943 mi fu fatta firmare una cartolina prestampata in lingua tedesca e francese, con tredici sole parole, dirette alla mia famiglia: «Mi trovo prigioniero dei tedeschi in Germania. Godo di buona salute e vi saluto». La cartolina, però, non fu mai spedita e non giunse mai a casa.
Il secondo paragrafo dell’art. 5 della Convenzione di Ginevra dice: «I prigionieri che si rifiutassero di rispondere sulla situazione nel loro Paese non potranno né essere minacciati né insultati né esposti a molestie o a svantaggi di qualsiasi specie». Per Hitler quei patti erano pezzi di carta straccia. Fummo sottoposti a continue minacce (e lusinghe fallaci) perché aderissimo alla Repubblica sociale e collaborassimo a fianco dei nazisti. Fummo coperti d’insulti dettati dall’odio razziale e dal pregiudizio sociale contro gli «uomini del Sud», mangiatori di pastasciutta, falsi e bugiardi. Per pura avversione antitaliana misero in atto contro di noi continue molestie. Durò a lungo la punzecchiatura verso i singoli prigionieri, cui veniva rivolta regolarmente l’insidiosa domanda: «Tu sei per Badoglio o per Mussolini?». Cessò soltanto quando imparammo a rispondere con dignità: «Io sono italiano, e basta».
I ricordi di chi ebbe la forza di sopravvivere al massacro si assomigliano tutti. A partire dalla descrizione del rancio, un unico pasto giornaliero, costituito, nel migliore dei casi, da un infuso di tiglio, rape secche bollite, un pezzo di pane, che spesso sapeva di segatura, e venti grammi di margarina. Ricordando le sue esperienze nei lager della Wehrmacht, il tenente cappellano don Giuseppe Colombo racconta che nella primavera del 1944, nel campo di lavoro di Neunkirchen circa duemila italiani erano allo stremo per la fame e il durissimo lavoro nella miniera e negli altiforni. Si contarono parecchi morti per incidenti sul lavoro e per rappresaglia da parte della polizia tedesca. Molti prigionieri morirono d’inedia. Un accordo raggiunto nel luglio 1944 tra Hitler e Mussolini trasformò gli internati italiani in «lavoratori civili», ma furono solo vuote parole perché la maggior parte di essi continuò a essere sottoposta a una condizione di vera e propria schiavitù. Il tasso di mortalità tra i prigionieri italiani si rivelò di gran lunga superiore a quello dei prigionieri provenienti dalle altre nazioni.
La vita nei lager
Non fu necessario arrivare in Germania per provare la crudeltà della detenzione nei campi di concentramento. Caduti in mano ai tedeschi, i soldati italiani sperimentarono immediatamente un regime durissimo, volto a umiliarli e a distruggerne il morale.
La prigionia fu, in certi casi, resa aspra non solo dalle iniziative del Reich, ma anche dalle intimidazioni di chi aveva deciso di aderire alla Repubblica di Salò. Racconta Alessandro Natta nell’Altra Resistenza in cui ha rievocato le vicende della sua prigionia, dopo essere stato catturato dai tedeschi a Rodi, che un certo maggiore Migliavacca si presentava nei campi di raccolta, accompagnato da un gruppetto di militi in camicia nera, per consumare di fronte ai prigionieri affamati un abbondante banchetto a base di carne in scatola, pane e vino. Cercava in questo modo adepti per la Repubblica di Salò. Nessuno tra gli ufficiali e i soldati presenti, che di solito venivano separati solo dopo l’arrivo nei campi in Germania, si lasciò lusingare dai suoi ricatti.
Molti dei prigionieri italiani pensavano che non sarebbero usciti vivi dall’Egeo: i tedeschi avevano pochi mezzi di trasporto e solo gli ufficiali più alti in grado ebbero il privilegio di un trasporto aereo, comunque sempre a rischio, come i trasferimenti via mare, a causa delle incursioni degli Alleati. Una piccola nave da carico salpata da Rodi a metà febbraio del 1944 fu affondata in vista del Pireo, causando la morte di alcune migliaia di prigionieri.
Ricorda ancora Natta che a fine gennaio 1944 nel campo di Asguro, a Rodi, erano internati circa cinquemila soldati e una trentina di ufficiali. Dopo alcuni tentativi di imbarco andati a vuoto, la sera del 7 febbraio giunse l’ordine di partenza. I soldati cominciarono a muoversi all’alba dell’8 per imbarcarsi sulla nave da carico Oria. I prigionieri italiani, a cui le SS avevano requisito gli zaini con tutto ciò che contenevano, vennero fatti scendere nelle stive con penzolanti scalette di corda. Qui i soldati tedeschi, spingendoli violentemente a colpi di bastone, stipavano gli italiani via via che scendevano. I prigionieri erano stretti gli uni agli altri, in uno spazio angusto rispetto al carico, senza alcuna possibilità di muoversi. Fin dai primi minuti l’aria divenne irrespirabile. Solo dopo qualche ora di navigazione furono aperti i portelloni e fu concesso agli ufficiali e ad alcuni soldati di salire sul ponte all’aria aperta.
L’Oria giunse nella baia di Lero, dove gettò l’ancora, e i prigionieri furono fatti sbarcare sotto una pioggia incessante e un forte vento, per essere trasferiti con una lunga marcia a Portolago, dove i tedeschi, in una zona bombardata, avevano recintato un campo con filo spinato; le case che avrebbero dovuto costituire gli alloggi per gli italiani erano solo un cumulo di macerie. Le pareti sventrate non sorreggevano i tetti, mancava tutto: le porte, le finestre, la legna per scaldarsi, i gabinetti e soprattutto l’acqua.
Il pomeriggio del 4 marzo il gruppo di cui faceva parte Natta, dopo una lunga marcia, raggiunse la nave che doveva trasportarlo al Pireo:
Due stive, ognuna divisa in due piani. Si saliva sulla coperta oltre che per le scalette, anche per mezzo di corde: l’impaccio del pastrano, delle coperte, dello zaino rendeva pericolosa ed estenuante la salita, ma ancor peggio era la discesa nelle stive per i calci, le imprecazioni dei tedeschi. Si giungeva in fondo – quasi una tomba fra pareti d’acciaio – con le mani sanguinanti… Quando si iniziava la discesa, i tedeschi strappavano dalle spalle gli zaini e li cacciavano giù dove nel buio e nella confusione avvenivano scene selvagge fra i soldati che tentavano di riprendere la propria roba e si disputavano con accanimento la proprietà di qualche misero straccio. Due soldati, non reggendo allo sforzo della discesa, caddero e si spezzarono le gambe: restarono giù. Avevamo solo potuto compiere delle fasciature sommarie dato che un infermiere fortunatamente possedeva ancora qualche pacchetto di medicazioni. Restarono giù nello spasimo continuo, e sopraggiunse poi il delirio, dalla sera del 4 fino al mezzogiorno del 6: furono gli ultimi a lasciare la stiva perché fu necessario tirarli fuori con la gru.
Per due giorni Natta e i suoi compagni non mangiarono, ma non fu quella la peggior sofferenza nel viaggio allucinante verso il Pireo. La nave su cui erano saliti era giunta a Lero con un carico di viveri. Nella stiva era rimasta della farina, nera perché mescolata alla polvere e alla sporcizia. I soldati, spinti dai morsi della fame, non esitarono a mescolarla con dell’acqua fetida e a mangiarla, cruda così com’era. Tra i prigionieri, ammassati in piedi nella stiva, senza possibilità di muoversi, senza aria, in un caldo soffocante, si scatenarono coliche e attacchi di diarrea violentissimi. Nel frattempo la nave aveva raggiunto il Pireo, ma i tedeschi consentirono loro di sbarcare solo al mattino dopo, prolungandone così l’enorme sofferenza. In quelle condizioni, sporchi e devastati dalla diarrea, li fecero sfilare per le vie del centro di Atene per infliggere loro un’ulteriore umiliazione. Di fronte all’Acropoli era stato allestito il campo Maginot, dove per la prima volta ufficiali e soldati vennero separati. Il regime vigente al Maginot era una triste anticipazione di ciò che li attendeva in Germania: il solito misero rancio a base di minestra di rape, un piccolo pezzo di pane nero e una inconsistente razione di margarina, accompagnato dal sistematico saccheggio degli oggetti e degli indumenti di un qualche possibile valore.
L’esperienza di viaggio via mare vissuta da quegli uomini non è troppo diversa da quella via terra, raccontata dall’ufficiale degli alpini Luigi Collo, nel suo libro La Resistenza disarmata. Collo, appartenente alla divisione Tridentina schierata a Novo Gorlovka, nel bacino minerario del Donietz, fu catturato nel pomeriggio del 9 settembre 1943 e trasferito in diversi campi di prigionia, prima in Polonia, poi in Germania. Nel riferire le condizioni disumane con cui lui e altri militari furono deportati in un vagone merci nel lager di Sandbostel, nei pressi di Amburgo, scrive:
Una descrizione puntuale di questo viaggio allucinante durato cinque giorni richiederebbe un capitolo a parte, per dare un’idea dei disagi, delle scosse, del rumore infernale; del freddo terribile che ci ha costretti a stare ammucchiati l’uno sull’altro per cercare un po’ di calore; della sete che ci ha tormentati fino a farci delirare; della diarrea e dei crampi; dell’intorpidimento che ci coglieva, dei massaggi alle gambe che ci facevamo l’un l’altro per non assiderare. Nelle notti ci accompagnava il rombo lontano dei bombardamenti sulle città tedesche; di giorno abbiamo cercato di orientarci spiando dai finestrini, sbarrati da filo spinato e inferriate, e nelle rare apparizioni del sole abbiamo capito che si andava a ovest, in un paesaggio bianco di neve e gelido…
Con il coltello riesco a scavare nel pavimento un foro che usiamo come scarico, altrimenti il secchio sarebbe stato pieno in breve tempo: il freddo ci provoca crampi e scariche terribili… qualcuno comincia a raschiare il ghiaccio sporco sulle pareti del carro, con il risultato disastroso di far aumentare la sete… al mattino del quinto giorno siamo ormai al limite delle forze, affamati e deliranti per la sete. Il treno si ferma per l’ennesima volta, i carri vengono aperti. Davanti a noi si estende una landa pianeggiante coperta di neve. I tedeschi urlano di scendere: «Schnell, schnell». Siamo anchilosati e stremati, ma ci buttiamo giù di corsa. Da alcuni vagoni esce un lezzo disgustoso di feci e urina, vediamo facce stravolte di ufficiali che non si reggono in piedi, imbrattati da ogni sorta di luridume… le gambe intorpidite che ci provocano dolori fortissimi, ci avviamo verso il nuovo lager.
La fame, il freddo e le umiliazioni inflitte dai tedeschi non riuscirono a piegare i prigionieri italiani. Anzi, in certi casi le vessazioni ottenevano l’effetto opposto: all’istinto di conservazione si univa un ritrovato orgoglio e la ricerca di dignità. Per non soccombere, nei campi di concentramento era necessario svolgere attività che tenessero vivi la mente e il corpo. I nostri soldati si ingegnarono in molti modi, dalle attività sportive a quelle culturali, soprattutto nei campi in cui erano internati gli ufficiali. Bisogna riconoscere che ...