
- 352 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Hanno collaborato: Arnaldo Colasanti, Carlo Carabba, Stefano Iucci, Zygmyunt Bauman, Carola Susani, Alessandro Leogrande, Giorgio van Straten, Chiara Valerio, Lorenzo Pavolini, Tommaso Giartosio, Carlo Mazzoni, Andrea Kerbaker, Francesco Borgonovo, Jacques Darras, Alba Donati, Gaia Manzini, Luigi Cojazzi, Marco Del Corona, Niccolò Nisivoccia, Elena Salibra, Alberto Pellegatta, Roberto Deidier, Marisa Volpi, Giampiero Carocci, Gianluigi Simonetti, Marco Debenedetti, Graziano, Dell'Anna, Andrea Caterini, Leonardo Colombati, Maria Vittoria Smaldone.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Nuovi Argomenti (44) di AA.VV. in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Letteratura e Storia e teoria della critica letteraria. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
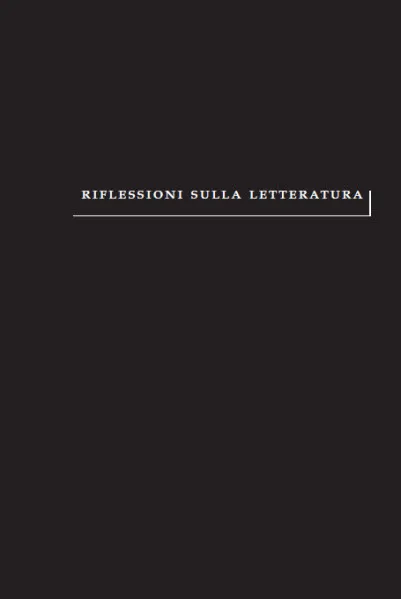
UN TRIBUTO ALLA POLVERE
ROBERTO DEIDIER
L’illusione è un sentimento. Precisamente come odio e amore, rancore e amicizia, o una programmata indifferenza. Proprio come questi, l’illusione è anche una prospettiva, almeno per lo spostamento che provoca nella nostra visuale consueta, quella delle lunghe bonacce di cui finiamo per non renderci più conto; poi, all’improvviso, e in modo del tutto imprevedibile, gli eventi si mostrano alla luce di questo sentimento e non importa a quale scala del tempo appartengano, se siano prossimi o remoti. Ciò che importa è che, da quel momento, la visuale si è ampliata o ristretta: sulla nostra esistenza, su quelle che continuiamo a chiamare le cose del mondo, perfino in una parte più o meno grande della visuale che gli altri aprono su di noi, intorno a noi.
I pensieri estesi procedono per generalizzazioni, amano le immagini vaghe della poesia: vaghe nel loro mostrarsi, ma mai nella loro sostanza più intima. Quelle più autentiche non mancano di colpire nel segno, fanno agire in chi legge o ascolta un moto di empatia, quel riconoscersi in una essenzialità comune, anche laddove il linguaggio sembra procedere in modo obliquo e allontanarsi da quel tanto di comune che deve esserci in ogni asserzione. Pure in questi casi, però, la poesia risulta sempre ovvia, nel senso più nobile: nel senso, cioè, che inevitabilmente ci appartiene, parla di noi.
Anche la memoria, che è tutt’altro che ovvia, procede nel vago. Non sono sicuro che si possa definire un sentimento, alla stregua degli altri che ho ricordato; ma se non lo è, certamente è il veicolo della maniera in cui filtriamo il vissuto, è una specie di bizzoso Mercurio nel sacrario dei nostri sentimenti. Viaggia senza sosta nel continuo dell’esperienza, pesca situazioni dimenticate o addirittura improbabili dal nostro passato e ne fa missive da spedire a noi stessi; come sostiene Leopardi, il suo è un intervento decisamente deviante, poiché nello spazio-tempo tra l’invio e l’arrivo di quella lettera si è sedimentato un sentimento. Tutto ciò che possiamo recuperare della nostra vita passa attraverso questo sentimento, questo moto puramente affettivo. Nel bene e nel male.
Verso la fine degli Ottanta, ancora nel bel mezzo dei vent’anni, indaffarato a leggere e a emulare e distratto, pienamente distratto dai rumori del mondo, Roma, la Roma dei poeti mi appariva lontanissima, come un’apparizione notturna dove si addensavano fotogrammi di letture pubbliche e presentazioni. Era un tempo, lo avrei compreso molto dopo, movimentatissimo nella sua apparente immobilità. Ogni settimana si poteva contare su qualche evento, locali nuovi e di ogni genere ospitavano volentieri rassegne più o meno importanti di poeti di ogni estrazione, sempre ammesso che la poesia ne abbia più di una. Le riviste che avevano agitato la vita letteraria della città si erano improvvisamente estinte, quasi insieme, così che avevo la sensazione di assistere al volgere di un’era, a una decisa mutazione; quelle che resistevano rischiavano di ripetersi stancamente, fisse nei loro moduli e quelle che nascevano sembravano già condannate a girare come una giostra vuota, prive di un vero progetto. Le novità, se di questo si può parlare, giungevano dalla provincia, anche distante; eppure sotto il cielo di Roma la poesia era ancora l’isola possibile, le parole si condensavano nei sotterranei del centro, a San Lorenzo, a Testaccio, nei teatrini che si riempivano di pubblico; e c’erano presenti le figure che già da un decennio riempivano la scena e tra loro alcune destinate a lasciarmi prematuramente e a divenire, per tutti, inquiete divinità di un pantheon vivace e affollato, quello delle Grandi Ombre. Questo era dunque il mondo: di lì a breve sarebbe crollato il Muro, alle spalle ci si era appena lasciati l’anno di Chernobyl. E io, ostinato, chiedevo conto di ogni cosa alla poesia, riducevo ogni notizia, ogni immagine televisiva ai pochi versi di una pagina: e andavo in cerca di un padre o di una madre, vagando di lettura in lettura.
Un sogno al ciclotrone, velocissimo. Le particelle di una vita che scorrono nella memoria, i colori che si fermano in una scia, come in una vecchia cartolina le luci delle auto: un intrico di linee bianche e rosse. È così che credevo la morte, come l’istantanea di un paesaggio conosciuto, dove all’improvviso il fermo immagine lascia vedere quello che resta del movimento, dell’energia dei corpi. Una scia a due colori che riempie lo spazio, quello còlto dall’occhio come vuoto. C’era dunque qualcosa di materico eppure non percepibile nell’aria, confini che si spezzavano al mio passaggio senza che ne fossi cosciente, tracce di chi era già passato di lì. Bastava una fotografia e la luce si condensava, prendeva forme fantasmatiche contro cui mi sarei scontrato senza avvertirle. Da bambino insorgono improvvisi sensi di colpa ed era proprio così che mi sentivo: responsabile di spezzare l’invisibile corrente di un mondo parallelo al mio, il mondo dei morti che insegue il mondo dei viventi, ne diviene la fluttuante appendice. Se valeva per le auto, doveva valere anche per gli uomini. Non ho capito quanto mi fosse vicina la linea che si stava tranciando, in un’estate afosa e opaca. Ricordo solo una telefonata di convenevoli, di parole vuote che divennero, in chiusura, la notizia più incredibile e impensabile. E le parole, sempre più efferate, che seguirono nei giorni e nelle settimane: poche, ma instancabilmente esatte, come un laser puntato a scandagliarmi le macerie dei visceri e del cuore. Ero rimasto solo. Velocemente, precocemente il composto veleno dell’assenza occupava per intero ogni cellula e questo divenivano ogni notte arterie e vene: il sogno di un circuito al ciclotrone e l’incubo di un cadavere che si disfaceva, nel marmo di un monumento visitato in una gita scolastica, solo pochi anni prima. E ancora la colpa, sempre più forte, irredimibile.
Roma è una grande palude dove annegano nella prima luce del giorno i progetti e le ambizioni della notte. Da ciò, penso, viene quella sorda patina di cinismo che si affaccia dalle nostre espressioni e dalla cadenza secca dei nostri toni, quasi non ammettessimo replica, neppure alla più pesante delle ingiurie. Il nostro italiano è pesante come il travertino, e come il travertino è poroso, pieno di insenature e doppi sensi. A Roma si parla dietro le parole, tra le righe: proprio come in una poesia, verrebbe da dire. Chi è venuto da fuori, e sono ormai i più, dopo qualche tempo inevitabilmente si lascia assorbire e comincia, senza accorgersene, ad annaspare in questa strana melma pervasiva. Il potere non è passato da qui senza lasciare il suo odore, riconoscibilissimo, e la sua coda guizzante. Di quale specie, non importa: questa lingua con cui iniziavo a misurarmi è un muro, che solo il lento, pazientissimo scalfire di una penna può forare, e farlo un poco vacillare. Ce lo aveva chiarito, fino all’estremo, Pasolini, una delle prime Grandi Ombre e perciò la più distante. Da lui, e da un poeta vicino ai luoghi dov’era nato mio padre e dove ne avrei trovato un secondo, più vero, veniva in parte l’ombra che mi sarebbe stata accanto, per un tragitto brevissimo che avrebbe mutato ogni assetto della mia vita. Di Pasolini a Roma si è parlato sempre, come si recita la liturgia di un mito; Scotellaro, invece, era un nome relegato in poche righe dei manuali universitari e per molto tempo le sue poesie rimasero sugli scaffali delle biblioteche, come il ritratto di un santo minore sull’altare di una cappella secondaria, in quell’enorme chiesa senza pilastri in cui mi addentravo sempre più e dove, nella luce rarefatta delle navate, rischiavo di sperdermi. Ancora non so quale sia il momento più tragico, nella giornata romana: la commedia degli ideali notturni o il loro immancabile dissolversi nella verità del mattino.
«La notte era una splendida canna di giunco». Pochi dei versi in cui mi imbattevo in quel periodo di esplorazioni casuali mi avevano impressionato come questo, intravedevo una potenza squassante, michelangiolesca, dietro l’apparente dolcezza di una metafora: era uno di quei versi destinati a rimanere nella memoria e a riemergerne puntualmente, come un richiamo, come un monito. Mi ero ostinato a non voler leggere troppo su chi lo aveva scritto, per quanto si agitasse in me una curiosità ancora impastata di indiscrezioni romane, a fronte dell’ostentata, generale indifferenza: infatti il telefono riempiva le mattinate dei letterati e conduceva lungo il filo una conversazione fitta di notizie, le stesse che in pubblico venivano omesse con il dovuto distacco. Ciò che sapevo doveva bastarmi a confermare che quel verso, musicalmente flessuoso come l’immagine che evoca, nasceva piuttosto da un grande dolore, da un’assidua confidenza con il vuoto e con la morte. Ne rappresenta la sospensione, la conquista di quel momento di grazia che contiene in sé anche il suo improvviso, inevitabile svanire e pertanto lascia intuire la presenza dell’ombra, della fine. Così i pochi dati della sua avventurosa biografia congiuravano con l’invenzione, che più tardi scoprii molto diffusa, di un piccolo mito, nel quale l’antifascismo del padre e dello zio, la frequentazione di tre lingue, gli studi di musica e gli elettrochoc disegnavano una vicenda proiettata in un passato più remoto, libresco, dove incrociavo altri numi, gli stessi che lei portava sulle sue spalle: Campana, e forse, ancora più lontano, Hölderlin. Numi della follia, che come quel verso, con forza intermittente decidevano un destino, ne spostavano la frontiera, ora in un futuro ineffabile, ora in un passato dove il ricordo si posa sulle proprie rovine, con uno sguardo che non si colora del pathos affettato dell’archeologia, ma rivela un’angoscia mai sopita.
Mi accorgo di avere richiamato troppo spesso l’ambigua coloritura della città dove sono cresciuto, i suoi ostinati chiaroscuri, il suo intricato organismo di marmo, la sua imponenza e la sua supponenza; ma ciò che di davvero imponente si offre agli occhi dei romani, talmente avvezzi alla maestosità da non farci più caso e lasciarla volentieri ai turisti, non è mai stata la sacrale euforia delle facciate, quanto l’ampiezza dei tramonti, specie nella stagione delle giornate più brevi, che ancora mantengono un sentore dell’estate appena trascorsa. Sarebbe un errore credere che qui si respiri la storia, se ne avverta il passo; questa luce scopre soltanto la distruzione del tempo. Non la storia, dunque, ma i suoi resti, i suoi avanzi. Come sul volto di Amelia Rosselli, che pure era stato bello. Di quel volto avrei conosciuto gli ultimi anni, mi sarei scontrato con il suo declino inquieto, scoprendo nelle rughe che lo solcavano la stessa flessuosità del giunco, che lo faceva trascorrere dal sorriso (sempre appena accennato, tranne quando si apriva in una rara risata, di solito accompagnata da uno sbuffo) al rigore di un pensiero o al rapido passaggio di una visione per lei penosa e sempre meno sopportabile, nonostante la compagnia e l’affetto che la circondavano. Questa rapidità nel mutare le espressioni era tipica di Amelia e si manifestava soprattutto durante i suoi colloqui, sia che ci trovassimo da soli, sia insieme a qualche altro poeta amico o in qualche sovraffollata terrazza: situazione, quest’ultima, in cui lei prendeva a sedersi in disparte, come preoccupandosi di dare fastidio, di essere di troppo, aspettando che qualcuno conosciuto le parlasse o che il suo accompagnatore occasionale le porgesse quel che offriva il buffet. Eppure quel volto così mobile e già scavato, macchiato dal tempo, sfuggiva anche all’interlocutore più attento; ciò che colpiva in profondità non era la varietà delle espressioni, comunque limitata, quanto lo sguardo. Amelia aveva la capacità di fissare l’altro e insieme di dare la precisa impressione di guardare oltre, verso grandi distanze, o forse solo dentro la sua privatissima condanna. Era uno sguardo doppio, sì, ma proiettato in avanti, verso la figura che aveva di fronte e al di là di essa. Invitava a dilatare lo spazio fin che si poteva, ricordandoci che la poesia non ci tratteneva in quei luoghi, ma ci portava fuori. Invitava a cogliere, nel suo inferno, il lume di una nostalgia d’infinito.
E poi c’era la voce. Per i più che l’hanno incontrata, certamente è questo il tratto più memorabile. Ero stato attorniato da molte voci, ciascuna con la sua singolarità, ma quella di Amelia sapeva sovrastarle tutte. Le avevo sentite in privato o durante le letture, ne fissavo i modi e le cadenze per poi ripetermeli nel mio personale teatrino della poesia, quello che si agita quando la letteratura diventa orecchio, puro ascolto interiorizzato. Erano certamente diverse, da quelle più asciutte a quelle più cantilenanti, fino a quelle che somigliavano, nell’esecuzione dei versi, a un mantra continuo, a una preghiera laica. Da lì iniziavo a capire quanto una poesia stampata equivalga a una partitura muta, che attende lo strumento per il quale è stata scritta. La voce di Amelia Rosselli era esattamente lo strumento per il quale lei stessa scriveva, un organo che estendeva le sue gradazioni e i suoi filtri in profondità piuttosto che in superficie: un immenso organo seicentesco dove avrei potuto immaginare Pachelbel allestire le sue misuratissime, perfette geometrie tonali, fino al punto in cui l’allievo le avrebbe dilatate e fatte esplodere nella verticalità delle sue fughe. La voce di Amelia, a lungo, mi faceva pensare per diretta analogia proprio al suono prodotto dalle mani di Bach sopra la tastiera. E di fatto le sue predilezioni musicali, e i suoi studi sui contemporanei, si concentravano sull’eccezione piuttosto che sulla norma, anche se, in pieno Novecento, si sarebbe distinto a fatica cosa fosse l’una e cosa fosse l’altra. Quando parlavamo di poeti, infatti, il nome che ricorreva più spesso era quello di Penna. Citava anche Saba, pur non comprendendolo. E poi aveva attraversato, o meglio sfiorato come una tangente, come una cometa che trascina la sua propria luminosità, la breve stagione dell’avanguardia, ma quando le chiesi se poteva considerarsi un poeta sperimentale, mi rispose con il suo sbuffo, invitandomi a rileggere La libellula. Quella voce poetante non era paragonabile ad altro nel nostro recinto dei lirici; densa, anfibia, proprio come se fosse portata da un doppio respiro, così da reinventare, ad ogni emissione, i propri sensi. Coerente con il suo sguardo.
Quella voce affondava dunque in un futuro remoto. Sembrava che ad Amelia venisse meno la dimensione del presente: non che mancasse alla sua quotidianità, perché amava accompagnarsi volentieri agli amici e concedersi, quando le sue condizioni lo consentivano, qualche piccolo viaggio o una breve gita. Mi ritorna il quadro di un pomeriggio di aprile, nel caffè di piazza del Fico, con il poeta Camillo Pennati che da qualche tempo si era trasferito anche lui a Parione, e Amelia serena, conviviale ci intratteneva tra aneddoti e progetti. Ancora il passato e il futuro, anche se spogli di ogni alone drammatico, fissati nel correre dei giorni. Aveva preso la responsabilità, per la parte letteraria, dei quaderni pubblicati dalla galleria «La Tartaruga», dove avrebbe ospitato sia poesie di Camillo che alcune mie prove ancora acerbe e con estrema precisione ne calcolava la distribuzione nei fascicoli, pronosticando quando sarebbero potute apparire. Il presente di Amelia era Roma, ed era anche la solitudine, aggravata dalla latitanza della scrittura. Non c’era, nella sua percezione poetica, se è vero che Amelia è divenuta lei stessa, a un certo punto, la propria poesia, un sentimento del presente come dimensione transeunte e assoluta; non c’erano più esperienze da travasare su una pagina, a penna con la sua scrittura larga, infantile e poi al ritmo musicale della macchina. Il quotidiano fuggiva in ore che immaginavo silenziose, lasciando ancora spazio ai fantasmi. Negli ul...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Nuovi Argomenti (44)
- DIARIO - Arnaldo Colasanti
- CONCORDIA NAZIONALE
- SCRITTURE
- RIFLESSIONI SULLA LETTERATURA
- REPORTAGE - Maria Vittoria Smaldone - L’ ITACA CHE NON C’È
- Copyright