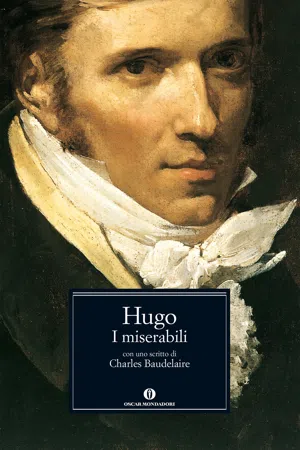![]()
![]()
I
Ben tagliato
Il 1831 e il 1832, i due anni che si riallacciano immediatamente alla rivoluzione di luglio, sono uno dei momenti più singolari e sorprendenti della storia, quasi due montagne tra quelli che li precedono e li seguono. Hanno in sé la grandezza rivoluzionaria e vi si discernono dei precipizi. Le masse sociali, le assise stesse della civiltà, il solido gruppo degli interessi sovrapposti e aderenti, i secolari profili dell’antica formazione francese vi appaiono e scompaiono a ogni istante attraverso i temporaleschi nuvoli dei sistemi, delle passioni e delle teorie: apparizioni e sparizioni che furono chiamate la resistenza e il movimento. A tratti vi si vede splendere la verità, questa luce dell’animo umano.
Questa età degna di nota è abbastanza circoscritta e già da noi sufficientemente lontana per poterne cogliere fin d’ora i tratti essenziali. Vogliamo provarci.
La restaurazione era stata una di quelle fasi intermedie, difficili a definirsi, un miscuglio di stanchezza, di brusio, di mormorii, di sonnolenza, di tumulto, che altro non sono se non il giungere a una tappa di una grande nazione. Momenti strani che ingannano i politici che intendono sfruttarli: dapprima la nazione non chiede che riposo, assetata di una sola cosa, la pace; di un’unica ambizione, essere piccola, cosa che equivale a starsene tranquilla. Di grandi avvenimenti, di grandi rischi, di grandi avventure, di grandi uomini, grazie a Dio, se ne sono visti abbastanza, se ne ha fin sopra i capelli. Si darebbe via Cesare per Prusia e Napoleone per il re d’Yvetot. “Che buon reuccio era mai quello!” In cammino dall’alba, il paese è giunto alla sera d’una lunga e dura giornata; ha fatto la prima tappa con Mirabeau, la seconda con Robespierre, la terza con Bonaparte; è sfiancato: tutti chiedono un letto.
Le dedizioni stanche, gli eroismi invecchiati, le ambizioni soddisfatte, le fortune acquisite cercano, reclamano, implorano, sollecitano, che cosa? Un asilo. Lo ottengono, prendono possesso della pace, della tranquillità, del riposo; eccoli contenti. Intanto al tempo stesso sorgono certi fatti che si fanno riconoscere e dal canto loro picchiano alla porta: essi provengono dalle rivoluzioni e dalle guerre, esistono, vivono, hanno diritto d’installarsi nella società e vi s’installano, e per lo più i fatti sono quartiermastri e furieri venuti soltanto a preparare l’alloggio ai princìpi.
Allora ecco quel che appare ai filosofi politici: mentre gli uomini affaticati chiedono tranquillità, i fatti compiuti chiedono garanzie, che per i fatti corrispondono alla tranquillità per gli uomini. Questo domandava l’Inghilterra agli Stuart dopo il Protettore, questo la Francia ai Borboni dopo l’Impero.
Queste garanzie sono una necessità dei tempi e bisogna pur accordarle: i prìncipi le “concedono”, ma in realtà le dona la forza dei fatti. Verità profonda e utile a conoscersi che gli Stuart non sospettarono nel 1660 e che i Borboni non intravidero neppure nel 1814.
La famiglia predestinata che ritornò in Francia dopo il crollo napoleonico ebbe la fatale ingenuità di credere d’esser lei a dare e di poter riprendere quanto aveva dato, che la casa di Borbone possedesse il diritto divino e la Francia nulla; e che il diritto politico concesso nella costituzione di Luigi XVIII non fosse altro che un ramo del diritto divino staccato dalla casa di Borbone e graziosamente regalato al popolo fino al giorno in cui al re piacesse di riprenderselo. Tuttavia dal dispiacere provato, la casa di Borbone, avrebbe dovuto capire che il dono non veniva da lei. Essa fu ringhiosa con il secolo diciannovesimo e fece brutta accoglienza a qualsiasi giubilo della nazione; per servirci d’una espressione triviale, ossia popolare e vera, essa storse il muso: il popolo se ne avvide.
Credette di esser forte perché l’impero le era scomparso dinnanzi come uno scenario di teatro e non si accorse che lei stessa era stata portata allo stesso modo; non capì d’esser anche lei strumento di quella mano che aveva tolto di lì Napoleone. Credette di avere radici perché era il passato, ma s’ingannava: essa faceva parte del passato, ma tutto il passato era la Francia, le radici della società francese non erano nei Borboni, ma nella nazione; radici vive e oscure che non costituivano il diritto d’una famiglia, ma la storia d’un popolo; esse erano dovunque, tranne che sul trono.
La casa di Borbone costituiva per la Francia il nodo illustre e sanguinoso della sua storia, ma non più l’elemento principale del suo destino e la base necessaria della sua politica. Si poteva fare a meno dei Borboni come se n’era fatto a meno per venticinque anni; c’era stata soluzione di continuità ed essi non lo sospettavano. E come lo avrebbero potuto, loro che si immaginavano che Luigi XVII regnasse il 9 Termidoro e Luigi XVIII il giorno di Marengo? Mai dall’origine della storia, i prìncipi erano stati così ciechi di fronte ai fatti e a quella parte di autorità divina che i fatti contengono e promulgano. Mai quella pretesa terrena che si chiama il diritto dei re aveva negato a tal punto il diritto supremo. Errore capitale che condusse questa famiglia a manomettere nuovamente garanzie “concesse” nel 1814, concessioni com’essa le chiamava. Triste cosa! Quel che chiamava le sue concessioni erano le nostre conquiste; quelle ch’essa chiamava le nostre usurpazioni erano i nostri diritti.
Quando le parve giunta l’ora, la restaurazione supponendosi vittoriosa di Bonaparte e radicata nel paese, cioè ritenendosi forte e profonda, prese improvvisamente la decisione e rischiò il colpo: un mattino si rizzò in faccia alla Francia e facendo la voce grossa, contestò il titolo collettivo e il titolo individuale, alla nazione la sovranità, al cittadino la libertà; in altri termini negò alla nazione quel che la faceva nazione e al cittadino quel che lo faceva cittadino.
Tale il fondo di quegli atti famosi chiamati le ordinanze di luglio.
La restaurazione cadde. Cadde giustamente, e tuttavia, diciamolo, non era stata completamente ostile a qualsiasi forma di progresso: con lei vicina grandi cose erano state compiute, sotto di lei la nazione s’era abituata alla discussione nella calma, cosa ch’era mancata alla repubblica, e alla grandezza nella pace, cosa ch’era mancata all’impero. La Francia libera e forte aveva offerto uno spettacolo incoraggiante agli altri popoli d’Europa. La rivoluzione aveva parlato sotto Robespierre, e sotto Bonaparte il cannone; sotto Luigi XVIII e Carlo X la parola toccò all’intelligenza; cessato il vento, si riaccese la fiaccola; sulle cime serene fu vista oscillare la pura luce del pensiero. Spettacolo magnifico, utile e affascinante. Per quindici anni si videro lavorare in piena pace, all’aperto, quei grandi princìpi così vecchi per il pensatore, così nuovi per l’uomo di stato: l’uguaglianza davanti alla legge, la libertà di coscienza, la libertà di parola, la libertà di stampa, l’accesso a qualsiasi ufficio di tutti gli individui capaci. La cosa andò fino al 1830. I Borboni furono uno strumento di civiltà che si ruppe nelle mani della provvidenza.
La caduta dei Borboni fu piena di grandiosità non da parte loro ma da parte della nazione; essi lasciarono il trono con dignità ma senza autorità; il loro tramonto nella notte non fu una di quelle scomparse solenni che lasciano alla storia una cupa emozione; non fu né la calma spettrale di Carlo I né il grido d’aquila di Napoleone. Se ne andarono, ecco tutto, deposero la corona senza conservare l’aureola, furono degni, ma non augusti. In certa misura mancarono alla maestà della loro sventura. Carlo X, che durante il viaggio di Cherbourg faceva trasformare un tavolo rotondo in uno quadrato, parve più preoccupato dell’etichetta pericolante che della monarchia in rovina. Tale diminuzione rattristò gli uomini devoti che ne amavano le persone e gli uomini seri che ne onoravano la stirpe. Il popolo, poi, fu ammirevole. La nazione, aggredita un mattino a mano armata da una specie d’insurrezione monarchica, si sentì tanto forte che non provò alcuna collera: si difese, si contenne, rimise le cose a posto, il governo nella legge, i Borboni in esilio, ahimè!, e si fermò. Tirò via il vecchio re Carlo X di sotto al baldacchino che aveva riparato Luigi XIV e lo collocò pian piano per terra; toccò le persone regali con tristezza e precauzione; non fu un uomo, non furono alcuni uomini, ma la Francia tutta, la Francia vittoriosa e inebriata della vittoria che parve ricordarsi e mise in pratica agli occhi del mondo intero le austere parole di Guillaume du Vair dopo la giornata delle barricate: «È facile per coloro che sono avvezzi a sfiorare il favore dei grandi e a saltellare come un uccello di ramo in ramo, da una fortuna avversa a una florida, mostrarsi arditi contro il loro principe nella sua sventura; ma per me la fortuna dei miei re sarà sempre degna di venerazione, specialmente afflitti».
I Borboni portarono con sé il rispetto ma non il rimpianto; come già accennammo, furono inferiori alla loro sciagura, scomparvero all’orizzonte.
La rivoluzione di luglio ebbe subito amici e nemici nel mondo intero: gli uni precipitarono verso di lei con entusiasmo e gioia, gli altri se ne allontanarono, ciascuno secondo la propria natura; al primo momento i prìncipi dell’Europa, gufi di quell’alba, chiusero gli occhi, stupiti e offesi e li riaprirono soltanto per minacciare: spavento comprensibile, collera scusabile. Questa strana rivoluzione era appena stata un urto, non aveva neanche fatto alla regalità vinta l’onore di trattarla da nemica e di versarne il sangue.
Agli occhi dei governi dispotici sempre interessati che la libertà si calunni da sola, la rivoluzione di luglio aveva il torto d’essere formidabile pur restando mansueta; d’altronde nulla fu tentato o ordito contro di lei. I più malcontenti, i più irritati, i più frementi la salutavano. Di qualunque specie siano i nostri egoismi e i nostri rancori, un misterioso rispetto emana dagli eventi nei quali si sente la collaborazione di qualcuno che opera al di sopra dell’uomo.
La rivoluzione di luglio è il trionfo del diritto che atterra il fatto, evento pieno di splendore. Il diritto che atterra il fatto, di qui il risalto della rivoluzione del 1830 e di qui anche la sua mitezza: il diritto che trionfa non ha bisogno di nessuna violenza. Il diritto è la giustizia e la verità.
È caratteristica del diritto restare eternamente bello e puro; il fatto, anche il più necessario in apparenza, anche il più accetto ai contemporanei, se non esiste che come fatto e se contiene troppo poco o niente diritto è immancabilmente destinato a diventare, con l’andar del tempo, deforme, immondo, fors’anche mostruoso. Se vogliamo subito constatare a qual grado di bruttura può giungere il fatto, visto a distanza di secoli, guardiamo Machiavelli. Machiavelli non è un cattivo genio, né un demone, né uno scrittore vile e miserabile, non è null’altro che il fatto; e non solo il fatto italiano, ma quello europeo, il fatto del sedicesimo secolo. Sembra ignobile, e lo è, di fronte all’idea morale del diciannovesimo secolo.
Questo conflitto tra il diritto e il fatto dura dall’origine della società: terminare il duello, fondere l’idea pura con la realtà umana, far penetrare pacificamente il diritto nel fatto e viceversa, ecco l’opera dei saggi.
II
Mal cucito
Ma altro è il lavoro dei savi, altro quello degli abili. La rivoluzione del 1830 si fermò presto.
Non appena una rivoluzione s’incaglia, gli abili ne mettono in pezzi i relitti. Nel nostro secolo gli abili si sono qualificati da soli uomini di stato, tanto che questo termine ha finito per diventare un po’ una parola di gergo. Non dimentichiamolo, là dove non c’è che abilità, vi è necessariamente meschinità. Dire gli abili equivale a dire i mediocri; così come dire gli uomini di stato equivale talvolta a dire i traditori.
A voler credere agli abili, le rivoluzioni come quella di luglio sono arterie tagliate; ci vuole una rapida legatura: il diritto, proclamato troppo apertamente, produce una scossa, per cui una volta che lo si è affermato, bisogna rafforzare lo stato; assicurata la libertà, bisogna pensare al potere. Qui i saggi non si separano ancora dagli abili, ma incominciano a diffidare: il potere, e sia, ma prima di tutto che cos’è il potere? E in secondo luogo: donde emana? Gli abili non sembrano udire l’obiezione sussurrata e continuano la loro manovra.
Secondo questi politici, ingegnosi a mettere alle finzioni profittevoli una maschera di necessità, il primo bisogno d’un popolo dopo una rivoluzione, quando questo popolo fa parte d’un continente monarchico, consiste nel procurarsi una dinastia; in tal modo, essi dicono, può avere la pace dopo la rivoluzione, cioè il tempo di medicarsi le piaghe e di ripararsi la casa: la dinastia cela l’impalcatura e copre l’ambulanza. Ora, non è sempre facile procurarsi una dinastia; a rigore, il primo uomo di genio o anche il primo fortunato che capita basta per fare un re; nel primo caso avete Bonaparte e nel secondo Iturbide. Ma non basta la prima famiglia qualsiasi a fare una dinastia, ogni razza contiene necessariamente una certa dose d’antichità e la ridda dei secoli non s’improvvisa.
Se ci si colloca dal punto di vista degli “uomini di stato”, con ogni riserva beninteso, quali sono le qualità di un re sorto da una rivoluzione? Può essere ed è utile che sia rivoluzionario, cioè partecipante di persona alla rivoluzione, che vi abbia messo mano, che vi si sia compromesso o reso illustre, che ne abbia toccato l’ascia o maneggiato la spada.
Quali sono le qualità d’una dinastia? Dev’essere nazionale, ossia rivoluzionaria a distanza non per gli atti commessi ma per le idee accettate, deve co...