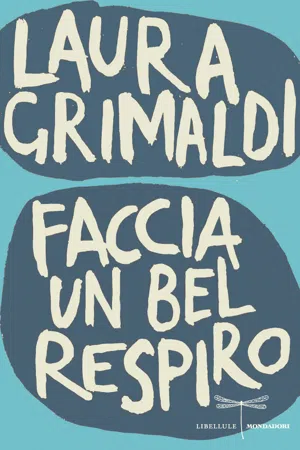![]()
6 di mattina.
Sei spiaccicata contro il materasso, sprofondata in una pozza di sudore. Si accende una luce che ti perfora le palpebre e ti si attorciglia intorno allo stomaco... deve essere dotata di tentacoli.
Deprivazione del sonno, riesci a biascicare mentalmente, terrorizzata. (Se vi sembra che non sia possibile biascicare mentalmente, sdraiatevi su una di quelle cose che chiamano letti e poi mi direte.)
Guantanamo. È il primo pensiero che ti incendia di paura il cervello.
Arricci una sola palpebra per spiare fuori e vedi una donna vestita di bianco...
Les blouses blanches, les blouses blanches... non, je ne suis pas folle! Pas folle!! Pas folle!!! Che ci fa Edith Piaf a Guantanamo?
La donna brandisce un termometro puntuto, elettronico, inattendibile. Te lo caccia nell’orecchio.
«35 e 2.»
È la tua temperatura. Unica informazione che ti è dato di avere, oltre a quella sulla pressione sanguigna.
«90 su 50.»
Per forza hai freddo.
Vuoi solo morire.
Il cuore è uno zingaro
Sei sopraffatta dalla sonnolenza, poi scivoli lentamente nel buio e non hai più consapevolezza di te. La chiamano ipossia, o coma carbonoso. Qualcuno fa arrivare l’ambulanza, che ti porta al pronto soccorso di un ospedale. Qui ti afferrano per i capelli, ti tirano su dalla fossa, sul cui bordo sei in equilibrio assai precario, e poi ti scaricano in uno stanzone con un lungo banco abitato da medici e infermiere. Puoi starci un paio di giorni oppure una decina, com’è capitato a te. Dipende da se e quando ti considerano fuori pericolo. O se si è liberato un posto altrove.
Quando arrivi al pronto soccorso (bollino rosso fuoco) sei ancora senza conoscenza, e così rimani per diverse ore. Ma non è che adesso che riemergi dal buio ti senti proprio lucida. Nel tuo cervello stanno succedendo cose. È pieno di ovatta e allo stesso tempo rigurgita di qualcosa di simile all’acqua quando bolle.
Hai la sensazione di essere sotto un cono di plastica, ma di sicuro sai che sei stesa su un lettino duro come ferro e angusto da contenerti a malapena. Ti sembra di intravvedere qualcuno e malgrado il fracasso che ti assorda gli chiedi notizie di te, alzando al massimo la voce. Quello risponde che non può sentirti, ma comunque ha già parlato con i tuoi familiari.
Vorresti tanto sapere che cosa ha detto ai tuoi familiari, e soprattutto dove sono, i tuoi familiari. Arrivi a concepire l’audace pensiero che forse non hanno accesso al posto dove sei tu e ti lasci scivolare ancora via, grata al nulla che ti accoglie.
Quando ti svegli di nuovo sei in uno stanzone con tende che fanno da divisorio fra i letti, ma rispetto a tutti gli stanzoni che conoscerai nelle tue future peregrinazioni ospedaliere è talmente atipico da meritare se non altro un distinguo: prima classe. Stanzone con tende di prima classe.
Ti guardi intorno: tre letti, uno accanto all’altro. In quello di mezzo ci sei tu.
Anche qui, come altrove, le tende sono di uno stinto color salmone, forse scelto da qualcuno che deve averlo ritenuto pacificante, oppure perché ne aveva una scorta in magazzino. Fatta salva l’eccezione di dove sei adesso, imparerai che sono tutte uguali anche se gli ospedali sono diversi, e tutte sbrindellate. Pendono da una stecca metallica orizzontale, e hanno regolarmente un paio di anelli che si sono staccati dal tessuto, e altri che fanno fatica a scorrere. Dovrebbero proteggere dalla visione dei vicini (molto vicini) di letto e invece, uomini o donne che siano, te ne offrono una panoramica che spesso arriva all’ombelico visto dall’interno. E viceversa tu a loro.
Con dentro da un minimo di tre a un massimo di cinque letti, gli stanzoni sono destinati a chi ha bisogno di cure e attenzione speciali perché è in condizioni critiche e dev’essere monitorato ventiquattr’ore su ventiquattro. Oppure solo perché non c’è ancora un letto libero in reparto (ma il paziente non lo sa, e a vedersi in mezzo a casi ritenuti gravi si dispera, credendosi in fin di vita).
Personalmente, so di esserci stata sempre messa a ragion veduta.
Il primo che ho conosciuto è stato lo stanzone di prima classe dell’UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica). Lindo, silenzioso, con i visitatori centellinati e paludati in camici, cuffia e galoches di una leggerissima plastica verdina molto spettacolare, ma anche molto fragile. Un mio amico alto un metro e novanta, e con spalle adeguate, pur avendo indossato con estrema attenzione e delicatezza camice e galoches, li ha ridotti in brandelli in pochi minuti.
L’UTIC ospita pazienti con problemi al cuore, tutti ugualmente terrorizzati (si sa, il cuore è uno zingaro che se ne va quando gli pare a lui), tutti domati dalla stessa paura, tutti bloccati dall’idea che un solo gesto, un solo gemito, potrebbe far scoppiare il prezioso organo. C’è poco da ridere, l’idea è proprio di deflagrazione.
Qui le tende scorrono quasi normalmente, non sono staccate dagli anelli e soprattutto nascondono dalla e alla visione del vicino di letto. Non sono mai riuscita a risolvere il mio dubbio sulla ragione di tutto questo: gli infermieri sono meno irruenti o il primario è un uomo d’ordine e di polso?
Sono capitata nell’UTIC per via di un infarto che mi è piovuto addosso nel corso di uno pneumotorace spontaneo (“pnx”, lo chiamano loro, per i quali tutte le patologie vanno rigorosamente in minuscolo, come per un indirizzo e-mail, mentre le terapie, gli esami e tutto ciò che riguarda l’ospedale va altrettanto rigorosamente in maiuscolo). Mi ci hanno portata con il rigido tubo del drenaggio che mi avevano inserito al PS (pronto soccorso) ancora cacciato nel polmone o limitrofi, per cui ho ricevuto estrema attenzione per l’infarto, e praticamente nulla per lo pneumotorace, che era stato la prima ragione del mio ricovero.
Per l’infarto, continui elettrocardiogrammi, presenza costante di un cardiologo/a al banco in fondo allo stanzone, infermieri e OSS (Operatori Socio Sanitari) pronti ad accorrere al primo pigolio della paziente. Per lo pneumotorace, solo qualche visitina scappa e fuggi di un giovane pneumologo, più che altro per vedere se il polmone spurgava ancora, facendo schiumare il liquido nauseabondo raccolto nel contenitore posato sul pavimento. L’ospedale era grande, con molti padiglioni, ma rispetto all’UTIC il reparto di pneumologia era direttamente al piano di sopra. Da lì spedivano il giovane medico nella cripta degli infartati.
Alla fine, quando sono stata dimessa (per fortuna senza drenaggio), la bolla del mio polmone che aveva provocato il pnx non si era ancora completamente risarcita e, guarda un po’, ho avuto una ricaduta e pure l’occasione – e la fortuna – di conoscere il reparto di chirurgia toracica dello stesso ospedale dove, a parte un inizio burrascoso, il mio secondo pneumotorace ha ricevuto tutta l’attenzione necessaria.
Sangue del mio sangue
Al primo pneumotorace il medico del PS che mi aveva dotata di un drenaggio (taglio di bisturi in alto sopra il seno, inserzione del tubo rigido giù fino a qualche anfratto del polmone o della pleura) mi aveva causato un dolore sopportabile, avendo credo usato un po’ di anestetico; nel reparto di chirurgia toracica, al contrario, il dolore è stato atroce. Per giunta, aggravato dal fatto che ero sotto la TAC, e quindi costretta a restare immobile. Non lo so per certo, ma credo che la TAC servisse a guidare il tubo nelle mie interiora.
Siccome sono convinta che se non si strilla non si è creduti, ho urlato come un’ossessa, con la speranza che se non altro per non sentire le mie strida avrebbero usato maggiore delicatezza. Invece no. Il dottore si è irritato e ha spinto più forte. Evidentemente trovava disdicevole che una vecchia signora nelle mie condizioni avesse ancora tanto fiato in corpo.
Nei giorni successivi il mio polmone ha continuato a fare i capricci, rifiutandosi di tornare a espandersi e continuando a far sobbollire il liquido dentro il contenitore, che per fortuna il bordo del letto nascondeva alla mia vista. La situazione sarebbe stata ritenuta normalizzata solo quando il liquido fosse rimasto immobile.
La mattina compariva il primario, medico bonario quanto saggio, e con lui i suoi collaboratori, rappresentati di solito dall’assistente e da due giovani medici (forse neospecializzati, forse specializzandi), tutti e quattro tallonati da due dottoresse altere che parlavano con il birignao della Milano bene, calzavano ballerine di marca e sotto il camice esibivano girocollo di cachemere. Era evidente che le due signore in questione si sentivano la reincarnazione di Cocomama.
Scrutavano tutti intensamente il liquido rivoltante del contenitore e poi il primario mi diceva qualche parola di incoraggiamento.
Dopo tre o quattro giorni mi è stato comunicato che dovevano introdurmi un secondo drenaggio. Questa volta ho affilato le armi, decisa a difendermi. Ho aggredito da subito il medico che presumibilmente avrebbe dovuto compiere il misfatto (lo stesso che mi aveva messo il drenaggio infischiandosene del mio dolore). Minacciandolo di svenimento al primo accenno di sofferenza, ricattandolo con l’infarto che avevo avuto e ricorrendo anche alle più meschine delle suppliche, ho ottenuto che il tubo mi scivolasse dentro senza quasi che lo sentissi. Il che mi dice che, volendo, Monsieur De Sade avrebbe potuto risparmiarmi la sofferenza anche la prima volta.
Malgrado il secondo drenaggio, però, il liquido del contenitore non ha smesso di schiumare, imperterrito.
Io, intanto, me ne stavo accucciata nel mio letto fra una giovanissima signora romena e una non più giovanissima signora bresciana, con le quali chiacchieravo ininterrottamente per tutta la giornata.
Loro avevano bisogno di parlare e io di ascoltare nuove voci.
Altri giorni, altra mattina.
Finito il primo giro di visite, il primario è tornato nella mia stanza. Dopo aver accennato all’irriducibile resistenza del mio polmone, mi ha chiesto se acconsentivo a farmi iniettare nel cavo pleurico il mio stesso sangue, sottintendendo che era l’unica alternativa possibile. Non riesco a ricordare se il metodo era usato solo o soprattutto negli Stati Uniti, o se era già stato usato qualche volta anche in Italia. Naturalmente ho acconsentito. Innanzitutto perché, avendomi spiegato con tutti i particolari in che cosa consisteva la faccenda, il primario, uomo dotato di una solida credibilità, mi aveva convinta che era indolore. E poi perché quello stesso primario aveva trapiantato entrambi i polmoni a un ventenne che adesso si allenava andando su e giù per le scale dell’ospedale. Per un chirurgo così, che sarebbe mai stata un’operazioncina come la mia?
Ovviamente non è stato lui a effettuarla, ma lo stesso medico che mi aveva messo i drenaggi. Ad assisterlo, le due Cocomama.
Fuori il sangue dal mio braccio, con un siringone che mi è parso enorme, dentro il sangue nel cavo pleurico attraverso uno dei due tubi del drenaggio.
Detto così, sembra semplice. E invece non lo è affatto. È stato veramente indolore, almeno fisicamente. Ma vedere il mio stesso sangue andare a raggiungere il mio corpo non più attraverso le vene, ma riversato come un bicchiere di pozione magica nel calderone della strega del drenaggio, mi ha mosso emozioni contrastanti. Ribrezzo, paura, esaltazione.
Il sangue non è bello da vedere, soprattutto il proprio, e comunque a me incute sempre timore. In quanto all’esaltazione, lo ammetto, ero fiera di me stessa per aver avuto la capacità di affrontare la bizzarra prova in piena solitudine. Chissà, se andava bene, con il mio assenso potevo aver partecipato a salvarmi la vita.
Quella notte, lo confesso, ho dormito poco. Ero preoccupata, ma pure, in qualc...