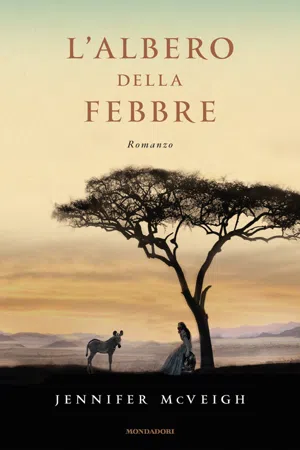![]()
Jennifer McVeigh
L’ALBERO DELLA FEBBRE
Traduzione di Teresa Albanese
![]()
Il primo segno che suo padre stava male era arrivato in giugno.
Frances si svegliò in piena notte e aprì gli occhi, tendendo l’orecchio. La casa restò muta per un istante, poi lasciò filtrare un mormorio dal piano di sotto. Lei prese uno scialle dal letto e aprì la porta.
«Lotta?» chiamò. Vi fu un attimo di silenzio, poi l’ondeggiare scricchiolante della mole di Lotta sulle scale e il guizzo di una candela. Frances scorse una camicia da notte bianca, e quindi apparve il volto largo e placido della cameriera.
«È vostro padre, signorina. È tornato, ma non sta molto bene» rispose Lotta, passando accanto a Frances ed entrando nella sua stanza da letto.
«Cosa vuoi dire?»
Lotta si chinò ad accendere la candela sul comodino. Il suo petto si alzava e abbassava come un mantice, e il fiato faceva tremolare la fiamma.
«Cosa è successo?» chiese Frances, afferrandole il polso.
La cera bollente schizzò sulle mani di Lotta, che indietreggiò con una smorfia di dolore. «Non lo so di preciso. Un cocchiere l’ha portato a casa, dicendo che aveva avuto un collasso.»
Frances si sforzò di immaginare la scena. Suo padre, con quel fisico possente, non sembrava il tipo da avere un collasso. Era un uomo forte, da tutti i punti di vista. Il garzone di bottega che aveva creato un impero dell’arredamento partendo da pochi spiccioli, come i prestigiatori che estraggono banconote dalle tasche dei poveracci.
Frances prese la candela di Lotta e scese al pianterreno, calpestando a piedi scalzi le piastrelle a scacchi del corridoio. Suo padre era nello studio, seduto in poltrona accanto al focolare spento. Aveva la camicia sbottonata e un’ispida barba iniziava a coprire i solchi profondi che gli rigavano le guance. Appariva pallido sullo sfondo dei muri verdi e del lucente mobilio di palissandro, ma alla vista della figlia il suo volto si aprì in un sorriso affettuoso. Era esausto, pensò lei sollevata, ma stava bene. L’uomo reggeva con dita malferme un bicchiere di brandy che minacciava di rovesciarsi sul tappeto. Aveva il torace scoperto, e lei vide che il suo corpo era più snello e compatto di quanto ricordasse, come se l’età lo avesse rimpicciolito. Da bambina aveva ammirato la sua forza bruta, la potenza delle sue mani che la sollevavano sulle ginocchia.
«Ah, Frances, avevo detto a Lotta di non svegliarti» disse, tendendo una mano verso di lei per scusarsi del fatto che non poteva alzarsi. Lei la afferrò con un sorriso e si chinò a baciarlo. Era stato via per affari, e riaverlo a casa era una gioia.
«Quando sei tornato? Stai male?»
«No, è solo un po’ di stanchezza.»
In quel momento, a Frances venne il dubbio che suo padre se la fosse andata a cercare. «Hai bevuto?»
Lui rise, un suono profondo e pastoso che lenì le paure di Frances e la fece sorridere suo malgrado, poi spostò gli occhi sulla poltrona di fronte. «Lo vedi, Matthews, quanto è sveglia la mia figliola?»
Frances si voltò. Non aveva visto l’uomo seduto nella poltrona alle sue spalle, sull’altro lato del focolare. Aveva un volto glabro e spigoloso, con la fronte alta e capelli bruni unti e tagliati corti. Le ci volle qualche istante per riconoscerlo, ma quando lui si alzò per venirle incontro, si ricordò: «Signor Matthews».
«Ormai lo devi chiamare dottor Matthews» disse il padre.
«Certo.» Era un cugino da parte di padre che da ragazzo aveva abitato per qualche mese in casa loro. Aveva la stessa espressione compunta che lei ricordava. «Dov’è il dottor Firth?»
«Il dottor Firth è fuori città» disse Edwin Matthews nel suo tono compassato. Anche a sedici anni, aveva quell’aria da maestrino.
Frances era accanto alla poltrona del padre, con la schiena rivolta al focolare e i piedi che sfioravano il bordo del tappeto. Lo scuro legno di quercia del pavimento le pungeva le piante dei piedi, e strisciò l’alluce sulla liscia capocchia di un chiodo. Era vestita in modo inappropriato e rabbrividì. Faceva troppo freddo per stare nello studio in camicia da notte. Aveva l’impressione di avere interrotto una conversazione privata, e il silenzio dei due uomini sembrava un invito a congedarsi. Forse avrebbe dovuto essere grata a Edwin Matthews per essere venuto a visitare suo padre nel cuore della notte, ma si sentiva solo frustrata. Era tanto tempo che non vedeva suo padre, e avrebbe voluto parlargli con calma, cioè a quattr’occhi.
«Bene, ora che sei tornato» gli disse «baderemo noi alla tua salute.»
«Frances, sto benissimo.» Il padre scrollò la mano con improvvisa impazienza. «Torna a letto. Sto lavorando troppo, ecco tutto, e ho chiamato il dottore perché mi dia qualcosa per dormire.»
Lei lo guardò per un altro istante. Il padre alzò il bicchiere come per dire “ti sei preoccupata fin troppo, lasciami tranquillo”, ma mentre se lo portava alle labbra, la sua mano tremò. Non aveva accennato al fatto di aver avuto un collasso. Forse Lotta aveva esagerato. In ogni caso, era inutile approfondire la questione, almeno per il momento. Si chinò per baciarlo di nuovo e andò di sopra.
Si fermò sul pianerottolo davanti alla stanza di suo padre, dove Lotta stava preparando il letto. «Vorrei scambiare due parole con il dottore dopo che mio padre si è coricato. Ti spiace chiedergli di aspettare?»
La finestra della sua stanza da letto splendeva diafana e fredda dietro le tende. Frances prese lo scialle dalla poltrona, scostò la stoffa damascata e guardò la strada di sotto. Aveva smesso di piovere e regnava il silenzio. Era troppo presto per i garzoni della macelleria in grembiule azzurro. Il lampione in fondo alla via spandeva uno smorto bagliore giallognolo attraverso la foschia biancastra. Il lampionaio sbucò dalla tenebra lucente, appoggiò la scala al palo e spense l’alimentazione. La fiamma si ridusse a una palla arancione, sfarfallò e si spense. L’uomo si fermò un attimo, con una mano sul palo, e guardò la strada dietro le sue spalle, come se aspettasse di vedere la città svegliarsi e scrollarsi dal sonno.
La cera della candela le aveva formato una pellicola liscia e dura sul dorso della mano. Quando la piegò, la patina si ruppe e cadde in schegge sul tappeto. Frances si passò le dita sulla pelle bruciata, fino al morbido incavo del polso. Il suo cuore batteva veloce e irrequieto, riecheggiando il tonfo sordo che le pulsava nello stomaco. E se suo padre si fosse ammalato? Quella paura l’aveva tenuta sveglia da bambina, quando la voce tonante e la calma del genitore erano l’unica cosa che spezzava il buio e il silenzio della casa dopo la morte di sua madre.
Un istante più tardi, richiuse le tende e accese la lampada sulla toeletta, illuminando un assortimento di pettini e spazzole, flaconcini di profumo, oli aromatici e scatole di cipria. Si spazzolò i capelli fino a renderli una massa crepitante e incandescente di riccioli color rame, poi li addomesticò con acqua di lavanda e li raccolse in una lunga treccia. Il suo riflesso la fissava dal piccolo specchio sul tavolo. A diciannove anni, sentiva che la sua vita avrebbe dovuto essere piena di possibilità, invece le sembrava di soffocare. Scosse appena il capo accarezzandosi la treccia e vide nello specchio le due bambole di porcellana che il padre le aveva regalato da bambina, sedute su una sedia accanto al letto. La guardavano con i loro occhi vitrei, le mute labbra socchiuse.
Vi fu un colpo alla porta. «Il dottore vi aspetta di sotto, signorina.»
Si era spostato nel soggiorno al pianterreno, e Frances lo trovò in piedi davanti alla finestra con il cappello già tra le mani, pronto a uscire.
«Come sta mio padre?»
«Dorme.» Il giovane fece qualche passo verso di lei. «Ero ansioso di rivedervi, signorina Irvine, anche se mi auguravo che capitasse in circostanze più felici». Il suo fervore la sconcertò e le parve minaccioso senza che sapesse spiegarne il perché. Notò che gli occhi del dottore erano molto chiari, quasi grigi nella fioca luce che illuminava il vetro verde della finestra sul giardino. Erano svegli e attenti, e molto luminosi: senza quegli occhi, il suo volto sarebbe sembrato una maschera. Non era un bell’uomo, forse aveva un’aria troppo grave per esserlo, ma aveva un’espressione penetrante, che attirava l’attenzione.
«Dovrei preoccuparmi?» gli chiese, e dato che lui non rispondeva: «Dottor Matthews, dovete dirmelo. Mio padre ha qualcosa di grave?».
Il dottore rimase immobile, come un’ombra contro la luce della finestra, le dita appoggiate sulla scrivania. In lui c’era qualcosa di glaciale. Quando la luce illuminò i contorni del suo viso, Frances notò che aveva la pelle spenta e tirata. Doveva aver passato la notte in bianco. Lui si inumidì le labbra con la punta della lingua. «Penso che soffra di esaurimento nervoso.»
«Esaurimento nervoso?» chiese lei con una risatina. «È certo che non sia nient’altro?»
Lui non rispose.
«Temo che non conosciate mio padre, dottor Matthews. Non è un tipo dai nervi fragili.»
«È spesso così, in questi casi.»
«E, secondo il vostro parere professionale, cosa avrebbe provocato questo esaurimento?»
«Signorina Irvine, adesso dovreste riposare.» Le sfiorò l’avambraccio. «Non avete motivo di preoccuparvi.»
Lei rabbrividì e si scansò. Forse il gesto del medico era dovuto a uno scrupolo professionale, ma sembrava sottintendere un’intimità fra loro. Rimpianse di non essersi vestita, prima di scendere. «Vi ringrazio, ma non sono stanca.»
Poi, dopo un momento, disse: «Dottor Matthews, ciò che riguarda mio padre riguarda anche me».
«Sospetto che non potrei dirvi niente di lui che già non sappiate.»
Qualsiasi cosa Edwin Matthews intendesse, non era proprio vero. Lei sapeva ben poco della vita di suo padre fuori da quella casa.
«Gradirei sapere se vi ha detto qualcosa.»
«Io e vostro padre abbiamo parlato, è vero, ma soprattutto delle miniere di Kimberley.»
«Ha investito nel carbone?»
«No!» rispose lui con una risatina. «Si tratta di miniere di diamanti, e non ha parlato di investire. Kimberley si trova in Sudafrica. Io vivo al Capo.»
Lei arrossì. Certo, Kimberley era la famosa città dei diamanti.
«Chi ha dipinto questi?» Edwin sollevò gli acquerelli raffiguranti le rose di suo padre, che erano sparsi sulla scrivania.
«Io.» Il brutto tempo l’aveva costretta a stare in casa e aveva passato buona parte delle ultime due settimane in soggiorno, a dipingere. Poche persone erano venute a farle visita, e le giornate erano state scandite dai colpetti del pennello quando lo puliva nella vaschetta e dalle voci smorzate dei commercianti che arrivavano dalla cucina di sotto.
«Sono molto graziosi.» Lui la guardò con interesse, come se stesse correggendo qualche valutazione a suo favore, e lei provò un antico fastidio. Era la stessa arroganza che aveva da bambino, quando era sempre pronto a giudicare il mondo con il suo metro personale.
«Avete studiato pittura?» chiese lui.
«Un po’.» Frances si strinse nelle spalle. «Ma sempre ritratti. Io preferisco dipingere le piante.» Frances amava il compito meticoloso di trasferire sul foglio ogni dettaglio: le venature, la peluria e le variazioni di colore che a molti occhi sfuggivano. Il dipinto era sempre un compromesso. Assomigliava ben poco alla cosa dipinta, ma la sua differenza – segno dello sforzo della rappresentazione – era anche la sua bellezza. Indicò i boccioli tagliati in un vaso sul tavolo. «Le rose di mio padre. Sono belle, non trovate?»
«Forse, ma non ho mai amato le piante domestiche. C’è qualcosa di stucchevole nella loro grazia.» Fece una pausa. «Sembrano fin troppo decorative.»
«Ma sono comunque splendide.»
«Non posso ammirare lo splendore se il suo prezzo è la sterilità.» Indicò gli acquerelli. «Queste rose sono frutto delle talee perché non riescono a propagarsi, oppure sono innestate sulle radici più robuste di altre piante che le aiutano a sopravvivere. Devono essere nutrite da un giardiniere attento in un ambiente perfettamente controllato. Mostruosità, così le ha chiamate Darwin. Deviazioni dalla loro genuina forma naturale.»
«E se uno le lasciasse crescere liberamente?» chiese lei, incuriosita.
«Morirebbero, oppure dovrebbero tornare al loro ceppo originario.» Edwin Matthews posò i quadretti e disse: «Ora è meglio che vi lasci riposare». Mentre si avviava verso la porta, lei lo fermò. Non voleva che se ne andasse senza darle una spiegazione.
«Non riesco a capire come sia potuto succedere» insistette. «Non ho mai visto mio padre sotto pressione. Lui non ha paura di nulla.»
«Tutti abbiamo paura di qualcosa, signorina Irvine» disse lui con calma, fissandola con il suo sguardo freddo. «Solo che alcuni sono più bravi a nasconderlo.»
Le parole del dottore instillarono dentro di lei un seme di apprensione. Quando se ne andò, sentì che quel seme germogliava, avvolgendole le costole con freddi tralci, e lasciò che una tristezza straziante si insinuasse tra le pieghe della sua stanchezza.
![]()
Quando i genitori di Frances si erano sposati, suo padre si era sforzato di vivere nel modo più decoroso possibile. Avevano un villino a St John’s Wood, senza carrozza e con una cameriera che faceva gli straordinari per impedire che la casa fosse sottosopra. Per il sesto compleanno di Frances, suo padre affittò una carrozza. Era una giornata limpida, le strade luccicavano della pioggia della sera prima, e loro sfrecciarono lungo i grandi spazi aperti di Kensington, superando strade costruite a metà e campi ridotti a fanghiglia dalle ruote dei carri degli operai, rivendite di legname, pile di rifiuti e fornaci di mattoni che spandevano l’odore caldo e soffocante di un forno per il pane. Ovunque risuonavano i rumori della costruzione, le urla degli operai e lo sbattere dei secchi issati sui ponteggi. Sua madre doveva già essere malata, perché Frances ricordava che il suo entusiasmo era smorzato dalla preoccupazione per il colorito pallido e gli occhi gonfi della donna, che si chiudevano ogniqualvolta la carrozza sobbalzava sulla strada piena di buche.
Si erano fermati davanti a una villa enorme e piena di stucchi e suo padre l’aveva presentata a un irlandese basso e corpulento con un largo sorriso e il suo stesso accento leggermente gutturale. “Kerrick, dovrai fare qualsiasi cosa Frances ti chieda.” E Kerrick l’aveva presentata ai due cavalli, che le avevano mordicchiato le dita con il muso morbido e peloso e soffiato tra i capelli il loro fiato caldo. Quando lei aveva chiesto di chi fosse quella villa, suo padre era scoppiato a ridere e aveva detto che era la loro nuova casa.
Otto mesi dopo sua madre era morta, e la villa che era sembrata una promessa di felicità era diventata un luogo di lutto e rimpianto. Frances immaginava che suo padre fosse distrutto dal dolore, ma non ne aveva la certezza. Dopo il funerale, lui non aveva più parlato della morte della moglie, e anche se c’erano cose che Frances avrebbe voluto sapere – perché i polmoni di sua madre si erano ammalati, se aveva sofferto –, non aveva il coraggio di chiederle. Per ordine del padre, ogni traccia di sua madre fu rimossa. Gli armadi furono svuotati, le fotografie staccate dalle pareti e il soggiorno sgombrato dalle sue lettere e diari. La lunga sala da pranzo, in cui Frances aveva immaginato donne eleganti passeggiare davanti agli specchi dorati, fu chiusa. Suo padre lavorava sodo e non passava molto tempo in casa. La sua vita ruotava attorno agli affari, e nelle rare occasioni in cui portava degli ospiti a casa, erano clienti che si sedevano con lui nello studio, per fumare e discutere a porte chiuse.
Un precettore veniva ogni mattina a insegnarle la matematica, la geografia e i rudimenti del latino. Fu lui a introdurla all’acquerello e a insegnarle le basi della pittura, e lei consumò intere risme di carta prima di imparare che, con i colori, è tutta una questione di delicatezza. La balia di Frances passava interminabili pomeriggi nella stanza dei ...